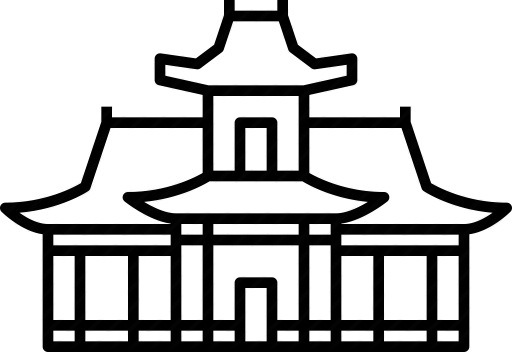Dal 18 febbraio al 27 aprile il Museo Diocesano di Milano ospita Emergenza climatica, un viaggio ai confini del mondo, la mostra di Alessandro Grassani, a cura di Denis Curti. Con questa esposizione il fotografo si sofferma su una conseguenza poco conosciuta del riscaldamento globale che sta investendo sempre più inesorabilmente il nostro pianeta: la migrazione ambientale. Grassani, che lavora sul campo da molto tempo, ha viaggiato in Kenya, Bangladesh, Mongolia e Haiti per raccontare come, con differenti climi e contesti geografici, molti abitanti di questi Paesi, siano costretti a migrare dalle campagne verso la città per trovare nuove forme di sostentamento. Il fotografo offre una nuova interpretazione dell’immaginario climatico, cogliendo volti e storie di vita e umanizzando una tematica la cui estetica è spesso molto uniforme, incentrata unicamente sulla natura e sul territorio.
Dal 18 febbraio il Museo Diocesano di Milano ospiterà la tua mostra Emergenza climatica. Un viaggio ai confini del mondo. Ce la racconti?
La mostra al Museo Diocesano esporrà una serie di immagini relative al problema dei cambiamenti climatici e più specificamente ai flussi migratori indotti dai cambiamenti climatici. È un lavoro a cui sto ancora lavorando, per ora mi sono concentrato su quattro Paesi (il Kenya, il Bangladesh, la Mongolia e Haiti) con l’intento di raccontare la tematica con uno sguardo globale. I contesti su cui mi focalizzo sono l’ambiente rurale e quello urbano, perché solitamente le migrazioni avvengono dalle campagne alle città.
Perché hai scelto questi quattro Paesi?
Per descrivere quattro contesti geografici e climi differenti: l’estremo freddo della Mongolia, la siccità in Kenya, l’innalzamento del livello del mare in Bangladesh, i cicloni e gli uragani ad Haiti.
Chi sono le persone che fotografi?
Sono pastori, allevatori, contadini e pescatori che, con le loro famiglie, abbandonano il luogo in cui sono nati, per migrare verso i centri urbani. Queste persone pensano alla città come a un luogo in cui vivere una vita migliore, ma si ritrovano comunque a vivere in miseria e il loro sogno viene inesorabilmente infranto.
Infatti, il lavoro da cui nasce la mostra si intitola The Last Illusion. Quando e come nasce l’idea di questo progetto?
Nasce una dozzina di anni fa, durante il mio primo viaggio in Mongolia. Al tempo stavo già indagando il tema dei cambiamenti climatici e la Mongolia mi dava l’opportunità, con il suo inverno estremamente rigido, di pensare ad una narrazione anticonvenzionale. Nel senso che solitamente quando si parla di cambiamenti climatici e di riscaldamento globale si immagina un innalzamento generalizzato delle temperature, ma le cose non vanno così dappertutto e la Mongolia mi dava la possibilità di rendere visibile questa distinzione.The Last Illusion è iniziato, quindi, con una riflessione sul concetto di immaginario relativo al riscaldamento globale, non solo come indagine sul territorio. Inoltre, ero andato in Mongolia anche perché quell’anno, secondo i dati delle Nazioni Unite, erano morti otto milioni di capi di bestiame durante l’inverno e ventimila pastori erano stati costretti ad abbandonare la loro vita nomade, per rifugiarsi nella capitale, Ulan Bator. In un certo senso, sono andato alla ricerca di quelle ventimila persone nella città in cui avevano sperato di trovare migliori condizioni di vita, cercando di dare loro un volto. Tutto il progetto ha l’intenzione di mostrare fisicamente chi sono i migranti ambientali, coloro che si ritrovano a dover migrare a causa dei cambiamenti climatici.
Quindi l’idea di estendere questa tua ricerca anche agli altri tre successivi capitoli ha preso forma durante il tuo viaggio in Mongolia?
Sì, l’idea di una progettualità a lungo termine e che comprendesse altri territori è nata durante quel primo viaggio. Mentre ero in Mongolia mi sono messo in contatto con un’agenzia delle Nazioni Unite e altre ONG, che mi hanno poi seguito nel progetto, e dalla Mongolia mi sono spostato verso il Bangladesh.
Nella tua narrazione non ti concentri sulla rappresentazione del viaggio di queste persone, ma unicamente sulla loro situazione di partenza nelle campagne o su quella di arrivo nelle città. Quello che manifesta il cambiamento ambientale è quindi il paesaggio dietro di loro…
Parlando di migranti ambientali non esistono delle specifiche rotte migratorie, come ho raccontato, invece, in un mio precedente progetto, attraverso il quale ho seguito i migranti che dal Guatemala arrivano negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i migranti ambientali l’idea del viaggio è molto più soggettiva. Dovrei aspettare che una famiglia decida di spostarsi verso la città, non c’è una tratta definita. Dal punto di vista del paesaggio che ho voluto rappresentare, ho realizzato due contesti visivi in parallelo, la campagna e le baraccopoli della città, che si rendono scenario di partenza e di arrivo.Quello che avviene in mezzo, il viaggio del migrante, non era mio interesse coglierlo. La cosa più importante, che voglio che emerga dal lavoro, sono i volti dei migranti ambientali. Volevo dare un volto a dei dati statistici, a delle storie che altrimenti non sarebbero mai raccontate, ad un tema, quello dei cambiamenti climatici, che altrimenti rimarrebbe focalizzato molto sull’ambiente e sulla natura e non abbastanza sulle persone che soccombono a tale problema. Le Nazioni Unite stesse si sono interessate al mio lavoro proprio perché era in linea con il loro progetto di umanizzare la questione dei cambiamenti climatici.
C’è qualche storia specifica che vorresti condividere con noi?
Parlando del viaggio fatto in Mongolia, ricordo la storia di Ganbaatar Damdisuren, un pastore che aveva abbandonato da un anno e mezzo la campagna perché circa centocinquanta delle sue pecore erano morte per la fame. Aveva, così, deciso di cercare fortuna in città, con al seguito la sua tenda, unico bene rimasto. Cercando un modo alternativo di vita nel contesto urbano, ha comprato una macchina per usarla come taxi, ma dopo una settimana, con un incidente automobilistico, è rimasto paralizzato.Racconto questa storia per fare capire come la necessità di trovare a tutti i costi nuove forme di sostentamento, in contesti distanti dalle proprie abitudini, porti i migranti ambientali a degli epiloghi drammatici.
Con lui impossibilitato a lavorare, la moglie aveva trovato impiego in una discarica dove differenziava i materiali, per scoprire poi di avere un cancro. La loro è una storia tragica, ma non è la sola con cui sono venuto in contatto.
di Francesca Orsi fotocult.it
La mostra
Alessandro Grassani. Emergenza climatica. Un viaggio ai confini del mondo
A cura di Denis Curti
Museo Diocesano, piazza Sant’Eustorgio, 3 – Milano
dal 18 febbraio al 27 aprile 2025
mar-dom 10-18
intero 9 euro, ridotto 7 euro
chiostrisanteustorgio.it