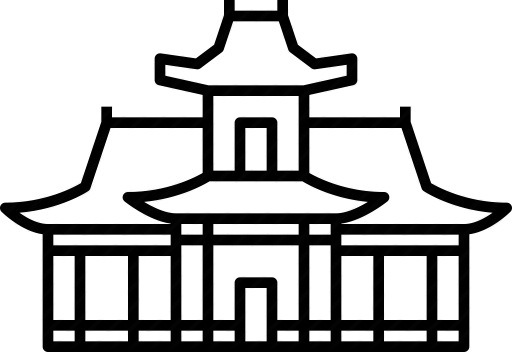Per millenni i pastori nomadi mongoli hanno vagato attraverso territori agresti seguendo le stagioni. Aree asciutte e ventose nei pressi di un fiume durante l’estate, aree non ventilate, lontane da corsi d’acqua e riparate da montagne o colline in inverno.
In un Paese dove i pascoli sono sempre stati, e ancora sono, un bene pubblico, i pastori potevano spostarsi liberamente verso i luoghi migliori. In uno stile di vita di libera transumanza fu creata la dimora nazionale chiamata “mongol gher”, la yurta mongola.
È una struttura rotonda composta da pareti facilmente smontabili, aste e un soffitto sferico coperto di teli e feltro, tenuti stretti da corde. La gher fu concepita in modo da essere abbastanza leggera per il trasporto, flessibile per essere ripiegata facilmente e caricata sui carri, resistente ai numerosi montaggi e smontaggi e con un pratico sistema per regolare la temperatura interna. Nel corso dei secoli la gher mongola fu trasformata in una perfetta struttura aerodinamica in grado di affrontare gli impetuosi venti primaverili che spirano a 18-20 metri al secondo. Può essere smontata in mezz’ora e montata in un’ora, da una piccola famiglia con 2-3 adulti. Esistono molti tipi di gher. La più comune è quella a 5 lati, costituita da altrettanti graticci in legno che formano una parete circolare, una porta, un toono (finestra rotonda del soffitto), due bagana (pali che sorreggono il toono) e 88 uni (lunghe aste che congiungono le pareti al toono formando il tetto della gher). Per realizzare una gher servono diversi artigiani specializzati: chi si occupa delle parti in legno, chi delle pitture e di incisioni ornamentali di mobili e strutture, altri ancora sono esperti nel tagliare, cucire e comporre teli di copertura, tende e materiali adatti al pavimento. Il lavoro più importante è quello relativo al legno, che viene assemblato con metodi e tecniche tradizionali particolarmente impegnativi. Ma la realizzazione dei graticci in legno per la parete circolare è la parte più delicata: l’artigiano seleziona i legni con cura, utilizzando l’acqua e il calore del fuoco per garantire la giusta flessibilità con le migliori qualità di cuoio e grasso animale per tenere insieme la struttura. Tradizionalmente l’artigiano (o artigiana) di gher è anche pastore e, nel momento in cui viene chiamato a costruire una yurta, chiede a un vicino o a un membro della famiglia di prendersi temporaneamente cura dei suoi animali. Insomma un artigiano non abbandona il suo stile di vita da pastore nomade.
Il periodo di lavoro più intenso è l’estate, prima del più popolare periodo matrimoniale, l’autunno. La tradizione dell’artigianato mongolo della gher si è evoluta lentamente e le sue caratteristiche sono le stesse in tutto il Paese. Tali caratteristiche includono: strutture in legno dipinte e abbellite con i tradizionali ornamenti mongoli; coperture con teli e feltri bianchi; corde di crini animali; pavimenti e tappeti di feltro cuciti a mano; infine i mobili disposti secondo tradizione, come la cucina che deve stare sul lato sud-est, eccetera. Piccole diversità nella lavorazione possono esistere per tradizioni locali o eredità culturali dell’artigiano.
Il modo migliore con cui le nuove generazioni possono imparare questa arte è attraverso l’insegnamento di un artigiano esperto. Montaggio e smontaggio sono invece attività che si imparano da bambini, guardando e aiutando gli adulti. Tosatura delle pecore, battitura della lana, lavorazione del feltro, fabbricazione delle corde, cucitura dei teli e lavorazione del legno sono lavori a cui, nella cultura nomade, partecipano tutti i vicini. Bambini e giovani sono invogliati ad apprendere la realizzazione di una gher e i più dotati lavorano con un artigiano per un certo periodo. Gli anziani hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel mantenere vive le tradizioni legate alla gher, che purtroppo si stanno affievolendo a causa dell’urbanizzazione sempre maggiore. Come dimora tradizionale la gher mongola ha un importante ruolo sociale e culturale per le famiglie nomadi. In campagna e nei sum centrali, ma non nelle città, una gher è un regalo doveroso da destinare ai novelli sposi. Il suo utilizzo è in continua crescita anche nell’ambito dei campi turistici e come alloggio per minatori. Gli artigiani che sanno costruire gher secondo la tradizione sono considerati una risorsa rara e preziosa e sono altamente rispettati nella comunità: a loro vengono donati khadag (i foulard di seta blu, simbolo religioso di rispetto) e soldi nel richiedere la costruzione di una nuova yurta. Poveri o ricchi, tutti i nomadi usano la gher mongola per fronteggiare due aspre difficoltà: gli zud (inverni particolarmente rigidi) e i gan (estati particolarmente secche). In entrambi i casi i pastori devono spostarsi verso luoghi insoliti per trovare un pascolo per gli animali. Anche se per una dolente ragione, gli artigiani di gher acquisiscono una reputazione ancora più alta in occasione di queste situazioni drammatiche. La gher mongola è anche una struttura ecologicamente perfetta: infatti è costituita da un unico ambiente che necessita di una modesta quantità di combustibile per il riscaldamento. Si è anche rivelata come una dimora molto flessibile ad adattarsi alle moderne tecnologie ecosostenibili. Migliaia di famiglie nomadi utilizzano energia solare ed eolica nelle loro gher e i pastori possono seguire la televisione grazie a queste tecnologie. Gli ingegneri progettano, per le gher mongole, sistemi di riscaldamento, teli di copertura isolanti e pavimenti termici a elettricità, senza stravolgere l’artigianato tradizionale. Le migliori gher tradizionali sono considerate quelle fabbricate nella regione dell’Övörkhangai. La tradizione impone che, quando ci si sposta con una gher, non si lascino buche o rifiuti in modo che l’erba possa ricrescere liberamente e velocemente. Ciò significa che è sempre esistita tradizionalmente una consuetudine ecologica tramandata di generazione in generazione. Oltre che in Mongolia l’uso e l’artigianato della gher è diffuso, con caratteristiche peculiari, in altre regioni dell’Asia quali il Qinghai e aree mongoliche della Cina, regioni buriate e calmucche della Russia, Kirghizistan e Kazakistan.
testo di Tsedevdambyn Oyungerel (da Монголоо таниулъя), fotografie di Federico Pistone
La parola Naadam significa “giochi” ma la denominazione completa è Eriin Gurvan Naadam, “i tre giochi degli uomini”: si confrontano infatti lottatori, cavalieri e arcieri in una giostra senza tempo.
I mongoli si battono in queste tre specialità da sempre, ma da otto secoli il Naadam è la rievocazione delle gesta di Chinggis Khan, orgoglio inossidabile di questo Paese, prima padrone di due continenti e poi vittima di invasioni e umiliazioni. Ancora oggi è l’occasione per fare festa e riscoprire l’unità nazionale, anche se i turisti stanno togliendo sempre più spazio ai titolari delle celebrazioni. Negli ultimi anni i mongoli si stanno abituando a vedere frotte di stranieri accalcarsi con le macchine fotografiche per vivere e immortalare qualcosa che probabilmente non capiranno mai fino in fondo. E che, tutto sommato, per un occhio occidentale a volte sconfina nel noioso. Invece per i mongoli questi giorni significano libertà e orgoglio. Dal 1921 il Naadam assume anche il valore celebrativo per la liberazione dai cinesi ma sotto il dominio stalinista ogni riferimento a Chinggis Khan era rigidamente proibito. Solo nel luglio 1990, scrollato di dosso anche il peso sovietico, si rivedono le icone del grande condottiero.
Ormai il Naadam fa parte di tutti i programmi di viaggio nel mese di luglio. Addirittura molti viaggiatori adeguano la partenza per la Mongolia per poter assistere a quella che con estrema fantasia è stata definita l’olimpiade della steppa. Il vero fascino però si avverte più nell’atmosfera che si carica di passione e di tensione nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti l’evento o nelle edizioni che si svolgono nelle campagne: Ulaanbaatar viene lentamente circondata dalle gher dei nomadi provenienti da tutto il Paese, dopo giorni e giorni a cavallo. Infatti il vero spettacolo, per chi vuole cercarlo, è alla periferia della capitale, trasformata per qualche giorno in un enorme accampamento.
Nelle strade di Ub, tra mongoli vestiti con i costumi tradizionali e i turisti sempre più numerosi, si vedono sfilare nomadi che, in groppa ai loro cavalli, hanno finalmente la possibilità di visitare la “grande città”. La celebrazione vera e propria ha inizio nella piazza principale di Ulaanbaatar dove l’esercito schierato fa da cornice ai discorsi delle autorità e del Presidente della Repubblica. Il pubblico e gli atleti si trasferiscono allo stadio principale dove comincia una lunga e principesca sfilata che rievoca le gesta di Gengis Khan. Si comincia con la lotta (foto 1, di Cartier Bresson), davanti a decine di migliaia di spettatori composti: si parte da 512 o 1.024 lottatori (il numero è sempre una progressione geometrica di ragione 2) che si sfidano in match a eliminazione diretta, dimezzandosi fino a rimanere due contendenti finali per il titolo di Arslan, cioè di leone. Quando il numero iniziale è 1024 si avranno quindi 10 turni di incontri. Superato il 5° turno si è insigniti di un titolo onorifico: è un Nachin (Gheppio) chi arriva al 6° turno, Khartsaga (Sparviero) al 7°, Zaan (Elefante) all’8°, Garid (Garuda) al 9°, Arslan (Leone) dal 9° in poi, in tre giorni di lotte trasmesse anche in diretta tv. Un due volte campione è Avarga, tre volte Dalai Avarga, quattro volte Dayan Avarga, infine Darkhan Avarga, ovvero Campione, Grande Campione, Titano, Campione Assoluto. Il più grande lottatore della storia è indubbiamente B. Bat-Erdene Avarga (classe 1964), vincitore di 12 Tsagaan Sar consecutivi e di 11 Naadam. Dal 2004 è deputato al Parlamento.
L’abbigliamento di gara, indumenti di particolare pregio, consiste in un corpetto (zodog) che copre solo spalle e braccia, attillati pantaloncini in seta (shuudag) e ai piedi i tradizionali stivali di cuoio (mongol gutal). Gli incontri si svolgono in un tempo limite che varia dai 10’ dei primi tre turni, 15’ del 4° e 5° turno, 20’ del 6° e 7° turno, fino ai 25’ dei turni finali; trascorsi tali limiti, si sorteggia la scelta di una presa che accelera l’esito dell’incontro. Vince chi costringe per primo l’avversario a toccare terra almeno con un ginocchio, un gomito o la testa. Il trionfatore volteggia come un uccello predatore sopra il rivale appena battuto. L’ultimo a resistere, dopo tre giorni di lotte trasmesse anche in diretta tv, è il vincitore del Naadam, l’uomo più forte della Mongolia. Nella storia del Naadam si contano una decina di pluricampioni.
La seconda prova è quella del tiro con l’arco (foto 2, di Federico Pistone), tornato in auge dopo l’indipendenza della Mongolia, a cui prendono parte anche giovanissimi e anziani, tutti bardati secondo l’antica tradizione guerriera. È uno degli sport più antichi dell’umanità, risalente a due millenni or sono. I concorrenti devono centrare dei cilindretti di cuoio intrecciato, con distanze che variano secondo lo stile delle varie gare. Le gare di tradizione khalkh prevedono la dotazione di 4 frecce e una distanza di 60 m per le donne, 75 m gli uomini; nelle gare di tradizione buriati sono 30 m per le donne e 40 m gli uomini; nella tradizione uriankhai, che ammette solo uomini, i bersagli sono a 50 m. Nelle gare dei bambini la dotazione è di 20 frecce e la distanza è proporzionale all’altezza. I compagni di clan sostengono gli arcieri con canti ossessivi di incoraggiamento. Infine, la corsa dei cavalli (foto 3, di Gordon Wiltsie) che si svolge nella vallata di Khüi Doloon Khudag, a 35 km da UB, protagonisti sono i bambini, da 5 a 12 anni, che lanciano i cavalli in sei sfiancanti gare, per sei diverse categorie di cavalli: Daaga, cavalli di due anni / percorso da 12 a 14 km; Shüdlen, cavalli di 3 anni / da 15 a 17 km: Khyazaalan, cavalli di 4 anni / da 15 a 17 km; Soyoolon, cavalli di 5 anni / da 22 a 24 km (è questa la gara più importante, nessun appassionato si perderebbe mai “la polvere dei Soyoolon” né un khuushuur del Naadam, venduti un po’ dappertutto); Ikh nas, cavalli di oltre 5 anni / da 24 a 26 km; Azarga, stalloni / da 22 a 24 km.
Da non perdere anche le gare di Joroo mori, cavalli che percorrono 2 km a passo ambio, e il Naadam degli uyaachid, ammaestratori di cavalli. Per partecipare al Naadam sarebbe opportuno prenotare in anticipo i biglietti per lo stadio, attraverso organizzatori locali, mentre si può assistere liberamente alle prove di tiro con l’arco e, in modo un po’ più avventuroso, alle corse dei cavalli.
Testo di Federico Pistone per mongolia.it
Diciassette etnie a formare la grande popolazione della Mongolia, ognuna con i propri usi e costumi, tutte stupefacenti. Mongolia.it le ha radunate in queste schede per scoprire ogni frammento della cultura di questo popolo straordinario, dalla minuscola comunità degli Tsaatan (250 uomini e molte più renne) fino ai Khalka che, con oltre due milioni di appartententi, costituiscono l'85% dell'intera Mongolia. Qui le presentiamo inordine alfabetico.
BARGA
Quanti sono: 2.000
Dove vivono: nelle zone remote degli aimag di Dornod e di Töv
Caratteristiche: sono originari delle regioni siberiane del lago Bajkal e hanno uno stile di vita legato ai ritmi della natura. Comprendono il ceppo etnico dei Solon. Sontuosi i costumi tradizionali, con dominante blu e cappello nero schiacciato con un lungo nastro rosso.
BAYAD
Quanti sono: 40.000
Dove vivono: nell’aimag di Uvs, in particolare tra i laghi Uvs e Khyargas
Caratteristiche: sono i discendenti diretti dei Mongoli Oirad e vivono con orgoglio le difficilissime condizioni climatiche. Gli uomini indossano un sobrio pastrano bianco con bordi neri, le donne un variopinto cappotto (chiamato “deel”) verde e viola.
BURIATI
Quanti sono: 50.000
Dove vivono: nelle zone settentrionali (Bulgan, Dornod, Selenghe e Khentii)
Caratteristiche: quella mongola è solo una piccola branca dei buriati, complessivamente mezzo milione. Alle gher preferiscono costruzioni stabili in legno. Hanno una lingua propria e come costume ufficiale indossano un vestito blu chiuso al petto da una cintura a tre colori.
DARIGANGA
Quanti sono: 30.000
Dove vivono: nella spoglia regione sud orientale di Sükhbaatar Caratteristiche: popolazione poco frequentata dagli stranieri e forse per questo ancora più ospitale e genuina. Gli abiti tradizionali sono particolarmente vivaci e si dice che le ragazze Dariganga siano le più belle della Mongolia. (foto 1)
DARKHAD
Quanti sono: 15.000
Dove vivono: nelle regioni settentrionali del Khövsgöl Caratteristiche: è un’etnia di origine turca, ex nomadi sedentarizzati durante il regime sovietico che oggi sopravvivono in condizioni proibitive, a causa del fallimento delle fabbriche di pesce. Gengis Khan attingeva ai Darkhad per ingaggiare le migliori guardie del corpo. Vestito semplice color ocra e nero.
DURVUD
Quanti sono: 60.000
Dove vivono: nelle regioni dell’Altai, in particolare nell’aimag di Uvs e Khovd
Caratteristiche: rappresentano il 50 per cento della popolazione di questi territori che anticamente si chiamavano proprio Dörvöd. Questa etnia è molto legata ai propri usi e costumi. Elegante l’abbigliamento, blu con fregi bianchi e neri e vivace cappello rosso.
ELGJIN
Quanti sono: 2.000
Dove vivono: nelle regioni occidentali, in una specie di zona franca circondata dai territori popolati dalle etnie Khoton e Dörvöd
Caratteristiche: minuscola etnia che quasi si nasconde tra le montagne della catena del Khangain nuruu. Sono molto orgogliosi delle proprie radici, adottano abiti e accessori molto raffinati.
KAZAKI
Quanti sono: 80.000
Dove vivono: nella zona degli Altai, in particolare nell’aimag di Bayan-Ölghii, non lontano dal vero Kazakistan
Caratteristiche: è l’unica etnia musulmana della Mongolia e, pur conservando i dettami islamici, non impone restrizioni alle donne. Resta ancora viva la tradizione della caccia con le aquile. Vestiti: scuri per gli uomini, chiari per le donne. (foto 2)
KHALKA
Quanti sono: 2.100.000, circa l’85 per cento della popolazione totale
Dove vivono: ovunque in Mongolia, sono la quasi totalità dal Gobi al fiume Selenghe
Caratteristiche: l’etnia nasce nel XVI con uno stato autonomo e una lingua che oggi è quella ufficiale. Numerosi anche i khalkh che vivono nella Mongolia Interna cinese. Vivacissimi gli abiti tradizionali femminili, più semplici quelli maschili. (foto 3)
KHOTON
Quanti sono: 5.000
Dove vivono: nelle regioni nordoccidentali, soprattutto negli aimag di Uvs e Zavkhan
Caratteristiche: una delle numerose etnie di origine turco-altaica che popolano la Mongolia. Molto legati alle antiche tradizioni. Gli abiti sono particolarmente eleganti e rigorosi, con prevalenza di colore nero e ricami dorati.
MYANGAD
Quanti sono: 5.000
Dove vivono: nell’aimag di Khovd alle pendici dei monti Altai
Caratteristiche: hanno origine turco-altaica con dialetto, tratti somatici, usi e costumi del tutto differenti dai mongoli khalkha.
L’abbigliamento tradizionale è particolarmente vivace, con tuniche nere, blu, rosse e verdi e ricami d’oro, cappello di pelo con vistose decorazioni.
ÖÖLD
Quanti sono: 12.000
Dove vivono: negli aimag di Khovd e Arkhangai
Caratteristiche: etnia nomade che ha seguito numerosi itinerari fino a stanziarsi in due zone non contigue, una nel centro della Mongolia, l’altra all’estremo ovest. Stirpe fiera e sanguigna, gli Ööld hanno dato vita nel XIV secolo a una feroce lotta interna all’impero mongolo. Eleganti costumi blu e viola.
TORGUUD
Quanti sono: 10.000
Dove vivono: nell’Altai, specialmente nell’aimag di Khovd
Caratteristiche: originari dei territori centrali, i Torguud si sono gradualmente spostati verso ovest fino a raggiungere l’Altai. Straordinari musicisti, da loro sono nate le melodie più suggestive della Mongolia. Raffinati i costumi, color ocra con riporti neri, cappelli a semisfera ricchi di fregi dorati.
TSAATAN
Quanti sono: 250
Dove vivono: nelle glaciali foreste dei monti Sayan, aimag di Khövsgöl, al confine di Tuva
Caratteristiche: antichissima etnia di origine turco-altaica, con dialetto e tradizioni proprie, che vive in simbiosi con un migliaio di renne. Ha mantenuto a caro prezzo la vocazione nomade e sciamanica. Veste in semplicità con pesanti cappotti blu o granata. (foto 4)
URIANKHAI
Quanti sono: 20.000
Dove vivono: su una vasta area occidentale, negli aimag di Khovd e Bayan-Ölghii
Caratteristiche: sono conosciuti anche come Tuvan o Altain poiché popolano le pendici della catena dell’Altain nuruu al confine con la Repubblica di Tuva. Le loro tradizioni antichissime rivivono negli impressionanti riti religiosi e nel sontuoso abbigliamento. (foto 5)
ÜZEMCHIN
Quanti sono: 2.000
Dove vivono: nelle regioni orientali del Dornod e Sükhbaatar
Caratteristiche: piccola etnia contaminata dalla vicina cultura cinese con cui condivide molte abitudini e perfino i costumi. L’abbigliamento tradizionale prevede meravigliosi copricapi femminili di perle e coralli, per gli uomini cappelli in stile cinese.
ZAKHCHIN
Quanti sono: 25.000
Dove vivono: sono concentrati in una zona relativamente ridotta dell’aimag di Khovd, nell’Altai
Caratteristiche: anticamente era una delle etnie preminenti dell’impero mongolo, protagonista di lotte violente contro altre etnie mongole, soprattutto nel XIV secolo. Donne in azzurro con dettagli in viola e nero, uomini in bianco con fregi neri.
Sciamani, nomadi fra terra e cielo
Lo sciamanismo è l’anima stessa della Mongolia, la sua dimensione mistica e primitiva. I riti sciamanici, poi diffusi su tutto il pianeta, sono nati nelle foreste siberiane e nella Buriazia mongola. Chinggis Khan, che consultava gli sciamani prima di ogni decisione, era convinto di essere stato delegato dal Cielo in persona (Tengher) per dominare i popoli del mondo. Tutti i suoi discorsi e i suoi comandi cominciavano con “Per il volere del Cielo”.
Ancora oggi, nella capitale Ulaanbaatar così come nelle più sperdute regioni, lo sciamanismo è praticato in modo diffuso. Nei settant’anni di governo filosovietico, i riti erano state vietati in maniera crudele, ma dopo il 1990 il fenomeno è riesploso più forte di prima. Oggi i mongoli riescono a conciliare con disinvoltura il culto buddhista lamaista con quello sciamanico. Il territorio del Paese è punteggiato dagli ovoo (foto 1), altari di pietra e rami che segnano, secondo antiche mappe esoteriche, la presenza degli spiriti. Ogni persona che incontra un ovoo gira tre volte intorno in senso orario e getta un’offerta. Che vale sia in funzione buddhista che sciamanica: un “offri uno ed esaudisci due”. Sullo sciamanismo sono stati scritti meravigliosi studi e cialtronerie inaudite. Ma è la semplicità a caratterizzare il senso stesso di questa pratica pura e drammatica. Ci sono sì implicazioni antropologiche e variazioni sul tema, ma i concetti di partenza sono minimi e non lasciano spazio all’interpretazione. La visione cosmologica è essenziale.
Secondo lo sciamanismo esistono tre livelli di esistenza, un po’ come nella nostra concezione religiosa: la dimensione terrena, il paradiso e l’inferno, con la possibilità di interagire fra questi mondi, compito delegato appunto allo sciamano. Nella vita terrena, l’uomo ha tre anime: una è quella collegata al corpo e quando si distacca provoca la morte. Le altre due regolano come un’altalena l’equilibrio psicofisico, possono abbandonare il corpo e si reincarnano. Se il corpo di chi muore (che ancora oggi viene abbandonato all’aperto dai nomadi) è divorato da animali di terra, come lupi o roditori, l’anima scivolerà nel mondo di sotto, che è buio, con mezzo sole e mezza luna. Il figlio di Tengher, Erleg Khan, deciderà come si reincarnerà, secondo le preghiere rivolte dai parenti del morto. Se il cadavere è invece ghermito dagli uccelli, l’anima è sollevata nel mondo di sopra, illuminato da sette soli, e lì vivrà in pace e letizia, accanto a Etseg Malaan, l’altro figlio di Tengher.
Solo gli sciamani possono individuare le porte di accesso del mondo superiore e inferiore per cercare di esaudire le richieste di chi si sottopone al rito. E lo fanno con pratiche stupefacenti e dopo un percorso personale estremamente sofferto. In questa visione, non è difficile comprendere come certe manifestazioni naturali assumano un significato così intenso per i nomadi della steppa, della taiga e del deserto. Un fulmine è letto come la rabbia del Cielo; un terremoto o un semplice ululato di un lupo significano che nel mondo di sotto c’è qualcosa che non va. Gli animali sono considerati, alla stregua degli uomini, esseri dotati di anima e destinati a reincarnarsi. Per questo i mongoli ne hanno un rispetto quasi sacro, e rivolgono preghiere quando uno di loro muore. Nella foto 2 una sciamana degli Tsaatan.
Testo di Federico Pistone per mongolia.it
Il buddhismo dentro la Mongolia
Sciamanisti, buddhisti e soprattutto tolleranti. I Mongoli hanno ereditato anche questi valori religiosi da Chinggis Khan, inflessibile imperatore ma benevolo seguace dei capi spirituali tibetani. Il condottiero giunge a inviare una missiva a Sakya Pandita, numero uno del potere buddhista. Il terzogenito Ögödei, divenuto Gran Khan, invita alla sontuosa corte di Karakorum lo stesso Sakya Pandita. E il figlio di Ögödei, Godan, nel 1244 replica l’invito convinto di poter guarire così da una grave malattia. Davanti al trono di Güyüg, l’imperatore incontrato da fra’ Giovanni di Pian del Carpine, giungono anche alcuni rappresentati dell’ordine karmapa. Eppure, fino al 1261, il clero buddhista rimane ai margini del potere mongolo.
La situazione cambia sotto Khubilai Khan che chiama in Cina, dove ha trasferito la sede dell’impero, il nipote di Sakya Pandita, Phagpa, lo elegge suo maestro e si fa conferire le consacrazioni di rito, una sorta di iniziazione buddhista. Khubilai nomina Phagpa capo supremo del clero e “Maestro dell’imperatore, Re della grande e preziosa dottrina, Degnissimo Lama e re della dottrina dei tre paesi”. Il Gran Khan fa inoltre erigere, in quella che diverrà Pechino, una serie di monasteri. Anche i successori di Khubilai continuano a distribuire favori ai religiosi buddhisti, ma la conversione riguarda solo i Khan e parte della loro corte. Il popolo continua a seguire l’ancestrale credo sciamanico. Nel 1368 l’ultimo imperatore mongolo Togoon Temur è cacciato dalla sua capitale con tutto l’esercito mongolo: comincia la persecuzione dei nuovi imperatori cinesi contro i credenti e i religiosi del buddhismo tibetano. Quando i discendenti di Gengis Khan ritornano in Mongolia devono affrontare l’ostilità dei vecchi alleati, gli Oirad (Mongoli occidentali), ma anche uno stillicidio di lotte interne: l’entusiasmo per il buddhismo si spegne e i Mongoli tornano al loro credo sciamanico.
Anche in Tibet la fede religiosa sembra dissolversi finché entra in scena Tsongkhapa, il riformatore. Nato nel 1357, colui che avrebbe fondato l’ordine Ghelugpa conduce una vita di illuminazione spirituale. Alla sua morte, nel 1419, lascia un ordine ormai consolidato, chiamato “dei berretti gialli”. Da qui nasce l’istituzione dei Dalai lama, il cui primo rappresentante sarà Ghedündrup, nipote di Tsongkhapa. Altan Khan (1543-1582), pretendente all’eredità politica di Gengis Khan ma nato al di fuori della sua discendenza, dopo aver vittoriosamente combattuto ed assoggettato buona parte della Mongolia, si converte improvvisamente al buddhismo. Nel 1577 chiede un incontro al lama tibetano Sonan Gyatso, “berretto giallo” del lignaggio di Tsongkhapa. Il Khan nomina Sonan terzo Dalai lama.
Phagpa aveva predetto a Khubilai che si sarebbero incontrati in una vita futura dove il tibetano sarebbe diventato acqua e il Khan oro. La profezia si compie: in mongolo Dalai significa “oceano” e Altan “oro”. Altan Khan è così riconosciuto dal lama quale reincarnazione di Khubilai, legittimando così le sue pretese al trono. È un capo dell’etnia Khalkh della Mongolia centrale, Avtai, a fondare un proprio khanato, il Tüsheet. Nel 1586 inizia la costruzione di quello che sarà il primo dei monasteri mongoli: l’Erdene Zuu (“cento gioielli”) ancora oggi visitabile in tutto il suo magico splendore nei pressi dell’antica Karakorum (Kharkhorin). Prima di arrivare ai fasti dell’Erdene Zuu, i templi non sono che grandi gher in grado di seguire i pastori nelle loro transumanze. Man mano che la religione si diffonde, si sente la necessità di strutture più spaziose per contenere i fedeli e per meglio adattarsi ai dettami del buddhismo, che attribuisce particolare significato ai punti cardinali e agli angoli; le grandi tende-tempio iniziano a poggiare su basi poligonali prima e quadrate in seguito, con tetto piramidale. Scompaiono i rivestimenti in feltro, sostituiti da legno intrecciato. Nel XVII secolo diventano sempre più popolari gli stili cinese e tibetano che, mescolati alla tradizionale impronta mongola, danno origine a un mosaico di architetture. Nella foto 3, il monastero di Gandan a Ulaanbaatar
Testo di Giancarlo Ventura