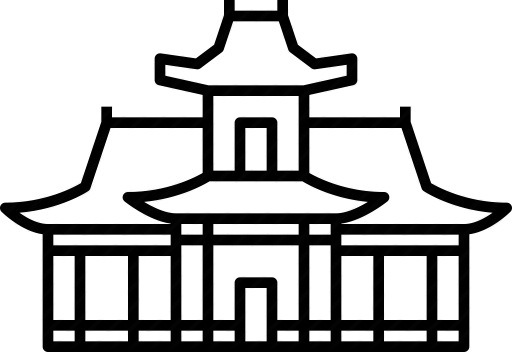Sciamani, nomadi fra terra e cielo
Lo sciamanismo è l’anima stessa della Mongolia, la sua dimensione mistica e primitiva. I riti sciamanici, poi diffusi su tutto il pianeta, sono nati nelle foreste siberiane e nella Buriazia mongola. Chinggis Khan, che consultava gli sciamani prima di ogni decisione, era convinto di essere stato delegato dal Cielo in persona (Tengher) per dominare i popoli del mondo. Tutti i suoi discorsi e i suoi comandi cominciavano con “Per il volere del Cielo”.
Ancora oggi, nella capitale Ulaanbaatar così come nelle più sperdute regioni, lo sciamanismo è praticato in modo diffuso. Nei settant’anni di governo filosovietico, i riti erano state vietati in maniera crudele, ma dopo il 1990 il fenomeno è riesploso più forte di prima. Oggi i mongoli riescono a conciliare con disinvoltura il culto buddhista lamaista con quello sciamanico. Il territorio del Paese è punteggiato dagli ovoo (foto 1), altari di pietra e rami che segnano, secondo antiche mappe esoteriche, la presenza degli spiriti. Ogni persona che incontra un ovoo gira tre volte intorno in senso orario e getta un’offerta. Che vale sia in funzione buddhista che sciamanica: un “offri uno ed esaudisci due”. Sullo sciamanismo sono stati scritti meravigliosi studi e cialtronerie inaudite. Ma è la semplicità a caratterizzare il senso stesso di questa pratica pura e drammatica. Ci sono sì implicazioni antropologiche e variazioni sul tema, ma i concetti di partenza sono minimi e non lasciano spazio all’interpretazione. La visione cosmologica è essenziale.
Secondo lo sciamanismo esistono tre livelli di esistenza, un po’ come nella nostra concezione religiosa: la dimensione terrena, il paradiso e l’inferno, con la possibilità di interagire fra questi mondi, compito delegato appunto allo sciamano. Nella vita terrena, l’uomo ha tre anime: una è quella collegata al corpo e quando si distacca provoca la morte. Le altre due regolano come un’altalena l’equilibrio psicofisico, possono abbandonare il corpo e si reincarnano. Se il corpo di chi muore (che ancora oggi viene abbandonato all’aperto dai nomadi) è divorato da animali di terra, come lupi o roditori, l’anima scivolerà nel mondo di sotto, che è buio, con mezzo sole e mezza luna. Il figlio di Tengher, Erleg Khan, deciderà come si reincarnerà, secondo le preghiere rivolte dai parenti del morto. Se il cadavere è invece ghermito dagli uccelli, l’anima è sollevata nel mondo di sopra, illuminato da sette soli, e lì vivrà in pace e letizia, accanto a Etseg Malaan, l’altro figlio di Tengher.
Solo gli sciamani possono individuare le porte di accesso del mondo superiore e inferiore per cercare di esaudire le richieste di chi si sottopone al rito. E lo fanno con pratiche stupefacenti e dopo un percorso personale estremamente sofferto. In questa visione, non è difficile comprendere come certe manifestazioni naturali assumano un significato così intenso per i nomadi della steppa, della taiga e del deserto. Un fulmine è letto come la rabbia del Cielo; un terremoto o un semplice ululato di un lupo significano che nel mondo di sotto c’è qualcosa che non va. Gli animali sono considerati, alla stregua degli uomini, esseri dotati di anima e destinati a reincarnarsi. Per questo i mongoli ne hanno un rispetto quasi sacro, e rivolgono preghiere quando uno di loro muore. Nella foto 2 una sciamana degli Tsaatan.
Testo di Federico Pistone per mongolia.it
Il buddhismo dentro la Mongolia
Sciamanisti, buddhisti e soprattutto tolleranti. I Mongoli hanno ereditato anche questi valori religiosi da Chinggis Khan, inflessibile imperatore ma benevolo seguace dei capi spirituali tibetani. Il condottiero giunge a inviare una missiva a Sakya Pandita, numero uno del potere buddhista. Il terzogenito Ögödei, divenuto Gran Khan, invita alla sontuosa corte di Karakorum lo stesso Sakya Pandita. E il figlio di Ögödei, Godan, nel 1244 replica l’invito convinto di poter guarire così da una grave malattia. Davanti al trono di Güyüg, l’imperatore incontrato da fra’ Giovanni di Pian del Carpine, giungono anche alcuni rappresentati dell’ordine karmapa. Eppure, fino al 1261, il clero buddhista rimane ai margini del potere mongolo.
La situazione cambia sotto Khubilai Khan che chiama in Cina, dove ha trasferito la sede dell’impero, il nipote di Sakya Pandita, Phagpa, lo elegge suo maestro e si fa conferire le consacrazioni di rito, una sorta di iniziazione buddhista. Khubilai nomina Phagpa capo supremo del clero e “Maestro dell’imperatore, Re della grande e preziosa dottrina, Degnissimo Lama e re della dottrina dei tre paesi”. Il Gran Khan fa inoltre erigere, in quella che diverrà Pechino, una serie di monasteri. Anche i successori di Khubilai continuano a distribuire favori ai religiosi buddhisti, ma la conversione riguarda solo i Khan e parte della loro corte. Il popolo continua a seguire l’ancestrale credo sciamanico. Nel 1368 l’ultimo imperatore mongolo Togoon Temur è cacciato dalla sua capitale con tutto l’esercito mongolo: comincia la persecuzione dei nuovi imperatori cinesi contro i credenti e i religiosi del buddhismo tibetano. Quando i discendenti di Gengis Khan ritornano in Mongolia devono affrontare l’ostilità dei vecchi alleati, gli Oirad (Mongoli occidentali), ma anche uno stillicidio di lotte interne: l’entusiasmo per il buddhismo si spegne e i Mongoli tornano al loro credo sciamanico.
Anche in Tibet la fede religiosa sembra dissolversi finché entra in scena Tsongkhapa, il riformatore. Nato nel 1357, colui che avrebbe fondato l’ordine Ghelugpa conduce una vita di illuminazione spirituale. Alla sua morte, nel 1419, lascia un ordine ormai consolidato, chiamato “dei berretti gialli”. Da qui nasce l’istituzione dei Dalai lama, il cui primo rappresentante sarà Ghedündrup, nipote di Tsongkhapa. Altan Khan (1543-1582), pretendente all’eredità politica di Gengis Khan ma nato al di fuori della sua discendenza, dopo aver vittoriosamente combattuto ed assoggettato buona parte della Mongolia, si converte improvvisamente al buddhismo. Nel 1577 chiede un incontro al lama tibetano Sonan Gyatso, “berretto giallo” del lignaggio di Tsongkhapa. Il Khan nomina Sonan terzo Dalai lama.
Phagpa aveva predetto a Khubilai che si sarebbero incontrati in una vita futura dove il tibetano sarebbe diventato acqua e il Khan oro. La profezia si compie: in mongolo Dalai significa “oceano” e Altan “oro”. Altan Khan è così riconosciuto dal lama quale reincarnazione di Khubilai, legittimando così le sue pretese al trono. È un capo dell’etnia Khalkh della Mongolia centrale, Avtai, a fondare un proprio khanato, il Tüsheet. Nel 1586 inizia la costruzione di quello che sarà il primo dei monasteri mongoli: l’Erdene Zuu (“cento gioielli”) ancora oggi visitabile in tutto il suo magico splendore nei pressi dell’antica Karakorum (Kharkhorin). Prima di arrivare ai fasti dell’Erdene Zuu, i templi non sono che grandi gher in grado di seguire i pastori nelle loro transumanze. Man mano che la religione si diffonde, si sente la necessità di strutture più spaziose per contenere i fedeli e per meglio adattarsi ai dettami del buddhismo, che attribuisce particolare significato ai punti cardinali e agli angoli; le grandi tende-tempio iniziano a poggiare su basi poligonali prima e quadrate in seguito, con tetto piramidale. Scompaiono i rivestimenti in feltro, sostituiti da legno intrecciato. Nel XVII secolo diventano sempre più popolari gli stili cinese e tibetano che, mescolati alla tradizionale impronta mongola, danno origine a un mosaico di architetture. Nella foto 3, il monastero di Gandan a Ulaanbaatar
Testo di Giancarlo Ventura