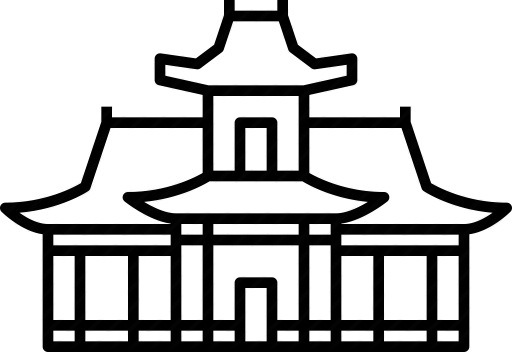Questo diario, le cui impressioni abbiamo registrato "live" in Mongolia su un registratorino che ci portiamo sempre dietro affinché nulla vada perso, vuole essere per noi una memoria dei viaggi che facciamo per non scordare anche solo i dettagli; più di quanto abbiamo visto (per questo sarebbero sufficienti le foto) ci interessa memorizzare quanto abbiamo vissuto.
ULAN BAATAR
Che il viaggio costituisca in qualche modo un’avventura e che dobbiamo prepararci a qualche disagio lo percepiamo fin dall’inizio, quando ci imbarchiamo sul Tupolev M154 in partenza da Mosca con destinazione Ulan Baatar. Sebbene la compagnia sia quella di bandiera russa, il velivolo presenta tutte le caratteristiche del relitto di stampo sovietico. Al di là delle pessimistiche previsioni il volo è invece regolare ed arriviamo sostanzialmente in orario nella capitale mongola. L’aeroporto è piccolo ma funzionale. La pista sarà pure in leggera salita come dicono le guide ma non è assolutamente da brivido, non fosse per l’aereo col quale stiamo per toccare terra. La strada che ci porta in città mostra Ulan Bataar al suo risveglio in una giornata qualsiasi: dinamica sui cartelloni pubblicitari in prossimità dello scalo, ma assai triste nelle baracche che recingono il centro. La città è costruita a nord del fiume Tuul e circondata da deliziose montagne. Il centro ostenta una modernità recente. All’esterno sorgono dapprima edifici d’epoca sovietica, mentre la periferia si sta rapidamente ampliando con accampamenti di ger attratti dalle false chimere della città. Con queste abitazioni la migrazione è resa più agevole che altrove. La zona più vecchia è caratterizzata da palazzi in stile sovietico, mentre nelle periferie si incontrano le tradizionali gher, tende in feltro di forma circolare.
Lasciamo la valigia più grande in hotel con dentro quanto non strettamente necessario per la vita country e siamo pronti ad iniziare il viaggio, partendo doverosamente dalla visita della capitale.
Il cardine è senza dubbio piazza Sukhbaatar, dedicata all’eroe nazionale a cui la Mongolia deve l’indipendenza dalla Cina nel 1921 ma contemporaneamente anche la sudditanza verso l’Unione Sovietica. Col senno di poi potremo dire che Sukhbaatar abbia fatto la scelta meno peggiore. Se fosse rimasto sotto Pechino, adesso il Paese sarebbe solo una provincia dell’impero cinese, come ha finito per esserlo la Mongolia Interna.
La città in generale non può considerarsi bella: in pieno centro ci sono dei tombini aperti che fungono da grandi cesti per la spazzatura e la condizione dei marciapiedi impone attenzione continua nell’incedere. Le persone che s’incontrano per la strada hanno comunque un’aria ordinata e pulita, a prescindere dal ceto sociale. Anche la moda assume dei toni sobri secondo i dettami dello stile orientale. Lo smog è padrone in mezzo ad un traffico caotico e dove dovrebbero trovarsi delle aiuole non c’è altro che erbacce. Decisamente il popolo mongolo non ha un grande senso dell’estetica per quanto riguarda gli ornamenti verdi. Tutto questo va detto considerando il nostro punto di vista. Si potrebbe opinare sulla necessità d’avere giardini decorati, quando a poca distanza iniziano paesaggi incantevoli.
Il traffico più intollerabile si limita al centro urbano. Si alternano mezzi pubblici accettabili (di solito ricevuti in nome della collaborazione con Paesi quali Corea e Giappone) ad autentiche carrette stracolme di passeggeri. L’unica cosa che li accomuna è l’ingente fumo che lasciano dietro di loro. Usciamo verso sud per issarci sulla punta di una collina, dove sorge il monumento all’amicizia sovietico-mongola (lo Zaisan), costituito da un enorme cerchio in cemento sostenuto da due pilastri, all’interno del quale sono stati realizzati dei mosaici tesi a testimoniare l’amicizia fra i due popoli. Alla base si trova un ovoo rivolto verso le montagne.
Ai piedi della collina sorge un monastero all’aperto, caratterizzato da un’alta statua di Buddha, con relative ruote di preghiera. Spicca nelle vicinanze un carro armato, donato dall’URSS a memoria dell’aiuto prestato dai mongoli nella seconda guerra mondiale. Trattasi di un mezzo sovietico divenuto famoso per essere stato tra quelli ad aver raggiunto e liberato Berlino. Intorno alla collina si trovano delle ger, separate dagli hasha, i cortili che garantiscono la privacy dei mongoli urbani. Poco oltre si trovano delle villette di recente costruzione, a simboleggiare lo status di un ceto borghese in costante crescita.
Prima di rientrare nel centro visitiamo il Palazzo Invernale di Bogd Khan, costruito tra il 1893 ed il 1903, in cui visse l'ultimo re mongolo Javzan Damba Hutagt VIII. Questo complesso di templi ospita numerose opere d'arte buddista e la collezione privata di oggetti e abiti del re, fra cui spiccano una ger rivestita con le pelli di 150 leopardi delle nevi e numerosi animali rari impagliati, frutto delle stravaganti passioni esotiche del sovrano (foto).
A seguire ci spostiamo verso Gandantegchenling, uno dei tre grandi monasteri rimasti dopo le purghe staliniane. Sorto nel 1838, è il più importante della Mongolia, al cui interno sorgono splendidi templi. In passato contava più di 10.000 monaci ed è considerato punto di riferimento da tutti i fedeli buddisti. Assistiamo in silenzio ad una cerimonia. La voce gutturale dei lama si diffonde nell’aria, offrendoci per la prima volta la netta percezione di trovarci nel vero Oriente. Spiccano molti ragazzini. Sono infatti i genitori che li indirizzano verso la vita monastica già all’età di 5 – 6 anni. A volte si tratta di vera ispirazione religiosa, in altri casi si tratta di un rimedio per non finire sulla strada quando le famiglie non possono permettersi di allevarli. Tutti questi monasteri sono stati ristrutturati dopo il 1990, sovente con contribuiti provenienti da altri Paesi buddisti. Sembra che i cinesi nel XV-XVI sec., contrariamente a quanto fecero i sovietici, durante l’occupazione della Mongolia promossero attivamente la proliferazione del buddismo fra tutti i ceti. Molti uomini divennero lama (si parla di metà della popolazione maschile) finendo per indebolire ogni resistenza attiva verso l’occupante. Quando arrivarono i sovietici trovarono i monasteri popolati di monaci (fino a diecimila per i più importanti) e misero in atto una politica di deportazione e sterminio nei loro confronti. Vediamo anche la statua dorata del Buddha Migjid Janraisag (Avalokiteshvara) nel tempio di Migjid Janraisig, alta 26,5 mt., riempita all’interno di sutra, formule di mantra e erbe medicinali. Tutt’intorno si trova un numero incalcolabile di ruote della preghiera. Il fedele, facendo girare tali ruote, è come se recitasse le preghiere in esse contenute, e queste salissero al cielo. Nelle vicinanze si trova anche l’università del Buddismo e, sempre all’interno del complesso, si trovano altri templi.
Pranziamo all’Altaj Mongolian Barbeucue, che si traduce in un buffet ricco di carne cruda di vari generi. Lo portiamo agli chefs, i quali lo cucinano all’instante sulla piastra intrattenendo il pubblico in attesa fornendo loro varie acrobazie con le porzioni. Normalmente quello che salta in aria finisce nel piatto del legittimo cliente.
Passiamo dai Grandi Magazzini di Stato, quello che qui definiremmo un centro commerciale, un tempo appannaggio soprattutto degli stranieri, oggi meta anche dei locali. Si tratta di un giro esplorativo tanto per vedere le alternative che offre lo shopping locale. Troviamo diversi oggetti che attraggono la nostra attenzione e ci diamo appuntamento per l’ultimo giorno, quando avremo un’idea più chiara di cosa mettere nella valigia per il rientro.
Arrivano finalmente le 14,30 e ci spostiamo al Museo di Storia Naturale, ricco di animali endemici impagliati. Fiore all’occhiello del museo sono gli scheletri di dinosauro rinvenuti nel deserto del Gobi. I più recenti hanno 70 milioni di anni. Assai interessanti anche le uova di questi rettili appartenuti ad un’era che stentiamo ad immaginare.
La giornata è stata calda ed abbiamo visto diverse persone (soprattutto signore) andare in giro con gli ombrelli aperti per ripararsi dal sole, oppure semplicemente coprirsi con delle borse portadocumenti. Non si capisce se sia per timore delle radiazioni solari o per non abbronzarsi. Come accadeva da noi un tempo, la pelle bianca è indice di classe. Altre invece indossavano una fasciatura sulla bocca, probabilmente nel tentativo di ridurre lo smog assorbito.
Rientriamo in hotel per una doccia rinvigorente ed usciamo alle 17,30 per recarci ad assistere ad uno spettacolo di musica e folklore locale. Costumi locali a tinte vivaci, maschere talvolta aggressive ma ricche di significato, canti di gola (o kööhmii) vanto di questo Paese, infanti contorsioniste che riesce difficile catalogare fra giovani artiste o geishe sfruttate, ci calano nella tradizione di questo popolo ricco di storia ed orgoglio. Rappresenta un ottimo sistema per prendere contatto con l’aspetto più edonistico della società.
Andiamo a cena al Modern Nomads, dove sperimentiamo il khorkhog, un piatto contenente pietre roventi e costine di montone. Ci accontentiamo di mangiare quest’ultimo, semplicemente delizioso. Convinti che per oggi possa bastare ci rifugiamo per un meritato riposo in hotel. La bella vita è finita, domani inizia l’avventura! Ma non sarà di certo questo a toglierci il sonno e nemmeno i clacson e fuochi artificiali che si sentono provenire dalle strade del centro: la Mongolia ha vinto il suo primo oro olimpico in assoluto, proprio a Pechino e nella disciplina del judo. Più che legittima l’euforia e l’orgoglio nazionale.
SECONDO GIORNO
Lasciamo la capitale in una bella giornata dopo esserci assicurati di aver preso tutto il necessario, anche per i pernottamenti in tenda, e si parte in direzione ovest per proseguire successivamente verso nord. La periferia è costellata da campi ger sorti negli ultimi anni in seguito ai numerosi inverni particolarmente freddi (denominati zud) susseguitisi nei primi anni di questo secolo. Sterminando il bestiame di cui vivevano, i pastori si sono trovati a dover affrontare una ben più triste transumanza verso la città. Hanno così ingrossato le fila della popolazione povera, senza un lavoro che possa dirsi tale, disadattati nel dover condurre una vita che non è la loro: quella del pastore e in aree rurali. Questo ha incrementato l’uso di alcolici come la vodka, che in principio dovevano servire per limitare il dolore di aver perso tutto, in realtà non ha fatto altro che aggravare il disagio. Questo alcolico venne inserito nel tessuto sociale dai sovietici per ammansire la popolazione negli anni ’70 ed è ancora ampiamente diffuso, sebbene da più fonti si afferma che il consumo di vodka sia in declino e che i giovani preferiscono la buona birra di produzione locale. Troveremo molti ubriachi, talvolta molesti nei confronti di altre persone, ma mai aggressivi. Anche qui si vede il carattere pacifico seppure nella piaga dell’alcolismo. Man mano che ci si allontana i quartieri di ger scompaiono per lasciare spazio alle prime praterie con rare tende isolate: finalmente le troviamo collocate nel posto giusto, quello pensato dalla Natura. Mentre procediamo incontriamo prima il crematorio della capitale e quindi il cimitero. La regola religiosa vuole che i corpi vengano cremati prima dell’inumazione. Sarebbe comunque impensabile inumare i corpi nella terra considerando le rigide temperature invernali.
Poco prima di Darkhan svoltiamo verso ovest. Proseguendo verso nord, in poche decine di km ci saremmo trovati in Siberia. E’ stupefacente come, pur trattandosi di un incrocio significativo, non vi siano indicazioni di direzione. L’autista fai da te avrebbe sicuramente vita dura non solo nell’orientarsi, ma anche nel scegliere la giusta via. Incontreremo questa mancanza di segnaletica un po’ in tutti gli incroci che troveremo. La strada finora è stata asfaltata sebbene con evidenti buche, ma prendendo per Erdenet migliora. In prossimità delle strade asfaltate si trovano dei caselli che richiedono il pagamento di un pedaggio (di solito sui 5000 T.). La velocità media si aggira sui 90 km/h. Ci fermiamo per qualche minuto a Hötög, villaggio evidentemente progettato e costruito seguendo lo stile sovietico, dove la nostra guida ha vissuto per 4 anni quando era ragazzino e suo padre faceva il poliziotto. La guida ci spiega di essere per metà di etnia bayad e per l’altra metà khalkha. Sua nonna proveniva dall’aimag di Uvs, da dove si è spostata in occasione dell’ultima guerra mondiale, essendo dottoressa militare. Imbocchiamo infine una pista sterrata ed in cattive condizioni che in 35 km porta al Monastero di Amarbayasgalant (foto a sinistra). In realtà si tratta di due e a volte anche tre piste che corrono parallele ad una distanza di pochi metri e di tanto in tanto finiscono per incrociarsi. Sta all’abilità degli autisti scegliere la migliore per incappare in un numero minore di buche. Questo sistema serve a schivare i mezzi che arrivano in senso inverso e a sorpassarne altri. In questo caso bisogno però centrare la pista più rapida in termini di sobbalzi. Sorpassare qualcuno significa anche ingerire quantitativi inferiori di polvere e a scapito purtroppo di chi sta dietro. Si attraversano frequenti guadi, dove incontriamo parecchie auto impantanate con i passeggeri intenti a spingere per farle uscire dall’acqua. Il viaggio dura in tutto 5 ore, di cui buona parte su strade asfaltate. Ma non è il caso di montarsi la testa: d’ora in avanti lo sterrato rappresenterà quasi la totalità del nostro itinerario. Il monastero è uno dei più belli ed importanti della Mongolia. Venne costruito fra il 1727 e il 1737 dall’imperatore manciù Kansu secondo i canoni dello stile cinese. E’ dedicato a Zanabazar, primo imperatore-lama, scienziato e grande scultore, la cui salma venne traslata qui nel 1779. Si percepisce fin da subito che i templi hanno un’origine cinese e se ne ha una conferma nel vedere le preghiere nella stessa lingua. Troviamo il luogo incredibilmente affollato per una ricorrenza religiosa, alla quale si affianca per l’occasione un Naadam (corse a cavallo solitamente montati a pelo e montati a pelo solitamente da ragazzini a partire dai 5 anni che a cui, che i mongoli considerano guidati da ragazzini a partire dai 3 anni, che i mongoli considerano lo sport preferito in estate), del quale riusciamo a vedere l’arrivo in volata. Cerchiamo il ger camp, che si trova ca. 10 km prima del monastero. Pranzo sul tardi con specialità locale, i buuz (involtini di pasta ripieni di montone e cipolla cotti al vapore), dal gusto intenso ma eccezionalmente buono. La ger è gradevole e pulita, con servizi esterni, come sempre accade nei ger camps. Ritorniamo al Monastero per visitarne l’interno in un clima gioioso di festa, anche se le celebrazioni sono ormai terminate. Venditori di airag, altre bevande e giocattoli ornano l’ingresso, mentre all’interno un profumo d’incenso pervade l’aria circostante. La tradizione buddista prevede che vengano fatte delle offerte in onore delle varie divinità, che vanno da piccole somme di denaro agli alimentari (riso, biscotti e pezzi di formaggio). Il tutto conferisce un senso di disordine e sporcizia, ma fa parte della tradizione. Capita anche di trovare delle offerte di denaro poste sugli ovoo, senza che nessuno le raccolga.
Cena al campo con involtini alla coreana e bevendo tè, la bevanda che di solito accompagna i pasti. Le mandrie di bestiame sono molto frequenti ed è bello vedere i cow-boys a cavallo mentre le radunano. Forse è una delle immagini maggiormente rappresentative della vita agreste in Mongolia ed effonde un senso di libertà. Il che, per contrasto, spiega il disagio che provano a vivere in città. Visitiamo anche i dintorni del monastero, salendo su una collina la cui cima è arricchita da ovoo e bandierine tibetane, per ammirare il paesaggio da dall’alto. In effetti la vista del Monastero di cui spicca il colore rosso in mezzo al verde delle praterie circostanti e delle basse montagne che si elevano tutt’attorno, offre un panorama incantevole.
TERZO GIORNO
La notte scorre via fresca e la coperta spessa ci torna assai utile. Alle 8,45 ci troviamo già ad Amarbayasgalant per vedere le cerimonie nel tempio. C’è già molta gente che si accalca, mentre all’interno i monaci intonano le loro preghiere cantate. Un’abbondanza di dolci, riso ed altri alimenti stanno a significare le offerte verso le divinità
Il cielo è sereno, con qualche velatura alta, mentre ci dirigiamo verso Erdenet , la seconda città della Mongolia, con una popolazione di ca. 70.000 abitanti. Ampi pascoli con numerosi vitelli che amano sostare sulla strada. La città ha una marcata struttura sovietica e se non bastasse, a ricordarcelo campeggia un grande mosaico del volto di Lenin sulla parete di un palazzo. Cerchiamo invano di visitare la miniera di rame che essendo sabato è chiusa ai turisti. E’ una fra le dieci miniere più grandi del mondo e da sola produce il 40% dell’export mongolo, consumando quasi la metà dell’elettricità del Paese. Erdenet trae la propria sussistenza unicamente da questa attività. Visitiamo il monumento dedicato all’amicizia sovieto-mongola: dalle bottiglie rotte deduciamo che funga da ritrovo notturno per gli alcolizzati, i quali implicitamente bestemmiano i sovietici per avere introdotto la vodka. Ne compriamo anche noi una bottiglia per le emergenze freddo che potrebbero coglierci nei prossimi giorni. In 60 di km raggiungiamo Bulgan e qui diamo definitivamente l’addio alla strada asfaltata. Pranziamo in un locale dall’arredamento tanto appariscente quanto pacchiano, in cui le mosche la fanno da padrone assoluto. La strada che si apre davanti a noi è già un acconto dell’inferno. Il tutto, se possibile, viene aggravato dalla costruzione di una strada che in un futuro poco prossimo collegherà U.B. con il nord ovest. Si tratta della cosiddetta Millenium Road. Alcuni scettici sostengono che il nome sia dovuto al fatto che impiegheranno mille anni per costruirla. Le piste che sono nate a fianco sembrano essere state bombardate ed i mezzi pesanti che la frequentano non aiutano di certo a spianarla. La polvere è una compagna costante che impedisce il respiro. Incontriamo un camion carico di persone: ci dicono essere dei carcerati che stando andando al lavoro per la costruzione della strada. Anche su questo punto ci rendiamo conto come la Mongolia sia più avanzata delle nostre “democrazie garantiste”. In altri tratti gli appalti sono stati vinti da imprese cinesi, le quali si sono portati dietro i mezzi meccanici e la manovalanza. Di tanto in tanto incrociamo dei vecchi camion stracolmi di lana ovina.
In questa regione l’etnia dominante è quella buriata, la quale preferisce le costruzioni in legno piuttosto che le ger.
Sullo sterrato iniziamo a vedere i minivan della UAZ, che tutti dicono essere i più affidabili e caratterizzeranno il paesaggio motorio della steppa. Stesso discorso vale per le jeep E69, brillanti per la resistenza, meno per il comfort. Attualmente la gente predilige le jeep giapponesi in quanto sono più comode ed il prezzo delle russe è aumentato fino ad essere quasi simile ad un buon usato made in Japan.
Superiamo il pedaggio sul fiume Sengel, il più lungo del Paese, che da qui deve percorrere ancora un centinaio di km prima di gettarsi nel lago Bajkal in Siberia. Da Bulgan al luogo dove diciamo basta e piazziamo la tenda impieghiamo circa 3h ½ per percorrere ca. 140 km. In tutto abbiamo realizzato 320 km, grazie sostanzialmente alla prima parte di asfalto. Nell’ultimo tratto, essendo finiti i cantieri per la costruzione della nuova strada, riusciamo a recuperare un po’ di velocità e chiudiamo con una media sui 40 km/h. Il luogo dove piantiamo le tende si trova un decina di km a ovest di Houtag Ondor, in prossimità di una ger nomade, dove abbiamo il piacere di conoscere l’ospitale famiglia composta da padre, madre e un bambino di 5 anni con sua sorella. Ci offrono del tè salato con latte (süütei tsai), che assaggiamo con piacere, biscotti e l’aaruul (cagliata di latte essiccato, foto). Quest’ultimo ha la forma di un biscotto durissimo, è salato ed ha un gusto acidulo che è destinato a piacere solo al palato di pochi occidentali. Ci dicono che in questo periodo si nutrono essenzialmente di derivati del latte, in quanto la carne andrebbe rapidamente a male se uccidessero degli animali. Finiscono le scorte di carne secca fatta essiccare in precedenza, mentre in inverno potranno sfamarsi con la carne fresca. Le temperature superano di frequente i -30°C. Di regola in un anno fanno 4 campi diversi e posseggono 500 pecore e 50 cavalli e possono considerarsi benestanti, sebbene i prezzi che gli offrono i mercanti di U.B. quando arrivano a comprare gli animali in autunno siano sempre più bassi. I ragazzi vanno a scuola da settembre a giugno e, non potendo rientrare a casa, si fermano in locali dormitorio che la scuola mette a disposizione. Per la prima volta ci imbattiamo nella proverbiale ospitalità della gente nomade e restiamo meravigliati per la disponibilità che dimostrano nell’accogliere dei forestieri. Quanto abbiamo occasione di sperimentare va ben oltre le già lusinghiere informazioni fornite dalle guide che abbiamo letto. Pernottiamo vicino ad un torrente e prima di cena viene a trovarci un pastore con l’immancabile deel (vestito lungo, simile ad un pastrano) a cavallo della sua moto russa. E’ molto simpatico e con lui diciamo subito le uniche due parole di mongolo che conosciamo, finendo in breve la conversazione. Per fortuna i nostri accompagnatori riescono ad intrattenerlo meglio. Sta tornando a casa, che si trova ad una ventina di km. Vanta di distillare la migliore vodka ricavata dal latte (lo shimin arikh) e ci invita a berne quanta ne vogliamo. La cena avviene al lume di una splendida luna piena, mentre il freddo cala sull’ambiente circostante e s’impossessa delle nostre membra. Bere qualche birra o tazza di tè in più si rivela assai disagevole per le conseguenti uscite verso la toilette. Uscire dal sacco a pelo nel cuore della notte non è una esperienza granché tiepida, ma consente tuttavia di ammirare il silenzio della steppa mentre si espletano i propri doveri fisiologici.
QUARTO GIORNO
Continuiamo lo spostamento verso Huvsgul sotto un sole che di tanto in tanto si cela dietro un sottile velo di nuvole, ma basta questo per irrigidire immediatamente la temperatura. Andy ci fa notare come Gengis Khan abbia sempre cercato di tenere i mongoli lontano dagli alcolici per evitarne le nefaste conseguenze. Paradossalmente, quasi oltraggiosamente, ora esiste addirittura un marchio di vodka che porta il nome e l’effige del valoroso condottiero medievale. Fin dai primi giorni ci stupisce l’insensibilità ecologica dei mongoli nel lasciare in giro i rifiuti. Vengono semplicemente abbandonati nel luogo in cui non servono più E’ così che lungo le strade si trova ogni genere di immondizia, con forte prevalenza di bottiglie di alcolici. Anche nei giorni a venire resteremo stupiti di come un ambiente così bello venga inquinato da rifiuti lasciati ogni dove. A stupire non è tanto la scarsa igiene che si vede all’interno delle ger, non molto diversa da come vivono i nostri montanari. Non sarebbe del resto possibile mantenere tutto lucido in un ambiente simile. E’ piuttosto l’indifferenza con la quale lasciano ogni genere di rifiuti sul terreno pubblico, senza curarsi almeno di ammucchiarli da qualche parte. Il tutto peggiora poi nelle città e nelle periferie. Sveglia alle 7 e partenza verso le 9.30 dopo aver fatto colazione a base di salumi, purée e cipolle fritte ed impacchettato le tende. Alcuni pastori stanno portando una capra al macello. Sembra una processione, uno tira la capra, mentre un altro segue con un contenitore dove versare il sangue. Ci viene riferito che le capre sono animali molto intelligenti, pertanto si rendono conto e scalpitano quando è stato deciso il loro momento finale, diversamente dalle pecore che conservano così la loro mansuetudine fino al termine della loro vita. Il paesaggio che ci scorre di fianco sembra austriaco, un altipiano alto sui 1300 mt, ricco di lariceti e verdi pascoli. Un cow-boy dorme coricato per terra a pochi metri dalla strada mentre il suo cavallo attende il risveglio del padrone. Alcuni ragazzini cercano di fermare le poche auto per vendere i mirtilli appena raccolti. Li hanno dentro dei barattoli e, non appena ries cono a venderne uno lo versano dentro una borsa. Il vuoto è prezioso.
Fermata per sosta idrica a Ih Uul, dove vediamo da fuori un tempietto buddista. La giornata diventa più grigia man mano che saliamo di quota, mentre il verde intorno resta lussureggiante. La pista di tanto in tanto corre nel letto del torrente in secca. Anche qui, come già visto in Australia, si trovano tutta una serie di alberi che ornano i torrenti, i quali si riempiono solo in occasione del disgelo primaverile. Prima di arrivare a Mörön prendiamo qualche goccia di pioggia. Quando arriviamo in città il cielo tende a schiarirsi. Oggi è domenica e molta gente frequenta il mercato, che di solito si chiama mercato dei container, visto l’abbondante uso che ne viene fatto per adibirli a negozio. Un paio di ubriachi si regge in piedi a vicenda, mentre altra gente ben vestita mette in mostra il deel della domenica. Stante il tempo incerto e l’ora non tarda, decidiamo di puntare immediatamente su Khatgal e quindi alla ger sul lago Huvsgul, saltando il campo tendato previsto per stanotte. Si prende una pista che dopo qualche tempo diventa sempre più esile fino a scomparire, in cerca di nuove emozioni più panoramiche. In effetti quello che vediamo riempie la vista e ci fa sembrare meno dure le asperità del terreno. Sono molti gli animali che pascolano nella prateria, fra i quali spiccano i primi yak, animali che esigono temperature fresche anche in estate, e gli hainek, ibrido fra lo yak e la mucca, dal pelo leggermente più corto rispetto al bovino dalle lunghe frange. Su questi altipiani alti 1900 mt. si vedono ancora delle ger, che ci tornano utili per ritrovare una pista, quando ormai pensavamo d’averla persa definitivamente. Essendo un Paese privo di indicazioni stradali, con poco traffico, ma con un intenso reticolato di piste poco battute, le informazioni presso le ger sono di vitale importanza. Del resto più di metà della popolazione mongola vive in questo tipo di casa. E’ così che ci fermiamo presso una gentile signora, la quale ci spalanca la porta di casa sua e ci offre aaruul di pecora e di yak, nonché lo tsuivan, tagliatelle tagliate a mano con carne di montone sminuzzata ricca di grasso e cipolle soffritte. Il tutto viene offerto in una scodella, che successivamente viene sciacquata alla buona per versarvi il tè col latte. Il gusto è molto buono, nonostante la rusticità di tutto quanto ci circonda. Non nascondo che non sia stato facile ingoiare i primi bocconi, ma un non si può e soprattutto non si deve rifiutare quanto viene offerto con tale gentilezza. Prima di offrire del cibo a noi la signora ha messo un po’ di tsuivan in una scodella e l’ha posto su uno scaffale per le divinità, prima ancora ne aveva messo qualche briciola nel fuoco a ricordo dei morti. Una volta fatta l’abitudine anche al gusto misto fra selvatico e dolciastro del montone, non ci sono stati problemi per il resto del viaggio. La famiglia possiede 400 animali, soprattutto capre e yak. Sono di etnia dharkad, che vivono soprattutto nel Khuvsgul settentrionale, in condizioni che in inverno pochi potrebbero sopportare (ci dicono che le temperature raggiungono i – 40/45°C.). Effettuano 4 migrazioni all’anno. Stanno attendendo il rientro della figlia che studia a U.B. per la migrazione autunnale. L’accoglienza particolarmente calda è anche dovuta, oltre alla proverbiale generosità di questa gente, al fatto che eravamo i primi stranieri ad entrare nella loro ger. Uscendo vediamo un bottiglia di plastica da 2 lt. appesa rovesciata con il fondo tagliato. E’ un “lavandino” che si riempie e si apre leggermente il tappo per far scendere l’acqua nella quantità desiderata. La quota sui duemila mt. rende il clima frizzante ma, come per incanto, rispunta il sole e troviamo anche una pista che porta indicativamente nella direzione desiderata. Ci raccordiamo infine sulla strada principale che conduce a Khatgal, senza peraltro che questo ci consenta di aumentare la velocità di crociera, stante i continui sobbalzi. Ci lasciamo alle spalle Khatgal mentre il sole sta tramontando e costeggiamo il Lago Huvsgul passando sul lato occidentale. Anche qui la strada è infame a causa della costruzione di nuova arteria che in futuro raggiungerà comodamente i campi ger dislocati lungo il lago. Arriviamo al nostro campeggio quando sono ormai le 21 ed il buio ha avvolto le foreste che lo circondano, mentre la luna sale ad illuminare il lago come in un film. La cena è servita quasi se fossimo in un ristorante d’elite, ma fortunatamente i piatti non hanno la stessa ricercatezza. Non c’è corrente nella nostra ger e leggiamo qualche riga sul programma di domani al lume di una candela prima di assopirci.
QUINTO GIORNO
Oggi scopriamo quanta poca acqua possa bastare per lavarsi la faccia al mattino, quando ne consumiamo decine di litri in inutili quanto talvolta dannose docce quotidiane. Al piccolo contenitore metallico da ca. 2 litri è attaccato un rubinetto dal quale esce un filo d’acqua che, una volta usata finisce in un secchio e viene eliminata. Un altro secchio serve per immettere acqua fredda che può mischiarsi ad alcune gocce di calda contenute in un termos posizionato accanto. Gli inservienti controllano regolarmente lo status dei secchielli. Finisce così che per una lavata di faccia possa sorprendentemente bastare ca. ½ lt. d’acqua, mentre per i servizi igienici questa risorsa non viene usata. La si fa in WC appositamente creati, sotto i quali si trovano dei contenitori e si ricopre il tutto con della segatura. Non che manchi l’acqua, ma trovandoci vicino ad un lago di vitale importanza per i pochi coraggiosi umani che ci vivono intorno, è importante non inquinarlo. Pertanto tutti i rifiuti vengono portati via. La nostra ger ha due letti (ma nel campeggio ne esistono di più grandi, fino a 6 posti) e consta di 62 listelli che convergono verso la ruota centrale a formarne il tetto.
Un generatore a gasolio è in funzione dalle 20 alle 23 ed in quell’orario si possono portare le utenze elettriche nella zona ristorante per la ricarica. Diversamente bruciano legna per la cucina e per riscaldare l’acqua delle docce, quando il pannello solare non basta. Il lago Huvsgul è uno dei più profondi laghi di acqua dolce dell'Asia Centrale (262 m), il secondo più antico del mondo e contiene il 2% delle risorse idriche dolci del mondo, nonché uno dei luoghi più incantevoli della Mongolia, circondato da montagne innevate e fitte foreste. La zona è infatti costituita in gran parte dal foreste di taiga (conifere subartiche). Il lago ghiaccia fin quasi ad un metro e mezzo e non disgela completamente fino a giugno. In inverno diventa un’importante via di comunicazione, anche per i camion più pesanti. E pensare che siamo poco sopra il nostro parallelo.
Avendo un giorno di vantaggio su quanto preventivato dal programma, lo destiniamo ad un’escursione sui monti che cingono il lato occidentale del lago. Ci infiliamo nella foresta di larici prestando la massima attenzione a dei riferimenti presi in precedenza. E’ tutto in piano e molto fitto, pertanto bisogna arrivare alla radura situata poco più in alto nel punto esatto. La centriamo con perfezione chirurgica dopo un’ora e dieci di cammino e di lì inizia la salita vera e propria, aprendosi a paesaggi che via via si fanno sempre più ampi. Sotto di noi il lago dimostra la sua grandezza, contornato da splendide lagune che già prenotano i nostri impegni pomeridiani. Raggiungiamo la cresta e la vista spazia sul versante che dà verso l’interno, con la catena montuosa del Saridag, nonché la strada che conduce nei territori degli Tsaatan. La vetta che raggiungiamo con un balzo di 900 mt di dislivello per 1h50’ di fatica si chiama Hirbist Uul (foto), a 2515 mt., ed è la più elevata della zona. In cima si trova un piccolo ovoo, sul quale gettiamo anche noi l’offerta di una pietra ed aggiriamo in senso orario, secondo il costume locale. Alta nel cielo volteggia un aquila e tiene d’occhio i nostri movimenti, ma noi siamo venuti e torniamo in punta di piedi, senza disturbarla. Scendiamo rapidamente sotto un sole limpido per non mancare l’appuntamento prandiale, sfruttando una traccia di sentiero usata dai cavalli quando vengono da queste parti con dei clienti. Il menu prevede gli tsuivan, ma in questo caso le esigenze del turismo impongono allo chef di eliminare il grasso del montone dalla carne. Mentre nella ger nomade di ieri il grasso costituiva una risorsa contro il freddo qui sanno che i sensibili palati occidentali poco gradirebbero un ammasso di grasso intorno alla carne. Facciamo la conoscenza di un ricercatore americano, il quale di professione organizza delle fiere su Gengis Khan. E’ appena arrivato dal deserto del Gobi e ci lascia il nominativo di alcuni suoi conoscenti intenti nella ricerca di ossa di dinosauri. Se dovessimo incontrarli avremo la sua indicazione per farci raccontare delle ultime scoperte in materia.
Un’ora e mezza di meritato riposto fuori dalla nostra ger e siamo di nuovo pronti a ripartire per visitare la laguna vista stamattina dall’alto. E’ un luogo che sembra creato appositamente per le esigenze fotografiche, non fosse che il sole di tanto in tanto si cela dietro qualche nube passeggera. Una doccia ristoratrice ed ancora un momento di riposo. Una mandria di yak rientra dal pascolo creando un sipario che vede come splendido sfondo il lago.
La cena arriva puntuale alle 19,30. Si tratta di carne più simile ad un ragout pressato e cotto al forno che ad un hamburger, sovrastato dal purée. Parlando con i nostri accompagnatori, che partono da una concezione di nomadismo negli spostamenti, ci chiedono se quando andiamo in montagna spostiamo anche i mobili. Questo no, ma visti i pesanti carichi poco ci manca! Anche stasera la luna riflette la sua luce sul lago, assumendo colori sempre più dorati man mano che si alza nel cielo. Qualche pagina letta al lume di candela ed infine ci si concede un buon riposo ristoratore, aggiungendo però una coperta. Ci troviamo a 1645 mt. e fa freddo. La stufa scalda fino a sembrare una sauna, ma di lì a poco smette la sua preziosa efficacia ed il freddo s’impadronisce del locale.
SESTO GIORNO
Alle 5 di mattina un’inserviente viene a bussare per accendere la stufa nella nostra ger. Il tepore sviluppato ci dà il coraggio di uscire fuori dal letto alle 6.30. Colazione alle 7. Oggi il programma prevede l’incontro con una famiglia Tsaatan, l’etnia del popolo delle renne. Sono rimasti in 220 e vivono di pastorizia con le renne in una delle sei zone più proibitive ed inospitali del pianeta, vicino al confine con la Siberia e più precisamente con la Repubblica Autonoma di Tuva. Le temperature invernali non di rado superano i -50°, mentre la gente vive in tende coniche formate da tronchi di larici. Non più le ger ma una tipologia abitativa molto più simile a quella degli indiani d’America. Anche i tratti somatici sembrano gli stessi, confermando la teoria che le popolazioni indiane traggono le loro origini dagli asiatici che in tempi antichi migrarono attraverso lo stretto di Bering. In particolare sono proprio i lineamenti dei mongoli a portare ad un accostamento con i loro cugini americani. Anche la lingua, molto gutturale e di gradevole ascolto, sembra foneticamente imparentata con quella dei nativi d’America, sebbene lo chiamino il tedesco dell’Asia. La lingua mongola deriva comunque dal gruppo turco altaico ed ha un suono molto diverso dal cinese. Fino al 1948 si scriveva in verticale con i caratteri uiguri, poi venne adottato l’alfabeto cirillico con alcuni adattamenti necessari per l’espressione di una lingua non slava. Dicono di avere qualcosa in comune con il coreano e con il giapponese. Per un mongolo è meno difficile imparare queste due lingue, mentre scrivere è cosa assai più complessa. Il cinese resta lontano, tanto nella lingua che nella cultura.
Percorriamo i 26 km che ci portano alla tenda degli Tsaatan su una strada ricca di sobbalzi. Quando vediamo una tenda conica costruita con tronchi di larice e ricoperta da un telo impermeabile sappiamo di aver raggiunto la nostra meta. Sono già evoluti: in passato ricoprivano le tende con le pelli degli animali. Dal centro del tetto esce il camino fumante di una stufa. Pur essendo forato ci diranno che il calore del camino impedisce alla pioggia d’entrare. Sarà cosi! Entriamo e troviamo una signora vestita con un deel, che in origine doveva essere di colore viola. Ci accomodiamo sul lato destro (sinistro rispetto all’entrata) tradizionalmente riservato agli ospiti, mentre lei occupa la posizione opposta a quella d’ingresso. Dopo alcuni convenevoli che ci scambiamo con la traduzione della guida, ci chiede se abbiamo delle domande da farle. Apprendiamo così che vivono allevando 17 renne. Ha 59 anni e 6 figli, di cui alcuni anche piccoli e restiamo allibiti quando scopriamo di trovarci di fronte ad una sciamana. In quanto tale è anche l’espressione medica della tribù. Prevenendo ogni nostra obiezione ci dice che di ospedali nelle vicinanze non ce ne sono e che i riti sciamanici, a differenza delle medicine occidentali, non hanno alcun effetto collaterale. Mentre noi per curare un organo finiamo sovente per danneggiarne un altro. Troppo facile ma anche difficile per controbattere e lasciamo cadere il discorso. Appesa all’interno della tenda c’è della carne tagliata a liste, messa ad essiccare. Sull’altro lato si trovano delle erbe medicinali anche loro per essiccare. Mentre alle spalle della sciamana vediamo i paramenti che usano durante i loro riti. Riti che vengono celebrati in determinate occasioni come funerali o festività. Il loro dialetto è molto vicino al tuvano, pertanto devono parlare in mongolo, almeno per capirsi con la nostra guida. Ci vengono offerti dei pezzi di pane fritto nel burro e non lievitato, si chiama bortzig. Dall’aspetto sembrano quasi dei babà salati. Se si dimentica l’impatto devastante che potrebbero avere sui nostri fegati già falcidiati dallo stress, potrebbero anche essere buoni. L’ospitalità vuole inoltre che ci vengano offerte delle costine di renna bollite e servite fredde. Ci limitiamo ad un assaggio, mentre i nostri accompagnatori non disdegnano di banchettare. Dentro ad un wok appoggiato direttamente sul fuoco della stufa fanno cuocere del tè in foglie, vi versano il latte delle loro renne prelevato da una bottiglia di coca cola (riciclare è una necessità prima ancora che una scelta ambientalista), lo colano per separare le foglie di tè e ce lo servono dentro delle scodelle. Superiamo con coraggio la vista del colino e delle tazze e beviamo l’intruglio.
Parlando delle renne che abbiamo incontrato in quantità in un precedente viaggio nella terra dei Lapponi, ci chiedono se non sarebbe possibile fargliene arrivare alcune. La loro razza si sta indebolendo a forza di continui accoppiamenti consanguinei e la statura diminuisce. La tribù ha in tutto poco più di mille renne, certo non molte se si pensa che è quasi l’unica fonte di sussistenza. Altro problema è rappresentato dai giovani, sempre meno disponibili ad affrontare una vita di sacrifici come questa. La naturale conseguenza è il loro esodo verso le città. E’ solo parzialmente vero quanto disse un capo Tsaatan: qui nessuno è obbligato a restare, per questa ragione nessuno se ne andrà. Una particolarità di chi segue la religione sciamanica sta nelle sepolture: non seppelliscono i morti ma lasciano che vengano divorati dagli animali, attribuendo un significato diverso a seconda che a divorarli siano animali di terra o uccelli.
I bambini frequentano la scuola a Khatgal da settembre a giugno, per le vacanze estive restano con la famiglia. Anche per attendere ai lavori di loro competenza. Quello che da noi si definirebbe sfruttamento minorile lì si chiama educazione al lavoro. Altra lezione che mandiamo in memoria.
Si trovano con la tenda vicino al lago per il campo estivo, ma il resto degli Tsaatan vive nelle zone più interne raggiungibili unicamente dopo giorni di cammino a cavallo. Si intuisce chiaramente che questa famiglia è già abituata ad incontrare dei turisti. Ci chiedono 5000 T. per poter scattare delle foto all’interno della tenda, ma resta il fatto che riusciamo a scoprire una cultura ancora più remota di quella delle altre etnie mongole. Le molte sigarette viste fumare durante l’incontro e qualche bottiglia di vodka abbandonata all’interno della tenda ci fanno intuire che una sorta di contagio l’hanno comunque avuto. Hanno uno stile di vita leggermente superiore agli altri della loro etnia grazie alle entrate dei turisti. In un sacchetto che pende al fondo della tenda si trova un cellulare, presente ovunque laddove ci sia la copertura. Gli uomini passano il tempo a bighellonare giocando a carte mentre i bambini giocano allegri, raccogliendo fiori.
A poca distanza si trovano alcuni banchetti che offrono artigianato locale: manufatti in osso, guanti e ciabatte ricavati con lana di cammello ed altri souvenirs.
Sulla via del ritorno chiediamo al nostro autista di lasciarci alla laguna di ieri dove terminiamo il servizio fotografico rimasto incompleto per la comparsa di qualche nuvola. Durante pranzo apprendiamo che la grande muraglia cinese non è stata costruita per difendersi dalle armate di Gengis Khan, bensì dagli assalti degli Unni, i quali alcuni secoli prima popolavano la Mongolia ed avevano dimostrato velleità di conquista del vicino cinese.
Il menù prevede un minestra di pomodori e gli squisiti buuz. Passeggiata verso sud per vedere gli yak al pascolo, mentre si stagliano con il lago sullo sfondo. Il sole ci riscalda ancora qualche minuto fuori della nostra ger mentre facciamo una partita con gli scacchi appena acquistati, la scacchiera è naturalmente in feltro, mentre il re non poteva che essere rappresentato da Gengis Khan. La cena prevede spaghetti al ragout. Ebbene sì, sono endemici di questa parte del mondo se vennero importati da Marco Polo. Alle 19.30 abbiamo visto il sole tramontare dietro le montagne. Dopo pochi minuti il cielo si è oscurato fino ad iniziare a piovere con fulmini che proiettano degli effetti scenici sul lago e sulla foresta che lo circonda. La stufa accesa, la ger illuminata dalla luce fioca di una candela e la pioggia che cade sul telo esterno rendono l’atmosfera surreale. In questo momento non vorremmo essere altrove.
SETTIMO GIORNO
Un giro a cavallo di un’ora lungo il lago ci restituisce un senso di libertà, che il canto del wrangler vestito con l’abito tradizionale rende ancora più suggestivo. Si pranza alle 12 in punto per essere pronti alle 14. Altre due ore in groppa al cavallo, tanto è stata bella l’esperienza mattutina. Ad accompagnarci stavolta c’è anche il figlio del wrangler. Ha 7 anni e quando è in sella dimostra una padronanza come se sul cavallo ci fosse nato. Ha una gestualità da adulto per imporre al cavallo cosa deve fare, poi quando scende torna un ragazzino come tutti gli altri.
Questo ci fa capire il perché del successo di Gengis Khan. Ma è anche vero il detto che ricorda come i regni conquistati a cavallo non possano essere amministrati restando a cavallo. Costeggiamo nuovamente il lago e rientriamo passando per la foresta. Ci invita nella sua ger, straordinariamente pulita ed ospitale, dove non compaiono bottiglie di vodka. Ci viene offerto dello yogurt di yak (tarag o tarikh) e non esito a fare il bis non appena se ne presenta l’occasione. Hanno una piccola televisione in bianco e nero con tanto di parabolica appoggiata per terra fuori della ger, che alimentano con un pannello solare collegato ad una batteria da auto. Quando è ora, collegano le pinze ai morsetti, si vede una scintilla e la TV si accende. Facciamo conoscenza con la sua signora e con lei riusciamo a comunicare a gesti e con il poco inglese che conosce, mentre il marito esce a spaccare legna. Scopriamo che lui ha il titolo di Elefante dell’aimag di Khuvsgul, l’onorificenza più alta guadagnata nelle gare di lotta libera. La stazza imponente infatti faceva supporre che non fosse un danzatore classico, ma solo vedere le sue foto dove mostra i muscoli dopo una gara impone il massimo rispetto. Le medaglie sono appese al fondo a testimoniare l’orgoglio del padrone di casa, trentasettenne. Sono di etnia dharkad. La signora, che ha 43 anni ma ne dimostra persino di più, ci dice che questo è il campo estivo, per l’inverno andranno in montagna. Parendo un controsenso e temendo di non avere capito bene ci facciamo ripetere l’asserzione, ma è proprio così. D’inverno vanno in montagna dove fa un po’ più freddo ma nevica di meno e gli yak possono trovare erba con maggiore facilità. Dispongono di un parco animali composto da 49 yak e 89 pecore. Il figlio a settembre andrà a scuola a Khatgal e vi resterà fino a giugno, quando raggiungerà i genitori nei pascoli estivi lungo il lago. Il poveretto avrà un piccolo incidente la sera stessa: mentre sta spostando alcuni cavalli, altri gli passano davanti ed i suoi tendono a seguirli. A questo punto il piccolo cerca invano di trattenerli scivolando per terra e scorticandosi. Solo quale graffio, ma l’attento quanto severo ma nel contempo amorevole padre gli vieta di piangere di fronte ad altri. Non si addice ad un uomo! In effetti fierezza ed orgoglio dovrebbero essere una virtù, ma ormai tendiamo a considerarli valori superati dal relativismo.
Riprendiamo i cavalli e facciamo ritorno al nostro campo consci d’aver vissuto una giornata di vera libertà. A tal proposito, in serata incontriamo una signora americana ma nativa della Germania Est, la quale ci racconta di essere scappata 40 anni fa dalla Turingia. La fuga è avvenuta fra mille traversie insieme a suo padre, lasciando a casa il poco che avevano. Lo stesso genitore le aveva fatto promettere di non tornare mai più in quella terra ingrata, ma lei, una volta caduto il Muro e non essendoci più suo padre, è ritornata a far visita ai parenti rimasti ed ai luoghi in cui ha vissuto l’infanzia.
Lo chef per cena propone un risotto con carne e verdura, con insalata di carote e aglio tritato. Qualche alitata ci servirà per attizzare il fuoco della stufa! Per cena assaggiamo nuovamente lo yogurt che abbiamo già gustato nel pomeriggio con marmellata di mirtilli, ma è sempre un piacere. Ed è questa la risposta migliore a chi sostiene ancora che in Mongolia si mangia male. Un cielo sereno e fresco accompagna la serata.
OTTAVO GIORNO
Anche stamane passano ad accendere la stufa nella ger per farci trovare l’ambiente caldo quando ci svegliamo. Oggi c’è il vento ed è un’esperienza che ci mancava ancora. Il fresco si trasforma rapidamente in freddo ed il cielo inizia a coprirsi. Dall’interno della ger sembra che fuori ci sia una grossa ventola accesa. La sistemazione è solidissima e non si muove minimamente, persin meglio di una casa dove ci può essere il rumore esercitato dal vento sui vetri. Ci consideriamo fortunati, avere tre giorni consecutivi di bel tempo sull’Hovsgul è cosa rara. A noi è riuscito e abbiamo cercato di sfruttare appieno l’opportunità offertaci. Osserviamo da alcuni giorni come la gente sia scevra da cerimoniali. Si saluta cordialmente quando si vede ma quando ci si congeda non è necessario un rito di commiato. Si possono avere comunque ottime relazione anche senza tante formalità. Lo stesso quando si dà o riceve qualcosa. Non ci sono particolari salamelecchi, basta un grazie, sapendo che se qualcuno ha dato è perché intendeva farlo e l’espressione di riconoscenza non richiede tanti giri di parole. Aiutarsi è una cosa doverosa ed avviene così, naturalmente.
Partiamo all’alba delle 9,10 per raggiungere Khatgal in poco più di un’ora (sono sempre 26 km!). Raggiungiamo Mörön in ulteriori 100 km di strada leggermente migliore. Andiamo al locale mercato dove veniamo in contatto con la vita quotidiana degli abitanti della città. E’ di particolare interesse la zona dedita alla macelleria, dove spiccano le vesciche di montone dalle quali si ricavano degli otri e le teste di montone incellophanate con dei gusti. Solo più da far bollire. i montoni prima di essere macellati devono avere almeno due anni d’età. Uccidere un animale prima di quella data viene considerato uno spreco inutile. I negozi offrono poca verdura, soprattutto quella a lunga conservazione, in particolare patate (750 T./kg) e cipolle. Quasi tutte le case sono in legno con annesso cortile (hasha).
Visitiamo il monastero di Danzandarjiaa Khiid e pranziamo qualche decina di km a sud, lungo le sponde del fiume Delger, dove incontriamo i francesi lasciati stamattina al ger camp, mentre sono intenti a desinare.
Parlando lungo il viaggio con Andy è curioso notare come quando gli diciamo che il problema maggiore che assilla la nostra società sta proprio nel cervello, non riuscire ad avere dei valori solidi, ci chiede se neanche la religione possa più rappresentare per l’occidente un rifugio edificante.
Chi lavora come dipendente paga i contributi per la pensione e sanità, mentre gli vengono detratte le imposte dal salario. I maggiori problemi legati alla sicurezza sono rappresentati dagli incendi che si sviluppano nelle ger. Essendo di materiale infiammabile le scintille provocate dalle stufe possono provocare disastri. Anche i bambini corrono molti rischi al contatto con la stufa, tant’è che spesso vengono legati ad una certa distanza onde evitarne il contatto. Nella nostra società si configurerebbe il reato di sequestro di persona! I pompieri della capitale effettuano la maggior parte dei loro interventi nei campi ger della periferia. Il nome della prossima tappa è Shine Ider Soum (foto) che si traduce in giovane e nuovo, soum sta invece per distretto, una suddivisione dell’aimag, che rappresenta la provincia.
Proseguiamo fino al passo Khindavaa, posto a 2350 mt. di quota, con un paesaggio altalenante di ampie vallate che si possono definire altipiani, alternandosi a colli sui 1800/2000 mt. Le praterie sono molto verdi e puntinate da rare ger bianche in mezzo a vasti greggi di animali. Vicino al paese di Shine Ider, lungo una collina vediamo un cimitero nel senso tradizionale che intendiamo solitamente, con pietre poste come lapidi. Il tempo inizia a guastarsi fino ad iniziare a piovere verso il tardo pomeriggio. E’ incredibile come fino a che non piova il paesaggio resti straordinariamente fotogenico, con luci come fari che filtrano fra le nuvole. Ci avviciniamo ad una ger per chiedere il permesso di campeggiare nelle vicinanze. Ci viene accordato ed andiamo a sistemare le tende in prossimità di un ricovero d’emergenza per animali (pecore e capre), costituito da tronchi intrecciati. L’interno è palquettato da ogni genere di escrementi caprini, ma ci torna di grande utilità quando il vento aumenta e diventa impossibile cenare fuori. La cuoca allestisce una cucina all’interno e prepara il makh, tagliando le costine di montone farcite di grasso, comprate al mercato di Mörön. E’ il piatto più classico della tradizione mongola. Le mette a bollire con patate, carote e cipolle, mentre fuori la situazione peggiora fino a piovere copiosamente, di stravento ovviamente. Siamo ad una quota di 2065 mt.
Intanto arrivano anche i francesi che piazzano le tende a qualche centinaio di metri da noi. Hanno ricevuto l’offerta di trascorrere la notte in una ger di nomadi ed hanno rifiutato per non disturbare. Se ne pentiranno più tardi, quando la loro tenda verrà sferzata dal vento e dalla pioggia.
Nel frattempo cala la notte e ci rischiariamo a lume di candela e di una torcia. Ceniamo nel ristorante improvvisato con le costine bollite di montone. Una volta estratte dalla pentola, la cuoca vi aggiunge della pasta e ci gustiamo una minestrina agli aromi di montone. Bisogna solo spicciarsi, altrimenti il grasso sfreddato forma una spessa coltre sulla superficie rendendola solida e pertanto imbevibile. Forse non è propriamente il pasto suggerito da tutti i dietologi, ma in quelle condizioni risulta particolarmente utile e gradito. Stante l’imperversare del maltempo si decide di portare le tende all’interno e trasformare così il ristorante in hotel. Il profumo, al quale ci siamo ormai abituati e forse siamo perfino impregnati, non è di quelli più ambiti dalle signore dell’alta società, ma il freddo esterno è ben peggio. Non che dentro faccia caldo, tant’è che dormiamo nei sacchi a pelo con tanto di coperta, calzamaglia, pantaloni e pile. Per concludere infilo una maglietta solo per coprire la testa e riparare l’unica parte esposta. Ci ricordiamo infine della bottiglia di vodka comprata alcuni giorni fa e rimasta nella jeep per le occasioni d’emergenza. Questa lo è, e la finiamo in un amen con alcuni quadretti di cioccolata. Nonostante tutti questi espedienti la notte trascorre lenta, con frequenti risvegli dovuti al freddo.
NONO GIORNO
Sebbene dormire sia poco più di un’opinione, quando fuori inizia a vedersi il chiaro pare un miracolo. Esco fuori dalla tenda, e quindi dall’ovile cercando di muovere le membra lentamente, come se fosse un disgelo. Inizio a camminare verso l’alto come spinto da una necessità superiore. E’ quella di rimettere in circolazione un po’ di sangue. Raggiungo una modesta elevazione e mi metto a correre all’impazzata per ristabilire un minimo di tepore corporeo. Il raffreddore che era incipiente fino a ieri è diventato una vera e propria realtà. Il sole sta per sorgere imperioso e freddo, mentre il silenzio e le dolci ondulazioni delle colline ci parlano dei tempi in cui questi luoghi erano battuti dalle orde di Gengis Khan. Dopo pochi minuti mi raggiunge Bruna ed insieme commentiamo i rigori della notte. Osserviamo stupiti i nomadi che iniziano le loro attività mattutine riportando le greggi al largo e mungendo gli yak. Ci pare incredibile come questa gente possa muoversi con noncuranza del freddo, anzi, quella che per noi è una mattinata gelida, per loro è semplicemente l’inizio di una giornata estiva. L’inverno deve ancora venire, e sarà cosa ben diversa da quella che noi soffriamo adesso. Kambah ci dice che quando è uscito ha dovuto grattare il ghiaccio che si è formato sul parabrezza.
Nel frattempo gli accompagnatori hanno preparato la colazione all’esterno e Kambah ci offre una scena che fino a pochi giorni fa avremmo semplicemente definito disgustosa. Ha avanzato una costina di montone e l’ha lasciata sul cofano della jeep, tant’è che mi faccio la figura di chiedere se qualcuno ha anche pensato alla colazione dei cani lasciandola lì. Lui invece la prende e ne spolpa la carne mista al grasso, lasciandola cadere amorevolmente nella tazza del tè. Non avevamo capito, ma ora è tutto chiaro e lo sconcerto iniziale diventa quasi ammirazione. La giornata è bella e partiamo che sono le 9. Passiamo dai francesi per vedere come sono sopravvissuti e li troviamo svegli da poco ed intirizziti quanto mai. Avrebbero ancora un paio di pernottamenti tenda ma ci chiedono l’indirizzo del prossimo ger camp. L’esperienza gli è bastata e ritengono che ad una prossima potrebbero anche non sopravvivere. La loro guida, una ragazza, ha dormito nella sua canadese e sembra abbastanza reattiva, mentre il loro autista ha accettato di buon grado l’ospitalità offerta dai nomadi.
Si parte in direzione della provincia di Arkhangay. Il paesaggio continua ad altalenare delle belle montagne basse (l’altezza media della Mongolia è di 1580 mt. slm). A poche decine di km dalla partenza vediamo dei cumuli di pietre che sono tombe di epoche antiche, risalenti a oltre mille anni fa. Giungiamo a costeggiare il fiume Ider fino al momento in cui dobbiamo superarlo con un ponte di travi in legno, la cui vista ci gela ancor più della notte appena trascorsa. Prima di attraversarlo ci raccomandiamo a tutti i santi di nostra conoscenza e, una volta giunti sull’altra sponda, alleggeriamo il carico psicologico con alcune foto all’opera dello scampato pericolo. Vediamo dei boschi di larici secchi e ci viene detto che la causa sono degli insetti che stanno distruggendo intere vallate. Sembra che sia stato trovato un rimedio ma lo scempio rimane. A metà mattinata ci fermiamo in una gher per un tè salato ed assaggiamo il burro di yak (rinomato per la sua carica di lipidi) con gallette di aaruul. I padroni di casa sono contenti dal momento che ci vedono mangiare di gusto. Di solito vedono degli stranieri molto schizzinosi che avanzano quanto loro offrono gentilmente. E’ proprio il caso di dire che restiamo tutti soddisfatti. Sono ancora nel campo estivo ed a breve si sposteranno in quello invernale. L’ambiente è pulito e pensiamo di sdebitarci della loro generosità regalando loro alcuni oggetti che abbiamo portato all’uopo, in particolare per i bellissimi bambini. A loro volta i nomadi, per tramite delle delicate mani dei loro figli, ci offrono ancora dell’aaruul da portare con noi durante il viaggio. Risaliamo una vallata per giungere ad un colle, incrociando dei camion, molti dei quali sono carichi di assi di legno e non ci spieghiamo come riescano a restare in piedi nonostante la strada ed il carico. Sono di solito dei vecchi Ural di fabbricazione sovietica; stupisce poi come riescano a scendere con i rimorchi. La strada si dipana tra monti e vallate, e dal punto più alto si può godere di un panorama splendido, con boschi di larici che si alternano a praterie. In breve raggiungiamo il bellissimo lago Lago Terkhin Tsagaan circondato da crateri di vulcani spenti, il più "giovane" dei quali è il Khorgo. Il Vulcano Khorgo ha un diametro di 200m. e una profondità di 100 mt. I torrenti di lava provenienti dal vulcano hanno bloccato il fiume Terkh, formando il lago. Ci sistemiamo nel ger camp quando ormai sono le 13,45, situato a pochi metri dal bacino posto a 2080 mt. di quota, sotto un vento freddo che inibisce l’azione solare. Si pranza nel ristorante del camp con un ragout di carne con patate fritte. Il vento diminuisce leggermente e ci spostiamo di una decina di km per vedere il cratere del Khorgo. Facendo il giro lungo il bordo del cratere il vento è molto forte ma la vista è appagante del sacrificio. Rientriamo per fare qualche foto dall’alto del ger camp ed un po’ di relax prima di cena. Facciamo la conoscenza con una coppia di genovesi ed una guida che parla italiano. Si chiama Zulaa ed è una studentessa ventiduenne appassionata dell’Italia tanto da studiare la nostra lingua all’università di U.B. Ci offre quella che qui chiamano la vodka mongola, ovvero latte fermentato con una gradazione di ca. 12°. Della vodka ha solo il colore trasparente ma è buona anche se conserva sempre un retrogusto abbastanza marcato di prodotto caseario. Nel frattempo arrivano anche i francesi, ben contenti di non dover più campeggiare in tenda. Vediamo una semifinale di box alle olimpiadi, che vede vincere il concorrente mongolo e qualificarsi per la finale. Una passeggiata digestiva mentre il vento si sta chetando e riassaporiamo il piacere di dormire in una ger calda.
DECIMO GIORNO
Il fuochista si presenta in ritardo ma il freddo è in qualche modo gestibile. La guida resta addormentata e dopo colazione dobbiamo attenderlo per tre quarti d’ora prima di partire. Cosa che avviene alle 9.10 h. Il Paesaggio dell’Arkhangay è meno bello di quello del Huvsgul. Gli altipiani sono più piatti ed il paesaggio diventa più monotono, mentre l’erba assume delle tinte più giallastre. Significativo di come sia più arido. I boschi lasciano lo spazio a praterie sterminate mentre spariscono i torrenti. Il cielo risulta velato anche se non ci sono dubbi in merito alle precipitazioni.
Ci fermiamo per vedere la gola formata dal fiume Chuluut, un vero canyon scavato dal tempo. Nelle vicinanze si trova il Zuun Salaa Mod, l’albero dei cento rami, ricoperto di sciarpe di preghiera ed offerte di vario genere, che il nostro pensiero non può non accostare ad un grande mucchio d’immondizia. A metà mattinata facciamo uno stop in una ger di nomadi, come la fermata che faremmo per prendere un caffè al bar. Sembra quasi d’essere invadenti ma il costume e quello, inoltre tanto noi che gli accompagnatori lasciamo dei regali quando non un contributo in denaro. Del resto questo è l’unico modo per renderci conto della vita che fanno gli indigeni ed aprirci alle reciproche culture. Anche qui ci accolgono volentieri e ci fanno assaggiare l’airag, il latte di giumenta fermentato. E’ fresco ed ha un gusto acidulo frizzante da poterlo paragonare ad una gazzosa, stante l’inevitabile retrogusto di latte. Il tutto accompagnato dagli immancabili aaruul. Impariamo anche che una volta tolto il burro si prepara l’airag con il latte rimasto, rimestandolo e facendolo così fermentare. Si aggiunge dello yogurt, si rimescola il tutto