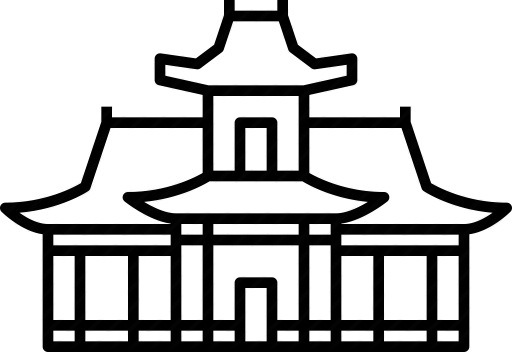Verso Oriente - Cronaca di un viaggio in Mongolia
Trascrivere un “diario di viaggio” in una forma definitiva comporta la necessità di scelte stilistiche comprensibili a chi legge. In occasione di un viaggio precedente, come per questo che mi accingo a raccontarvi, mi è accaduto di percepirmi non unico ‘autore’, ma co-autore, insieme ad altri, da cui ho tratto spunti, suggerimenti, annotazioni.
Questo viaggio, per la maggior parte in Mongolia, deriva da uno stimolo che definisco cultural-musicale – chi mi conosce sa qualcosa di questo pungolo: si tratta dell’ex gruppo musicale dei CSI (Consorzio Suonatori Indipendenti), ormai scioltosi. Non è questa la sede per narrarvi la loro storia, gli influssi e gli stimoli che ne sono scaturiti e che, perseguiti e sviluppatisi, sono ora parte concreta della mia esistenza. Vi basti sapere che il gruppo ebbe, nel 1997, occasione di fare un viaggio in quelle lande, apparentemente prive di attrattiva. Ne usci uno splendido cd, Tabula Rasa Elettrificata, e un volume, In Mongolia in retromarcia, pubblicato nel 2000 da Giunti, editore di Firenze. Così, come per un resoconto di viaggio precedente a questo, accadrà che la mia voce narrante si mescolerà a quella di canzoni del gruppo, a libri letti, a brani citati, senza soluzione di continuità.
Poiché è sacrosanto dare a Cesare quel che è di Cesare, la scelta stilistica consiste (1) nel mettere tra parentesi ciò che cito, ciò che al mio narrare si sovrappone, si impone, o resta semplice sottofondo e (2) di segnalare in nota i precisi riferimenti bibliografici, eccezion fatta proprio per Tabula Rasa Elettrificata, pilastro e colonna sonora del mio peregrinare: non è cattiveria, ma solo un modo per non appesantire eccessivamente la notazione e invitarvi all’ascolto dei CSI.
Chinggs Khaan hotel, Ulaan Baatar (Mongolia)
Pascolano le nuvole, nel cielo di Ulaan Baatar. Grandi greggi. Unico pastore, il vento. Nuvole bianche come lana di pecora, che abbiamo toccato con le ali del Boeing 737 Air China sul verde rasato e brullo [convergono le mandrie alla piana / muovono lentamente l’orizzonte / punti neri punti bianco bigi bruni / tutto il verde per terra / pozze d’acqua di piombo / nastri d’argento i fiumi / neanche un’ombra. / ci volano le gru non ancora convinte / che sia tutto finito / meraviglia d’un mondo d’età ruvid’acerba (3). Spazia lo sguardo su tutto ciò che c’è intorno e nulla sembra ottundere i sensi, risvegliati dalla luce turchese del cielo.
Siamo passati, in un paio d’ore, da una situazione al suo opposto: da una densità di popolazione spaventosa ad una scarsità altrettanto considerevole: tutta la popolazione della Mongolia è riassumibile nella città di Napoli. Un terzo di questa popolazione vive nella capitale (circa 800.000 persone), mentre il resto è sparso nelle regioni circostanti, densamente spopolate [densamente spopolata è la felicità]. In compenso ci sono circa 33 milioni di animali tra pecore, capre, mucche, cavalli e cammelli. Visitiamo, appena arrivati, il monastero del lama Choijn, unico superstite alla rivoluzione culturale, stavolta non cinese ma russa.
Architetture originali e ben conservate, di pregio gli originali di alcune statue bronzee di Zanabazar (1635-1723), raffiguranti Buddha. Fedeli al motto nietzschiano di “eliminare la poltrona di Dio” e a quello di Marx per il quale “la religione è l’oppio dei popoli”, i russi hanno se non altro avuto il buon senso e il buon gusto di risparmiare l’opera di quello considerare l’equivalente di un Michelangelo o un Canova asiatico.
Ulaan Baatar è una città architettonicamente sghimbescia, sbilenca, disarmonica, con palazzi ultramoderni giustapposti a edifici fatiscenti, ad architetture “soviet” e cinese, frapposte a cartelloni pubblicitari (come in Cina, come da noi) che magnificano le doti di automobili e telefoni cellulari, su uno sfondo di ciminiere fumanti nate in mezzo al nulla desertico di cespugli d’erba verde e rada. Il tutto immerso in un traffico stradale incomprensibile. Il nostro autista – che segaligno e scuro di pelle vedrei molto meglio su un bel cavallo che alla guida di un bus – è riuscito letteralmente a far volare la nostra guida locale che, in piedi e voltata verso di noi, cercava di spiegarci qualcosa: frenata brusca e la guida, poverina, è scomparsa ruzzolando sugli scalini della porta anteriore, fortunatamente chiusa. Alla seconda frenata un po’ decisa ho capito che era meglio per me fare viaggi disorganizzati: le lamentazioni della prima frenata si sono trasformate in un coro di proteste del quale mi sono un po’ vergognato. Un po’ per il tono, un po’ perché del tutto ingiustificate, visto che semplicemente l’auto che precedeva ha inchiodato in mezzo alla strada senza apparente motivo. Limite di appartenenza ad un gruppo over 55: scarsa adattabilità a ciò che è altro dai propri standard.
La polemica è poi proseguita a seguito di una incomprensione sulla sistemazione per la notte. Da programma avevamo il pernottamento in albergo, mentre l’agenzia mongola aveva previsto – sorpresa! – un’accoglienza al campo nomadi, con tanto di festa di benvenuto e dormita in tenda. A me andava bene un po’ tutto, ma non così per tutti. Qualcuno ha malignato che la sorpresa fosse organizzata ad arte per evitare di occupare l’albergo per una notte: pare che in coincidenza del nostro arrivo ci sia un’importante fiera (e corsa) di cavalli, che attira un po’ di persone. Più conveniente per l’albergo offrire letti per più notti. Dopo qualche telefonata intercontinentale e qualche manager tirato giù dal letto in Italia, pare che la questione si sia risolta: siamo, come da programma, in albergo. Ho deciso per vacanze serene e alla fine sono abbastanza contento che queste beghe se le sbroglino altri. Da come si sono evoluti rapidamente gli eventi però devo dar credito alla voce maligna, che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Virtù di appartenere al gruppo over 55: molti del gruppo hanno grande esperienza di viaggi organizzati e per molti si tratta di un film già visto [voglio ciò che mi spetta / lo voglio perché mio / m’aspetta].
Ho fatto poche foto. Solo oggi avrei dovuto scattarne almeno una trentina, soprattutto ai mongoli, che trovo un popolo bellissimo. Solo che mi sentivo idiota e marziano a far foto alle persone, e ti ci senti anche quando sono tutti gli altri a farlo al posto tuo, perché alla fine anche tu appartieni a quel gruppo. Non c’è niente di male nel voler scattare foto agli altri, ma la percepisco come una questione di pudore, di tatto: preferisco, per quanto posso, documentare il mio viaggio con le parole.
Dopo il monastero/museo siamo andati alla piazza più grande della città, una sorta di Tienanmen in miniatura e, ovviamente, molto meno popolata: sulla sinistra il mausoleo – per fortuna in via di smantellamento – dell’ultimo dittatore filorusso. Lo stile, al solito, è l’indefinibile razionalismo che sembra essere stata l’arte preferita da tutti i totalitarismi, dal fascismo al comunismo.
Anche qui qualche (meno insistente) pletora di questuanti e venditori, vera vittoria del capitalismo: i primi contatti con un altro popolo, con un’altra civiltà sembrano passare nei tempi moderni invariabilmente attraverso la dura legge del mercato. Il solo essere turista significa questo. È una cosa che mi pesa un po’: mi piacerebbe avere amici nei posti, ma è difficile quando il rapporto è professionale e – come nel caso delle guide locali, per esempio – è pure occasionale.
Passiamo davanti a un quartiere del quale avevo letto: alcuni nomadi, stanchi di esserlo, hanno piazzato definitivamente le loro gher e le hanno rese stanziali. Oppure hanno costruito una casa in muratura e hanno messo la gher in giardino, per andarci ogni tanto. È buffo per noi, ma il nodo – simbolo del nomadismo, perché ha facoltà di essere sciolto – si trasforma in chiodo – simbolo dell’animale/uomo stabile, stanziale (4). Il problema è che sempre più famiglie operano questa scelta per problemi ovvi, il primo dei quali è mandare a scuola i figli. Al termine del solito ristorante per turisti, veniamo intrattenuti da un concertino in abiti tipici. Siamo gli ultimi avventori e praticamente questi suonano solo per noi. Apprendo da qualche compagno di viaggio che il cantante sfrutta una tecnica particolare – chiamata il canto di gola – per far funzionare le proprie corde vocali simultaneamente. Esce dalla sua bocca una strana melodia, più simile a uno strumento che alla voce umana. Ne vengo suggestionato al punto che mi vengono i brividi, perché mi sembra che canti l’ululare del vento siberiano. Quel vento che fa della mite Ulaan Baatar di oggi un posto che, d’inverno, arriva senza difficoltà a –35°C (3).
Campo base di Elsen Tasarhal (Mongolia)
Il tempo rallenta qui al campo base [rallenta il mio respiro / scende in profondità / si adatta al soffio del mondo (4). Siamo a gruppi di 2 o 3 nelle gher. Stamattina la polemica è proseguita e c’è stato un nuovo scontro tra nodo e chiodo: non possiamo portare tutti i bagagli sulle jeep e si rende necessario selezionare ciò che più ci sarà funzionale per questa escursione di 3 giorni. Lamentele e proteste si levano perché pare che molti non siano attrezzati adeguatamente o, più semplicemente, non abbiano borse o zaini nei quali stipare un bagaglio più piccolo. Riesco, pensandoci 10 minuti, a fare un solo zaino da 30 litri, nel quale metto tutto. Bagaglio minimo, macchinista ferroviere! Le esigenze del nomadismo (per quanto praticato come turismo), del viaggiare leggeri (5) si scontra con la pesantezza, il fardello di chi da sempre nasce, vive, frequenta case in muratura. Pare che i mongoli ci mettano un’ora a smontare la propria gher. Più o meno quel che noi impieghiamo per prepararci a uscire di casa dopo esserci sistemati un po’.
Una volta chetata la questione, siamo pronti a partire, non prima però di una visita al monastero di Gadanteng Cheling, quasi del tutto ricostruito dopo la fine della dominazione comunista (circa 1990). Vediamo un altro maestosissimo Buddha (ricostruito nel 1996), alto 26 metri, di rame, ricoperto d’oro. L’interno, cavo, contiene le offerte. Mi trovo a girare, senza pensarci, i rulli della preghiera: non ho, in questo momento, desideri da esprimere. Posso solo ringraziare della pienezza che sto vivendo, del desiderio esaudito di essere qui, ora. Il cilindro dei rulli mi affascina per l’idea di ritorno, di tondo, di ciclicità, di reincarnazione. Di presenza.
Facciamo “irruzione” in un’altra ala del monastero, mentre ci sono dei monaci in preghiera. Pare si possa. Siamo figure sullo sfondo. Un odore caprino mi assale le narici, poi, ma solo dopo, d’incenso. Possiamo girare intorno e parlottare tra noi. Non sono disturbati. Del resto è un po’ come da noi quando si dice messa: non è vietato entrare. Altre analogie col cattolicesimo (frutto di sincretismo?): ieri all’altro museo/monastero la raffigurazione di paradiso, inferno e una specie di purgatorio. Oggi chicchi di cereale (orzo? Segale?) vengono lanciati dai monaci durante la preghiera. Sono beneauguranti (e i fedeli li raccolgono) come forse lo è da noi il rametto d’ulivo per la Pasqua.
Per tornare al viaggio fin qui: vengono approntate 5 jeeppone nipponiche per i nostri molli fondoschiena occidentali. Si presentano all’albergo, gli autisti, con le auto lucide e loro vestiti di tutto punto, come dovessero portarci al gran gala anziché in qualche remota località desertica. Il fuoristrada Nissan che ci accoglie credo abbia un utilizzo promiscuo: lo tradiscono i chilometri (227mila e spiccioli) e, come al monastero, un odore pecoreccio, mistificato e vanamente camuffato da una specie di “arbre magique” locale. Di nuovo vengo colpito dalla totale giustapposta disarticolazione di questa città: giocatori di biliardo (6) ai bordi della strada, sotto una tenda improvvisata, vicino alla casa dello sciamano (che magari è uno dei giocatori…), vicino al mercato.
Superiamo nel traffico gorgogliante, ingorgato peggio che da noi, un filobus che sembra stare in piedi solo perché ha le antenne attaccate ai fili; in alternativa pulmini di modeste dimensioni fanno da trasporto pubblico; vecchi camion Uaz sovietici che neanche da bambino avevo il modellino: musone, piano di carico alto sopra le ruote, aerodinamica anni ’50/’60 del secolo scorso, verdi militare, forse dismessi dall’esercito. Ne incontreremo di simili lungo il percorso, molti dei quali invariabilmente con la bocca del cofano aperta, bisognosi di cure d’emergenza. Ai lati del lembo d’asfalto, terra, senza marciapiedi. E ancora: città oblunga, come fosse in rifacimento dopo una guerra, ma senza apparente criterio. Mi scorre davanti al naso il cartello che pubblicizza la prima televisione mongola via internet: TV5.mn. Per il 5 nutro, scusate, berlusconiano sospetto. È tutto giustapposto, non stratificato in epoche: tutto coesiste insieme. Oggetti che arrivano da passati remoti (per noi, ma forse sarebbe meglio dire presenti prossimi per loro) con oggetti, idee, velleità proiettate verso un futuro che è, in tutto e per tutto, il nostro.
L’insieme, per le strade, mi stordisce, mi sbilancia e mentre mi godo pascolante nella mente e nello sguardo tutto questo, vedo, con la coda dell’occhio, l’auto davanti a noi con gli stop accesi e culo alzato dalla frenata brusca. Il nostro autista, che gli alitava sullo scarico nella modesta velocità cittadina, con prodezza e prontezza non tocca freno e scarta di lato. Lo manchiamo per uno zip, però lo manchiamo. Fuori dal gorgo cittadino il lembo di strada si assottiglia: l’asfalto diventa un’idea, una supposizione, mentre ben più concreti si fanno i crateri, le buche da evitare. Dopo qualche chilometro non esiste più un vero e proprio senso di marcia: diventiamo serpente che zigzaga a destra e sinistra per evitare il peggio, mentre stai sulla tua destra solo quando arriva qualcuno in senso inverso. Il problema spesso si pone quando un mezzo più lento ti precede nello zigzag e per fargli capire che non vuoi centrarlo, ma solo sorpassarlo, gli suoni. Il clacson anche a Ulaan Baatar è molto usato come mezzo di comunicazione. Lasciata la città trovi carovane, zone semiresidenziali, prototipi di fattorie in bilico fra nodo e chiodo.
Campo base di Tsenkher (Mongolia)
La tortura più grande, alcune volte, è non poter scrivere quando si vorrebbe. Devo munirmi di registratore portatile: così parlo. Ma dovrei essere solo. E, in un viaggio organizzato, questo non accade quasi mai. Fine della lamentazio e della parentesi. Credo che la mia scrittura subirà un’evoluzione. Cercherò di evocare immagini, foto. Tutte quelle che non ho scattato perché sulla jeep in corsa (7) quelle per cui il momento e la situazione mi sono sembrate degne di un racconto.
La strada. Ieri. Alla prima sosta pipì gli autisti si allontanano e sul prato di fronte espletano il loro bisogno. A noi, che eravamo di qua dalla strada, è sembrato controvento: che siano capaci di controllare anche quello? Lo sterrato di fianco alla strada, quando la strada c’è, serve ai veicoli lenti. Più si va avanti più la strada è pista, è idea, è direzione per andare verso il luogo nel quale si vuole arrivare. E le jeep rivelano sempre più il loro motivo d’essere strutturate in quel modo, la loro efficacia di automobili. [La macchina, signore e signori, è un mezzo di trasporto, ma non come voi lo intendete. È un vettore mistico, una rivelazione in atto della potenza e della fame, del genio e della miseria. È l’impeto senza nome della specie. È la materia che vuol sorpassare se stessa. È un trasporto passionale, fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, Prospero Ariel e Calibrano. Le avanguardie appaiono lente e fiacche, povere e goffe, sempre in retroguardia rispetto a questa concentrazione di materia e lavoro, di brutalità e volo, di dentro e fuori, nella pressione costante del presente. Mai contenta, la macchina del cervello, sempre in movimento, incapace di stare. […] Dio è il grande meccanico e Ayrton Senna il suo profeta, il suo figlio malinconico e prediletto (8).
Buchi, crateri, balzi, sorpassi. Ci fermiamo quasi con cadenza regolare. I pali della copertina di Tabula Rasa Elettrificata ci accompagnano, ci lasciano, attraversano la nostra strada. Ad un confine [il confine è d’aria e luce / aria e luce] sul nulla, immaginario, immaginato, di pura convenzione, probabilmente con una provincia più ricca, la strada migliora di colpo: asfalto liscio con addirittura una striscia di mezzeria. Un lusso. I chilometri corrono più veloci sotto le ruote. Il verde deserto ondoso, uguale a se stesso, muta continuamente toni, specchio del cielo. Di colpo, senza cartelli, senza preavviso, usciamo fuori strada, con regolare freccia a sinistra.
Strada immaginaria, immaginata, in mezzo a cespugli che solo successivamente scoprirò quasi totalmente di artemisia. Ci raccordiamo ad una pista, ad una traccia che non sia direzione arbitraria. Scorgiamo in lontananza la nostra destinazione: il campo tendato di Elsen Tasarhal. Prendiamo possesso delle gher, dopo pranzo. Voglio sorvolare per i pranzi, molto per turisti, credo. La prospettiva falsata del turista. Il problema è che turista sono, ma non vorrei esserlo. So che è contraddittorio, ma è così. È una cosa che un po’ m’infastidisce, mi indispone. Cerco in Mugi (9) la nostra giovane giuda mongola, un contatto che vada al di là della disponibilità compresa nel prezzo – so che molti di voi stanno malignamente fraintendendo, ma non importa. Preferisce parlare inglese, anche se è stata in Italia 2 anni. Sono contento: del gruppo nessuno osa spiccicar parola (a parte la guida) e, si sa, in un gruppo di ciechi chi vede da un occhio è quello sano.
Ci riportano a fare un giro con le jeep, non paghi dei 280 km di oggi. Andiamo poco lontano, alle dune. Mugi mi spiega che questa duna praticamente parte dalla Mongolia del nord e, per uno strano gioco di correnti, viene sospinta dal vento siberiano verso sud. Un vento che spira costante, solo in quella fascia. Incredibile, come il film La storia del cammello che piange. Mi dice di averlo visto e che l’episodio del violino non è del tutto di fantasia. Proprio come nel film passiamo davanti a una gher con pannelli solari e parabola (altra foto mancata, dalla jeep…); come nel film vediamo cammelli tosati. Pascoliamo, con le macchine fotografiche. Solo, che al solito, gli umani rompono i coglioni e, con regale altezza, i cammelli si voltano di culo, così le foto smettono.
Ho rischiato di continuare a scrivere stasera, a luce di candela. Rischio ovviamente ben accetto. Come con accettazione mi rassegno alla pila scarica della macchina fotografica digitale, per domani. Unico modo di impressionare pellicole: la scrittura che fluisce come esigenza fisiologica. Dopo i cammelli, si diceva, la duna. Una grande duna di vera sabbia desertica in mezzo al deserto dei cespugli. Un vento che sembra soffiare solo per lei, creando effetti bellissimi di trasporto di sabbia sulla superficie. Saliamo. Sento la camicia che si gonfia, che fa vela, che non si cheta [Il mio viso si intontiva / davanti al tuo parlare difficile / c’era da indossare subito / una camicia hawaiana / e sventolare contento / davanti a un cielo primitivo (10) Impronte. Di noi. Del nostro effimero passaggio. [Capita, in questo fuggevole passaggio, di illudersi nell’ascolto di voci del tempo andato, di illudersi di parlare con voce che resista per sempre. Ma il frantoio non ha pietà. E il sapore dell’olio, anche il migliore, di qualità intensa e persistente, maturato tra siccità sasso sole e silenzio, dura ben poco. Se pensi alle stesse montagne come fluide onde geologiche, loro che appaiono imponenti e imperiture, la tua smania di permanenza si traduce nel vapore del palmo della mano impresso sulla finestra di un giorno d’inverno. Guardi fuori, distratto, e il tempo è già passato (11). Così è. Anzi così ripenso quando arriviamo alla tenda di alcuni pastori da cui assaggiamo l’airag, la bevanda alcolica derivata dalla fermentazione del latte di cavalla o di yak. Il nostro impatto turistico mi fa venire la tentazione di rimanere chiuso dentro la jeep o, ancora meglio, di avviarmi al campo a piedi.
Entro per l’unica mediazione tra me/noi e loro: Mugi che parla la nostra e la loro lingua. Mi sembra di essere uno di quegli antropologi idioti che va a ficcanasare nelle vite altrui, come se gli altri fossero marziani. Non siamo richiesti. Bastare a sé. Noi occidentali sembriamo non bastare mai a noi stessi. Assaggio volentieri e con riconoscenza ciò che mi porgono: latte, yogurt, airag. Forse per smorzare la discrasia creatasi nella gher, tra noi e loro, tra quelli con le macchine fotografiche – e dai, mettetevi in posa che vi facciamo una foto – e i pastori che mettono a disposizione tutto, senza chiedere nulla, gli autisti improvvisano un gioco cantato, cadenzato come una nenia, simile alla morra cinese.
Chi perde beve. Airag, ovviamente. Il lato positivo è che anche loro sono curiosi di noi, almeno quanto noi di loro. Lo percepisco dagli sguardi: “ma che ci fate voi qui?”.
Pali della corrente elettrica da fotografare. Ancora sulle jeep. Destinazione: un montarozzo granitico poco distante. Con le jeep tutto è strada. Con le ruote schiacciamo artemisia. Così dalle bocchette di aerazione oltre alla polvere entra uno splendido profumo. Colonna sonora: Kocani orchestar. Le colonne sonore varieranno, ancorché invariabilmente occidentali (turismo è turismo, come business is business…): saranno le più suggestive e, al tempo stesso, le più surreali.
Chiedo a Mugi se vuole fare una passeggiata fuori dal campo, dopo cena. Giusto per far quattro chiacchiere in ital-english. Worst english, I’m sorry. Parliamo di tutto, a ruota libera: dalla politica alla cosmologia, da Gengis Khan alle ambizioni personali. I cani del campo ci seguono, pastori dal riflesso condizionato a fare il loro dovere e ai loro occhi probabilmente non siamo tanto differenti da pecore, mucche o altro. Ci ronzano intorno, concentrici, mentre avanziamo nel buio. Nomadi pure loro, un po’ pulciosi e spelacchiati, hanno l’andatura del cavallo. Prossimità delle quattro zampe. Nomadi, ma col senso del territorio: evidentemente, senza accorgerci, abbiamo sconfinato e i cani, dall’altro confine, sono venuti ad accoglierci, ringhiosi.
Cambiamo strada e discorso per evitare che si azzuffino, mentre sopra le nostre teste la volta celeste si fa indicibile. Via Lattea (si dice così anche in mongolo!), centro della galassia della quale – con il solo sguardo suggestionato – sembra di intuire lo scoppio di supernovae distanti anni luce. Torniamo al campo. A mezzanotte, come da programma, spengono tutte le luci, così cessa anche il modesto inquinamento luminoso locale: adesso è buio, anzi è IL BUIO, quello dei primordi, dell’uomo di Neandertahl. Prossimi alla notte di S. Lorenzo vedo un numero considerevole di stelle cadenti, anche senza andarle a cercare. Le vedo incorniciare di tanto in tanto il volto di Mugi, mentre parliamo. Se per noi è motivo di espressione di desideri, per i mongoli il periodo delle stelle cadenti non è una cosa di cui gioire: per loro ogni stella è un uomo e, per ogni stella che cade, un uomo muore. Mi sembra di capire, più in generale, che tutto quel sta in cielo è, per questo popolo, sacro. Non cacciano né mangiano uccelli e come i tibetani usano (o forse usavano) fare a pezzi i propri morti e darli da mangiare agli avvoltoi. Usanza che a noi sembra barbara, ma se lo spirito dimorava nella carne del defunto, quella carne, dopo essere stata mangiata, torna, attraverso l’animale, al cielo. Lo spirito si ricongiunge al firmamento, per via della carne, per via dell’uccello che la mangia, preparandosi ad una nuova reincarnazione, a dimorare in nuova carne che nascerà. È il momento della buonanotte. Alzo ancora, magnetizzato, gli occhi al cielo. Sembra di scorgere la carie nei denti di Dio, o forse la pagliuzza nell’occhio di Buddha. Che sia una buona notte, Mugi. Che tutti i tuoi desideri di giovane donna che ha già visto molto, si realizzino [We can see together / the beauty of souls / hidden like diamonds / in the clock of world (12).
La mia, di notte, buona non sarà. Sulla duna oggi Mugi mi ha mostrato un piccolo coleottero. Con candore mi ha detto che può involontariamente infilarsi nelle orecchie e non aver più voglia di andarsene. Sto per prender sonno e mi sveglio di soprassalto perché mi sento camminare su una gamba. È lui: lo afferro e lo lancio stizzito in mezzo alla gher. Fatico ad addormentarmi, al pensiero stupido dell’insetto dentro l’orecchio. Avevo chiesto ai compagni che condividono con me la tenda di lasciare aperta la finestrella in alto; visto che non è freddissimo avrei potuto starmene a guardar le stelle, in attesa del sonno, comodamente sdraiato nel mio letto. Niente da fare. Tutto chiuso. Ancora chiodo contro nodo. E chiodo vince.
Alle 9 stamattina tutti in pista. Destinazione: qui, da dove scrivo. Adesso a lume di candela, per gruppo elettrogeno in ferie. Terra battuta, di nuovo asfalto, ma per poco. Su un lungo rettilineo, dopo una curva il nostro autista calcola male o non vede l’auto di fronte, un’altra jeep, durante un sorpasso. Ero dietro e distratto dal paesaggio, per fortuna e solo all’ultimo mi rendo conto di quel che sta accadendo. Evitiamo per una manciata di centimetri un frontale a velocità sostenuta che avrebbe interrotto le nostre vacanze e forse non solo. Passiamo millimetrici tra il furgone che stiamo sorpassando e l’auto in senso contrario. Complimenti per il sangue freddo. Poi ricordo le parole di Mugi ieri sera. Parole che spiegano molte cose: gli autisti sono professionisti che fanno parte di un’agenzia statale.
Il loro mestiere è portare a spasso personalità e membri di stato. Solo che quando i ministri e il presidente sono in vacanza bisogna continuare a vivere, così portano a spasso i turisti, anche se non siamo esattamente corpo diplomatico. Si spiegano quindi le frontiere (sul nulla) passate con un cenno della mano, la grande perizia nella guida, la conoscenza capillare del territorio, la disposizione “a flotta” delle auto quando ci fermiamo e l’ordine durante la marcia (siamo sempre stati la quarta auto). Si spiegano i bei vestiti del nostro autista. La gentilezza – quasi una seconda natura – di aprirti la portiera dell’auto una volta fermi.
Il sole spunta, in mezzo alle nuvole, dallo specchietto retrovisore. Pare non abbia intenzione di sorpassare. Anzi, poco prima della visita a un “ovo”, una sorta di pilone votivo formato da un cumulo di sassi, inizia una pioggia via via più fitta, incalzante. Mugi ci offre un paio di possibili spiegazioni sull’origine di questi “monumenti”, formati da cumuli di sassi e sciarpe da lama. Quella che mi rimane in mente è la versione più laica: anticamente ogni soldato che si recava in guerra lasciava una pietra in quello che poi diventava un cumulo. Tornando sottraeva nuovamente una pietra al cumulo e, per differenza, le pietre che rimanevano costituivano l’equivalente spannometrico (non tutte le pietre hanno uguali dimensioni!) delle perdite in battaglia. Insomma: memoria dei caduti. Non capisco se questo è legato in qualche modo al buddismo e il perché, oggi, dell’usanza di lanciare (come voto? Come offerta?) tre sassi nel cumulo e fare tre giri in senso orario. Sempre tre? Perché non uno? Ho chiesto, ma neppure lei lo sa. So troppo poco.
La pista è sempre più pista. Più Camel Trophy. Più roba da motocross. Le jeep reggono tutto e anche noi dentro di loro. Salti, buche, un fondo bastardo che è terra dura e poi di colpo sabbia nella quale senti affondare e scodare le 2 tonnellate abbondanti della jeep. Un leggero controsterzo, di nuovo il cambio di fondo, qualche altro salto e tutto si aggiusta. Indicatori sulla via da seguire: inesistenti. Da questo dettaglio capisci che in Mongolia non puoi andare senza un indigeno che conosca un minimo di lingua franca, con la quale poter comunicare. Ammesso e non concesso che l’indicazione la trovi, è scritta in cirillico. Ma sapere il russo non serve a niente perché semplicemente la scritta è una traslitterazione del mongolo!
Arriviamo a guadare torrenti, prima di giungere sulla dirittura di arrivo di una corsa – manco a dirlo, di cavalli – riservata ai piccoli (cavalli, 2 anni, e bambini da 5 a 12). Ci godiamo in diretta lo spettacolo e ci fermiamo per la premiazione, marziani. I bambini soprattutto ci guardano come se lo fossimo. Curiosi come faine, ci fissano. Tentiamo di mimetizzarci in mezzo agli altri, ma senza successo. Anche perché – al di là delle ovvie differenze di abbigliamento – siamo senza cavallo. Troppo evidenti, troppo diversi. Mi appare evidente il motivo di tanta grazia e bellezza (scoperta dell’acqua calda): l’armonia con la terra, che li forgia come lo scultore fa con le statue. Lineamenti corpi sorrisi canti cadenzati rituali per premiare cavallo e cavaliere vincitori, ma anche tutti gli altri. Una sorta di Nadaam in miniatura.
[Infine ci sono sempre, ovunque, i cavalli. L’autore, come fosse davvero il vecchio nomade seduto nella jurta (13) li conosce, li ama, li ricorda a uno a uno. Quando descrive una fuga, un inseguimento, un viaggio, non parla di cavalli in quanto categoria astratta, è sempre quel concreto cavallo fotografato con l’occhio della mente, o baio, o zoppo, o alto, o spelacchiato, o magro, o pezzato, o magari con uno strano bozzolo sul capo. Su questi cavalli stanno in sella uomini instancabili, feroci, vendicativi, crudeli, ma anche improvvisamente generosi e ospitali (14).
Siamo stati fortunati, prima di arrivare qui nell’eden, a 2.200 metri di altitudine, dove trovo i primi alberi che, a questa altezza, non possono che essere larici. Paesaggio decisamente alpino e meno altipiano. Mi sento a casa. Nel mezzo, ancora, in mezzo al nulla, Kharakhorum, dove torneremo attraverso la stessa Camel Trophy street. Ancora qualche foto mancata per eccesso di velocità.
Campo base di Kharakhorum (Mongolia)
C’era, disponibile, ieri sera, un servizio di “accensione stufa”. Ne avrei fatto a meno: non mi sembrava freddissimo o comunque la temperatura all’interno della gher, considerate le coperte, non mi era sembrata tale da giustificare l’intervento di una giovane fanciulla che venisse ad accendere. Invece? Invece sì.
Le gher sono fatte per resistere a –30° e oltre, per conservare il calore interno. Le stufe sono fatte per l’inverno. A 10 minuti dall’accensione dentro si schiantava letteralmente dal caldo. La persona che ha insistito per avere il servizio in camera, dopo 3 minuti era fuori della gher in pigiama. Voglio astenermi da giudizi sin troppo facili da emettere, però sto parlando di persone di 50 anni che possono menar vanto di aver girato il mondo. Ma non è finita: era previsto che questa mattina alle 6 la gentile fanciulla ripetesse l’operazione dell’accensione per garantirci il comfort della sveglia. A parte di preferire il freddo (che freddo non è) all’essere svegliato alle 6 di mattina, l’esclamazione più idiota che abbia sentito è «va’ che storia!…» come se questa persona NON avesse MAI visto un fuoco acceso. Fine dell’episodio.
Passiamo alla mattinata. Alle foto non scattate per assenza di batteria nella macchina fotografica, tornando verso Kharakhorum.
Questa sera siamo andati a uno spettacolo. Una sorta di rievocazione storica della nascita della prima (forse) riserva naturale della storia. Di fronte a Ulaan Baatar c’è una montagna tutt’ora considerata sacra, dove non si possono toccare gli animali e la natura in generale. La montagna aveva questo status già nel 1206 e le persone che contravvenivano questa legge, venivano uccise “senza (spargimento di) sangue”, vale a dire tramite la rottura della colonna vertebrale.
Un temporale ha rischiato di mandare a monte tutto, ma poi ha smesso. Al campo in cui si tiene lo spettacolo bambini giocano ad una specie di gioco dell’oca chiamato – provate a indovinare – “corsa di cavalli”. Il tutto (cavalli sulla pista e dadi) è fatto con ossa di garretto di pecora e l’anziano, che attraverso Mugi mi aveva spiegato il gioco, mi regala uno di questi dadi e si raccomanda di spiegare, quando tornerò a casa, come si gioca quando lo mostrerò agli amici. Non posso non promettergli che lo farò, che ne lascerò traccia proprio in queste righe.
Una brezza tagliente ci congela tutta la sera. Ci offrono latte di cavalla rigorosamente freddo. La rievocazione va avanti, mentre sulla scena, nel teatro naturale che è il paesaggio di fronte, si susseguono lottatori, tiratori con l’arco, contorsioniste, musicisti, cavalieri che corrono. Questa ragazzi è l’incredibile Mongolia. Una luna, alla fine, esce enorme sul verde, a tingere il blu fondo del cielo [I feel the Earth tumbling down (15)
Chinggs Khaan hotel, Ulaan Baatar (Mongolia)
Latte di cavalla, freddo, notte di vento siberiano – non so se lo fosse, ma gli 11 gradi misurati in tenda lo lasciano supporre. Cani abbaiano latrano vicini lontani per ore. Discutere e abbaiare rappresentano la «vergogna del regno animale»: si riempie di sé lo spazio, compulsivi, isterici, senza controllo, senza disposizione all’ascolto, incatenati alla difesa della proprietà privata del padrone di turno: quella torbida e sfuggente del “mondo interiore” e quella marcata da steccati porte cancelli serrature, protetta dalle alchimie telematiche dei capitali finanziari – insomma, ogni mezzo capace di assicurare una parvenza di benessere e persistenza. Gli amanti isterici discutono, i galoppini mediatici del potere discutono (mentre nelle “alte sfere” si spara e si fa la guerra, senza discutere troppo): «i cani abbaiano a quello che non conoscono», sentenzia Eraclito. La razza canina schiava e parassita, abbaia perché da qualche millennio frequenta l’eruttazione fonica dell’uomo, senza capire niente di quel che vien detto. Soltanto come randagi cominciano a ritrovare la loro dignità selvaggia di creature libere e disperate, predisposte più al silenzio che al latrato. Prendi un lupo: tace oppure ulula, alla luna, all’universo, a quello che non conosce. Non ci discute, da gran signore. Invece, queste bestie al guinzaglio, basta un fruscio e subito ad aggredire con furore, ad agitarsi senza controllo. C’è sempre un cane che abbaia: sta’ zitto, stupidog! Sarà mica un caso che la bestemmia più diffusa è canina? (16)
Mi sveglio stranito, sul letto marmoreo e capisco che qualcosa non va. Assistiamo a una cerimonia buddista al monastero di Erden Zuu, visto in parte ieri. [raccontami Ongii / che scorri / incessante preghiera che mormora al cielo / del tuo monastero perduto / dimmi la bellezza dei gesti e dei colori / che ti hanno traversato e hai riflesso]. È incredibile come tutta la poesia e il fascino di un luogo del genere svaniscano come neve al sole di fronte a una impellenza fisiologica: il luogo di maggior interesse per tutta la durata della cerimonia (alla quale non ho finito di assistere) è stata la toilette, dentro il negozietto turistico all’inizio di Erden Zuu.
360 km di buche, da Kharakhorum a Ulaan Baatar, passati a controllare lo sfintere anale ad ogni sobbalzo, per non farmela addosso. Virus intestinale e buon ferragosto a tutti. Scopro le virtù terapeutiche della Coca Cola, consigliata come disinfettante (sgasata) nei posti esotici. In arrivo a Ulaan Baatar alle 18, il solito traffico. Guida a destra, guida a sinistra, guida selvaggia. Il nome di questa città è un urlo di battaglia. Combattuta a colpi di clacson. Apprendo che i nomi delle strade non ci sono. Semplicemente non mettono cartelli. Non li mettono per andare da un posto all’altro nelle piste, figuriamoci in città. Come facciano a recapitare la posta resta un mistero. Pare che cercare un indirizzo in città sia un’impresa titanica. Rivincita del nodo sul chiodo. Rigurgito dello spirito nomade sullo stanziale: del resto a che ti serve avere un indirizzo se poi prendi la tua casa, in un’ora la smonti e te ne vai?
Gli stessi edifici sono del tutto approssimativi: sembra non riescano a fare uno scalino uguale all’altro! Manca il concetto di “alzata”…
Arrivo in albergo e mi fiondo a letto, febbricitante. Il maxischermo della finestra proietta i chimerici cieli della città mutevoli ogni minuto al tramonto, quando, di tanto in tanto, nel dormiveglia apro gli occhi. Mugi mi telefona alle 23 per sapere come sto e mi consiglia il metodo mongolo: vodka o whisky per disinfettare le budella e dormire. Forse farei meglio a seguire il suo consiglio, anziché prendere antibiotici. Speriamo domani vada meglio. Per adesso la febbre c’è ancora.
Campo base Tovshin II, Deserto dei Gobi (Mongolia)
Benebenebene. Ieri, grazie a una provvidenziale soppressione di aerei destinati al Gobi, siamo riusciti a stare un giorno e una notte in più a Ulaan Baatar. Provvidenziale per le mie precarie condizioni di salute, che via via migliorano. Ho scariche che si attenuano nell’arco della giornata. Visitiamo, ieri, un paio di musei (di Storia Naturale e di Storia della Mongolia), di cui una cosa sola realmente mi colpisce: utilizzano BC e AC (avanti e dopo cristo, in inglese), pur non essendovi cristianesimo da queste parti. Mi spiegano che è una specie di standard internazionale che si è imposto anche laddove la parola “Cristo” è quasi del tutto sconosciuta, quindi… ci si adegua. Potenza del cristianesimo. Per il resto i musei hanno un allestimento per certi aspetti approssimato e un po’ raffazzonato con elementi che si ripetono sia nell’uno che nell’altro (in particolare sulle origini dell’uomo che si ritrovano in entrambi i musei…), ma qui c’è da far la tara a quel che dico perché – allievo di Paola Rodari e Matteo Merzagora per il corso di museologia scientifica il secondo anno di master Sissa – ho l’occhio allenato alla visione di allestimenti che andrebbero migliorati, a sale che andrebbero illuminate diversamente, in cui gli oggetti dovrebbero avere altre collocazioni e via dicendo. Nel pomeriggio ci siamo recati in visita a un monumento sulla collina. Ringraziamento e commemorazione ai soldati mongoli che hanno aiutato i russi nell’avanzata contro i nazisti e i giapponesi (1943-1945). Posizione panoramica sulla città. Stile bolscevico. Nella visita al museo che parla della Mongolia c’è tutta una sezione dedicata al periodo di adesione al bolscevismo. Il presidente – l’ultimo prima delle libere elezioni del 1990 – è stato in carica 44 anni. La scheda per votare era unica. Un simbolo unico e qualche nome. Potevi scegliere tra varie gradazioni di rosso: da quello chiaro al rosso scuro, tendente al nero… Neanche Gengis Khan è riuscito a rimanere in sella così tanto [barbaro umanesimo bolscevico / l’età del bruci il mondo / caschi in terra / l’età del tutto giù / nuova la Terra / rosso fiammante].
Stamattina solita sveglia impossibile. Destinazione: deserto dei Gobi. Ad attenderci all’aeroporto un Fokker-50. Aeroplano doppia elica. Domestic flies. Altri turisti. Qualche indigeno. Sonno. Tanto sonno. Solita questione bagagli. Sempre troppi. Riesco a essere ancora più essenziale.
Volare sulla Mongolia è come volare su un immenso tessuto di seta, increspato, fine, dai colori cangianti. Cuciture le strade, artificiali, rettilinee, essenziali, scarse, scarne. Vene, arterie, vasi sanguigni i fiumi, i torrenti, reali o in secca.
Dormo. Mi sveglio di soprassalto convinto di essere rimasto in albergo per non aver sentito la sveglia. Invece stiamo volando. Il doppia elica ronza allegro, su un cielo sereno. Atterriamo su una pista di battuto. Il carrello sinistro dell’aereo lo vedo affacciandomi al finestrino. Il braccio meccanico scende, in primo piano, mentre sullo sfondo la terra sotto si avvicina. Una ripresa da telecamera che forse sarebbe piaciuta a Federico, penso. Le ruote toccano terra, sollevando un gran polverone. Landing! C’è un timore irrazionale che qualcosa debba andare storto, ma non c’è un reale motivo. Procedure collaudate, ma inusuali la prima volta senza asfalto. Ci sono molte “prime volte” in questo viaggio: misura di quanto poco abbia visto e girato il pianeta. Che effetto fa, la prima volta, il deserto? Strano. Paesaggio lunare, brullo, piatto. Essenziale.
Ad attenderci pulmini di fabbricazione russa. Somiglianti vagamente ai vecchi Volkswagen che i figli dei fiori usavano per andare in giro negli anni ’70 o, più modestamente, ai nostri Fiat 238 (o 242?). Sono pazzeschi per estetica, per il livello di tecnologia, per il loro essere spartani. Siccome siamo sulla Luna, devo trovare un nome per questi veicoli che ci condurranno in giro questi due giorni: lo battezzerò UML, acronimo di Uaz Moon Lander. Del resto quando questi mezzi furono costruiti i tempi di Gagarin non devono essere stati molto lontani.
Le strade sono piste. Il deserto dei Gobi è anomalo: è in alto (più di 1.000 m. sul livello del mare) e freddo (d’inverno si arriva, come nel resto di queste regioni, a –20°). Non ultimo c’è da ricordare che nelle vallette qua intorno sono stati ritrovati l’80% degli scheletri e dei resti di dinosauri che sono esposti in giro per il mondo. Le sue anomalie lo rendono patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Abbiamo due unità UML da 10 posti – alcuni dei quali riservati necessariamente ai bagagli – e quindi due autisti. Parlano poco, i mongoli, in generale (17). Quelli che abitano queste regioni, ancora meno. Sempre gentilissimi e professionali – si prestano sempre se hai bisogno di fermarti; per galanteria ci aprono sempre le porte (18)– restano impenetrabili anche (forse soprattutto?) alla contagiosa (?) “gioia” delle combriccole di italiani in gita, al pascolo.
A 10 minuti di strada dall’aeroporto facciamo una sosta per rifornimento cibarie. È caldo, ma è secco e asciutto. In movimento l’aria sembra addirittura fresca, ma sono solo le 10 del mattino. Quel che sappiamo essere un falcone (dalla visita di ieri al Museo di Storia Naturale), ci guarda di pietra da un dosso. Immobile animale sacro di questo pezzo di Luna su cui siamo sbarcati.
Chilometri. Tanti? Pochi? Come si fanno a misurare a intuito in un deserto? Sembra d’esser per mare. Tutto relativo. Conviene parlare di ore di viaggio. Le ore delle UML, unità di misura delle velocità che puoi tenere da queste parti. UML che qui sostituiscono le jeep (ci sono anche quelle, ma Uaz) e cavalli, perché più capienti e perché in fondo il deserto non ha pendenze insormontabili. Ci fermiamo per il pranzo, “al sacco”. Con prudenza mangio solo il riso scondito e “vendo” al miglior offerente la mia razione. Ci fermiamo ancora in un paesino che è il centro più grande della zona: 1.000 anime e altre 3.000 sparse nel territorio della provincia. Del resto è tutto proporzionale: siamo o no in un deserto?
Verso le 14,30 vediamo l’autista uscire dalla pista: freccia a sinistra, anzi: nessuna freccia, e stop. “Huston, UML 1 in avaria, we have a problem”. Una spia rosso bolscevico è fissa sul cruscotto, a indicare pressione dell’olio insufficiente. Prova ad aggiungerne un po’, ma si tratta di una perdita seria. Così scendiamo tutti in mezzo al nulla, a 40° ventilati. Vengono tolti i sedili davanti perché i pistoni stanno lì a scaldare i fondoschiena di autista e passeggero davanti. Nel frattempo arriva anche la seconda unità UML. Perderemo (?) in tutto un’ora e un quarto.
Con Mugi, per ingannare il tempo, facciamo un gioco che già avevo visto fare e che consiste in quella specie di morra cinese per la quale a turno si deve tirare a indovinare la somma di quel che ognuno di noi ha deciso di mettere nella propria mano destra (abbiamo raccolto 10 sassolini a testa prima di iniziare). Il gioco, a noi sofisticati occidentali, sembra un po’ stupido all’inizio. Poi invece capisci che è sottilmente psicologico, ancorché legato alla fortuna. Le chiedo – per capirne meglio le regole – quando si considera finita la partita. Mi sorride e dice: «The game will be finished when you have lost!». Hai capito la signorina mongola! Di fronte alle mie rimostranze, si corregge con un: «no… you or me!». Ora va meglio.
Azzecca una puntata lei, perdo 6 sassi. Ne indovino una io. Ad un certo punto perdo secco: ho solo più 3 sassolini, ma non mi perdo d’animo. Gioco a spiazzarla, dico numeri esorbitanti cercando di immaginare cosa lei possa avere in mano, oppure bassissimi, seguendo il saliscendi, la scia ondivaga di quel che mette nella sua mano. Indovino due puntate secche che la lasciano con un sassolino e tocca a me dire il numero per primo. A questo punto del gioco la psicologia e la fortuna non c’entrano più; è sufficiente l’abaco: ho 3 sassi in mano e dico 4. Lei in mano o ha un sasso o ne ha nessuno. Avendo scorto la sua meraviglia di fronte ad alcune puntate nel quale non avevo messo nessun sasso (zero è un numero dignitosissimo, le ho ribattuto) ero quasi certo che in mano avesse l’unico sasso che possedeva, quindi…
Non si capacita d’aver perso. Le dico per scherzo che conserverò i 20 sassolini scrivendoci sopra come ricordo: «The game will be finished when you have lost!».
Manco una foto per distrazione: motociclista e passeggero indigeni e stracarichi su una di queste moto di marca russa o forse coreana. Spesso monocilindriche, 150 di cilindrata. Ciclistica anni ’70 o forse prima. Altro che enduro supertecnologici! Venire qui, in questi luoghi fa bene, serve a capire la misura esatta del superfluo che abbiamo. Tecnologie belle, fragili, talvolta inutili, un po’ fini a se stesse per eccesso di edonismo. Differenze di sostanza – penso al me stesso motociclista – tra l’essere (/l’andare) in giro per divertimento vs. per necessità. Necessità di nomade, esistenziale, di sussistenza, e quindi essenziale. Poi mi viene il dubbio: ma vuoi che non ci si diverta anche con un Jfmco, a spasso nel deserto, senza casco? Credo di sì.
Resta il fatto che non è una questione di ciclistica o di ultimo grido: questo deserto è solcato da mezzi che appartengono a buon diritto al secolo scorso, e non per pochi anni. Questo pezzo di Luna è fantastico, soprattutto perché dopo i taglia, incolla, cuci, smonta e rimonta pezzi, i due autisti – evidentemente anche meccanici – ricostruiscono una guarnizione artigianale per sostituire quella andata. E lo fanno con il tappetino di gomma che uno dei due ha sotto i piedi mentre guida. Lo osservo, il tappetino, e a giudicare da come è messo, non è da escludere che sia stato usato nello stesso modo per altre occasioni. “Huston, problema risolto, possiamo ripartire”. Alle 18 siamo al campo da cui scrivo. Tovshin II. Nome da base lunare, appunto.
Chinggs Khaan hotel, Ulaan Baatar (Mongolia)
Dal campo base l’avventura non è finita, anzi. Una merenda/cena è prevista per andare a vedere il tramonto sulle dune. Altri 20 km ad andare e 20 a tornare in UML, dove si arriva fino a un certo punto. Poi è parco, area protetta. Si va a piedi, passando per piccole dune di vegetazione che ben si adattano al clima. Inatteso un corso d’acqua e poi le dune vere, alte un centinaio di metri. Il sole cala. La luna sorge. Tutt’e due stanno appesi lì, come nelle favole, in un cielo turchino che cambia colore ogni minuto. Così la sabbia e il mondo intorno. Cerco di catturare con la macchina fotografica ciò che mi sembra impossibile. Continuo a scattare, ma a chiacchierare anche con Mugi. Siamo noi due su una duna. Tutto il gruppo è intorno, sparpagliato.
Ma lì abbiamo creato di nuovo una piccola intimità che fa fluire i nostri discorsi ancora su di noi, sui nostri desideri, speranze, ambizioni. La cornice intorno è l’eden, prima della cacciata dell’uomo. Mugi è combattuta: quando torneremo alle nostre case lei partirà per il college, a New York, per 4 anni. Le ho chiesto, per sdrammatizzare, che “percorso” le convenisse fare: passare dal Giappone o dall’Europa? Mi risponde che è praticamente equivalente, il posto dove andrà è esattamente agli antipodi, dall’altra parte del globo. E io che in certi momenti ho vissuto come un trauma il distacco definitivo da casa mia, in età adulta, per andare a 300 km di distanza. Mi vergogno un po’: lei ne farà 30mila, a 22 anni ancora da compiere.
Mi sbaglio pensando di essere nell’eden prima della cacciata dell’uomo. Sicuramente è dopo, visto che la divinità ha già introdotto il fattore tempo: lo percepiamo dall’avvicendarsi degli astri. Il sole scompare definitivamente per mescolare la tavolozza di ocre, tutte, ancora una volta, con la luna [d’oro giada bordeaux si tinge il mondo / bagliori d’amaranto viola la fine / segue lo sguardo il montare della sera dal fondo delle valli]. Mi sono portato una bottiglietta perché vorrei riempirla della sabbia del Gobi. Da regalare. Mugi lo fa per me. Le mani si chiudono a imbuto. La sabbia fluisce fine, impalpabile. Gesto concreto, come le pastiglie naturali (“no antibiotic!”) che mi ha portato da casa, contro la diarrea. Doni.
Lascio pezzi di cuore sulle dune. Emozionato. Così mi percepisco. Promessa a me stesso – forse “vacua e solenne” – di un ritorno. Ma quando? Dolore lancinante per la brevità di tutto ciò che siamo, per il respiro di vita corto e sciupato e gettato, barattato col denaro, misura quantificazione qualificazione di ciò che siamo. [Si dice sempre che il tempo è denaro. Ma bisogna ricordarsi che l’equazione non è reversibile: il denaro non è tempo. Il tempo è vita. Io decido dove investirla: nella pesca, nell’orto, al sindacato, in famiglia. Questa è libertà. Una parola grossa che bisogna imparare presto a riempire di cose piccole (19). Dolore per il modesto capitale di tempo che abbiamo. Tutto troppo in fretta. A partire da questo viaggio, di cui riesco a cogliere istantanee, ma solo in differita. Pensieri inespressi (voglio un registratore!) per i troppi dondolii dell’UML o di qualsiasi altro mezzo su cui sono a bordo. Per eccesso di stanchezza.
Torniamo che i cammelli pascolano insieme ai cavalli alla luce della luna. Arriviamo agli UML che è buio. Alla nostra unità lunar-terrestre non si accendono i fanali. L’autista/meccanico si prodiga. In pochi minuti ne viene a capo e i fanali funzionano di nuovo. Questo ragazzo è un prodigio! Mugi ha un umore saltellante: alterna momenti di tristezza a momenti di serenità. La invito a bere una birra con me.
Ci acquartieriamo sulla specie di veranda che è nella struttura principale del campo base. Le gher sembrano strutture aliene (colonizzatori lunari?) in quella luce: una luna che guarda la luna. Il suo viso tondo riluce, con il taglio d’occhi nel quale non si vedono le palpebre. Le sue forme, pur abbondanti, hanno nel portamento un che di regale. Parliamo ancora per un’ora. Cerco di illustrarle il mio punto di vista sulla questione, nel mio inglese biascicato, misto all’italiano when the word is missing. Per crescere è necessario perdere qualcosa. Il bambino perde il palloncino che la madre gli ha comprato. Oggi, nel deserto, ha perso un ciondolo che aveva comprato da poco. Dovrà lasciare casa, rinunciare alla presenza e all’affetto dei genitori, che avrà sempre, ma non più come gesto concreto. E quindi crescere. Ma rimanere se stessa. Essere serpente che cambia pelle. [Secondo natura e destino che giunge / ad ognuno il suo Dunque. / Per caso banale o scontro su strada. / O nel ghetto di sempre. / Per cielo corrotto o terra che trema. / E veleni ingeriti. / Sul telaio che produce alla moda / colori a chilometri. / E seduto in vetta alla piramide. / Mentre reggi il timone. / Ti cattura negli agi del superfluo / che fa la differenza. / Arriva nel sonno. Ti strozza. Lo sai. / È la resa dei conti. / Ognuno è fiume-serpente che morde la sua coda nel Dunque. […] / Scatta la morte sulla preda attesa. / Il posto dei serpenti lo conosce. / È dove si tradiscono lasciando / la traccia intera della pelle vecchia. / E da serpente tu la sfida accetti. / Ma lei ti pianta un sasso nella testa. / E viene al mare col serpente dietro. / Alla barca del nulla assicurato. / Inerte corpo dalla pancia al cielo (20).
Poi la stanchezza prende il sopravvento. Buonanotte piccola regina della Mongolia. Di te mi rimarranno 20 sassolini raccolti nel deserto e la sabbia che hai voluto depositare nella bottiglietta di plastica. Metterò tutto nella indefinita scatola ad hominem della mia esistenza. A futura memoria. [Poi mi domandò, anzi, mi implorò di vendergli la Scatola. Naturalmente rifiutai. Nei minuti che seguirono, mi offrì una somma molto più alta di quanto l’avessi pagata. Gli risposi che non l’avevo comprata per guadagnarci nel rivenderla, ma che mi sarebbe piaciuto sapere perché era così interessato. Se fosse stato un habitué delle aste, si sarebbe rifiutato di rispondermi o avrebbe tentato di combinare qualche affare. Per fortuna, invece, era un professore di storia dell’arte e si mostrò accomodante. “Sa che cos’è un memento hominem?” chiese, col suo accento tipicamente italiano. “Memento hominem?” domandai. Ne avevo una vaga idea. “Teschi e orologi senza lancette.”
Mi corresse. “Lei lo confonde con il più comune memento mori, cioè con quei simboli della morte che si trovano nei dipinti e nell’architettura funeraria europea.” Mi spiegò che un memento hominem non serve a rammentare la morte, ma piuttosto è il documento di una vita. Ogni oggetto nella scatola rappresenta un momento o un rapporto importante nella vita di colui che l’ha preparata. Gli oggetti scelti sono spesso comuni e banali; ma non lo sono mai le ragioni della selezione. Disse che era una cosa comune in Svizzera e in Francia tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Esuberante come possono esserlo solo gli italiani, mi rivelo che la Scatola dell’inventore narrava una storia, una storia veramente singolare(21).
Stamattina trasferimento da Tovshin II a I. Da base lunare a base lunare. Gli UML e gli autisti in splendida forma. Soste. Foto. Pipì. Carcasse di cammelli. Le tracce che i mezzi seguono sono esili, quasi indistinguibili dal resto. Elemento essenziale per un paesaggio minimale. Tutto torna. Non c’è bisogno d’altro. Scendiamo al solito un po’ shakerati. Mangiamo per ripartire subito, diretti alla valle di Iol. Il Gobi continua a essere uno strano deserto. Molto popolato di specie animali per dirsi tale. Volendo cercare la definizione nella morfologia che lo vorrebbe piatto, non avremmo ugualmente successo: non esattamente tale per dirsi deserto. Infatti andiamo verso le montagne. Gazzelle – nel deserto? Sì, in questo ci sono anche loro! – a branchi. Velocissime, manco avessero dei leoni a rincorrerle. Pazzesco.
Il deserto con le montagne ha questa valletta famosa, detta delle aquile, perché da queste parti ci sono anche loro. Abbandoniamo i fidi mezzi lunari e ci addentriamo a piedi, per il sentiero. Chi vuole ha a disposizione, almeno fino a un certo punto, cammello o cavallo. Preferisco andare a piedi, per smaltire cibo e shakeraggio. Tutto cambia nell’arco di pochi metri. Un rivolo d’acqua, responsabile della gola, scorre innocuo. Mugi mi dice che nemmeno un mese fa qui c’era ancora un metro di neve. Non c’è da stupirsi se d’inverno s’arriva a –25°, ma non posso non stupirmi!
Su insistenza di Mugi torno in cammello. Lei espertissima ne “guida” uno tutto suo, mentre il mio è condotto a passo d’uomo da uno dei proprietari delle bestie: viene tirato attraverso una specie di cordino che funge da briglia, innestato sul naso attraverso uno piccolo ramo. La leggenda che circola da queste parti vuole che il cammello sia l’ultimo discendente del dinosauro. Un’altra leggenda lo vuole animale-chimera, ovvero animale che è frutto dell’assemblaggio, dell’unione di parti di animali diversi. Ma quali? Quelli dell’oroscopo cinese, ovviamente: le orecchie del topo, il collo del drago, and so on. L’assunzione delle parti di altri animali non è però solo formale: il cammello assume su di sé il carattere delle altre fiere. Sta di fatto che è un animale buffo. Ti guarda di sguardo laterale, torbido, illanguidito, ipnotizzato e ipnotico. Mastica come bradipo per lentezza e precisione. Mandibola disarticolata: un colpo a destra, un colpo a sinistra.
Quando non è impegnato nella masticazione tiene le labbra semiaperte, come in un’espressione di eterna sorpresa o estasi. Come i cavalli sono di bassa statura rispetto agli animali della stessa specie che vivono a latitudini meno rigide: i –25 hanno il loro peso genetico. Di indole mite, quando si spaventano pisciano puzzolente. Gli zoccoli, ricoperti di pelo, sembrano morbide pantofole. Le zampe hanno articolazioni che ho osservato per diversi minuti, soprattutto quando si chinano per l’accesso alle gobbe, per salire e scendere, si abbassano con movimento curioso: si inginocchiano con le zampe davanti, poi dietro e poi ancora si accucciano. Buffissimi. Fortissimi.
Aquile, nella valle delle aquile, comunque poche. Troppo via vai. Troppo casino. Siamo in troppi, anche nel deserto. Torniamo al campo base. Le navicelle UML atterrano dopo salti buche fossi, silenziose. Ci tocca una merenda/cena perché abbiamo un checkin alle 18. Tutto si svolge rapido e veloce. Ci congediamo dall’autista. Neanche nel momento dell’addio gli strappiamo un sorriso. Non è cattiveria la sua, si capisce. È riservatezza, imbarazzo, introversione. Tiene gli occhi bassi, fissi a terra.
Il Fokker-50 Aero Mongolia scarica e carica persone e bagagli. Il rito collaudato. Nessuna sorpresa anche senza asfalto. I carrelli rientrano, meccanici, che la terra è ancora vicina. A una mezz’ora dall’atterraggio incontriamo banchi di nuvole. È come essere su una delle strade/piste che congiungono il paese: buche e scossoni. I vuoti d’aria si fanno sentire. Il chiacchiericcio di sottofondo si smorza per lasciare spazio a un silenzio attento in sala, partecipato. Chi dormiva si sveglia. Il comandante, con voce asettica, come fosse routine, raccomanda di tenere le cinture allacciate e di evitare di andare a spasso per l’aereo. Per fortuna le buche del cielo durano pochi minuti. Scendiamo sulla pista d’asfalto. Thank you for flying with us. Le nuvole nelle quali eravamo sono parte del paesaggio. Rientriamo in albergo, stanchi. Mi assegnano una stanza che perde acqua dal soffitto del bagno. Chiedo il cambio per telefono. Mi dicono che mandano su qualcuno. Aspetto, ma non arriva nessuno. Vado di sotto alla reception per chiedere de visu che mi cambino la stanza. Nell’open space di fronte noto tre belle ragazze che chiacchierano davanti a una coca cola.
L’operazione di assegnamento dura qualche minuto: dovrò tornare giù a restituirgli la chiave della stanza fallata perché devo spostare i bagagli. Vado. Torno. Quando torno all’ascensore per salire definitivamente in camera ho alle calcagna una delle tre fanciulle. Marziano, anzi appena rientrato dalla luna del deserto, ancora impolverato, insabbiato, stopposo di capelli, poco dignitoso nel vestito, da ripulire, penso di fare il gentile tenendo la porta dell’ascensore aperta. Dopo trenta secondi netti capisco tutto. Trattasi si abbordaggio in ascensore in piena regola: «Excuse me… do you need massages…», dice lei. «Oh no! Thank you!» declino io, che non voglio comprare niente, credendo – quando ha iniziato a parlare – che mi volesse chiedere da dove vengo, per quale motivo sono lì o che so io. Insomma: io che supponevo la classica conversazione da ascensore, mi ritrovo a sentir completare la frase nell’istante stesso in cui la porta si apre sul mio piano: «…or sex?». Plin plon. Zzzzttttt. La porta è aperta.
Declino. Forse mi incrino, ma prima di sgretolarmi come un cartone animato, schizzo fuori, tappo di sughero di una bottiglia di spumante. Inebetito di bollicine. Totalmente disorientato e confuso per il “candore”, per la maniera dannatamente NON occidentale di offrirsi. Sono uomo, ma anche maschio. Fatto di ciccia e non di ferro. Con l’aggravante che non tocco una donna con l’unghia del dito mignolo da un tempo che non voglio rivelare, perché sono fatti miei.
«Cavolo, ma non potevi dire di sì! Ma hai visto com’è bella? Che taglio d’occhi. Ma quando ti ricapita per le mani una così! Cacchio sembrava una principessa…» «Sì, sul pisello! No, no e no! Già abbiamo pochi principi, ma ch