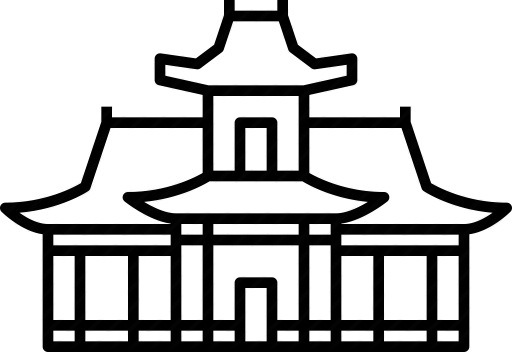Il mio viaggio in Mongolia inizia quasi per caso. Nulla di pre-organizzato, ma un semplice invito da parte del Comitato Olimpico Mongolo a mio padre (foto sotto), quale presidente mondiale della stampa sportiva, in occasione dei festeggiamenti del Nadaam e soprattutto della ricorrenza degli ‘800 anni dalla nomina di Ginghis Khan a primo imperatore della Mongolia. Un’occasione unica, irripetibile e da prendere al volo.
Un viaggio ufficiale quindi, ricco d’intermezzi istituzionali e visite a ministri, alte cariche dello sport, banchetti e cene con giornalisti, interviste televisive e visite nelle redazioni dei giornali. Situazioni e persone che hanno arricchito culturalmente la nostra visita, che hanno permesso di addentrarci in profondità nel loro tessuto sociale, di conoscere abitudini, routine lavorative e valori che difficilmente un turista può cogliere.
Curioso ad esempio è stato incontrare il ministro dello sport.
All’interno di palazzone apparentemente di stampo sovietico ma di costruzione cinese, si trova “The Ministry of Sport Ability - Ministero delle abilità sportive. La struttura e gli interni mi ricordano molto le mie scuole elementari: soffitti bassi, uffici come aule dalle porte di legno laccate e grandi scaloni in marmo.
Il ministro ci illustra lo sport in Mongolia, terra di lottatori. Racconta che in tutte le 21 aimag (province) si fa attività, dalla taiga al deserto dei Gobi e che il basket e la pallavolo sono le discipline più diffuse e praticate in queste regioni remote. Esistono 5 piscine in tutta la Mongolia, 3 di queste si trovano nella capitale.
Gli sport che hanno regalato più successi sono la lotta con una medaglia di bronzo alle ultime olimpiadi di Atene, e gli sport invernali come lo short track, sci di fondo, e gli sport sul ghiaccio praticati all’aperto negli inverni rigidissimi di Ulaan Bator. Il nostro occidentale jogging non è praticato. Nessuno alla mattina si alza a correre, anche perché di parchi non ne ho visto l’ombra.
Il nostro viaggio ci ha regalato luoghi e paesaggi unici come la steppa, e ci ha fatto conoscere l’incredibile vita dei nomadi. Spesso mi sono chiesta se fosse così la Mongolia che mi aspettavo e ricordo che, quando in Italia chiudevo gli occhi e cercavo di immaginare questo paese, sognavo immagini strappate dai documentari: spazi immensi, verdi, sovrastati da cieli tersi, infiniti e un popolo a cavallo, dagli occhi a mandorla e dalla pelle cotta dal sole e dal vento. E così è stato. Quello che immaginavo ha preso forma proprio nella visita alla steppa.
La cosa che più mi ha impressionato è la vastità della steppa. Potrei cercare di descriverla semplicemente dicendo che è tanto vasta quanto il cielo, impossibile intravederne l’inizio e la fine e difficile da contenere con lo sguardo.
A naso in su, mi sono tornati in mente i cieli dell’Outback australiano, così immensi e tersi, dalle nuvole talmente alte e striate che ti danno la sensazione di trovarti dall’altra parte del mondo, in un paese lontanissimo!
Ma, il racconto di questa visita alla steppa deve per forza iniziare dalla narrazione dai mezzi e i modi con cui dalla capitale ci si arriva. Da Ulaan Bator si prende una strada che noi definiremmo statale, ma assurge a ben più importanti ruoli, in quanto è la principale via di comunicazione tra la capitale e il centro della Mongolia. Oltre ai dossi, alle buche, all’assenza totale di guard-rail e oltre al fatto di essere ad una sola corsia, capitava che d’improvviso venisse attraversata da greggi, persone, cavalli. O, nel peggior dei casi, è capitato che all’improvviso sbucassero da dietro un dosso, gruppi di lavoratori che nel mezzo della strada, senza preavviso o protezioni, gettavano catrame caldo per ricoprire i buchi e abbellire il manto in vista del Nadaam.
Per non parlare delle stradine che abbiamo poi percorso, per addentrarci nel cuore della steppa e raggiungere una coppia di nomadi, amici della nostra guida-autista. Indaffarati nelle loro routinarie mansioni di mungitura e pascolo, appena ci videro sopraggiungere, abbandonarono il lavoro per accoglierci con sorriso nella loro gher (tenda). Ci fecero entrare in questa tenda circolare bianca, fatta di bastoni e ricoperta di feltro, dove la vita sembra gravitare attorno alla stufa posta nel centro e la cui canna fumaria fuoriesce dall’apertura centrale del soffitto.
Ci sedemmo secondo l’ordine da loro impartito. Purtroppo non sono in grado di descrivere nel dettaglio tutto quello che ci è stato servito e chiesto di fare poiché ero troppo assorta ad osservare i dettagli di un modo strano e insolito. Ricordo solo che come prima cosa abbiamo dovuto annusare una boccettina di profumo da tenere rigorosamente nella mano sinistra, e che poi ci hanno offerto tè salato, una specie di yogurt di giumenta e formaggio seccato e salatissimo. Ero come estasiata ed era difficile capire il confine tra la realtà e l’immaginazione della vita di questa coppia di settantenni, dagli occhi a mandorla e dalla pelle molto spessa e incisa da rughe profonde, che avevano vissuto una vita in continuo spostamento, montando e smontando questa piccola casetta circolare, in cerca di campi sempre verdi per il pascolo e riparo dalle intemperie e dal vento gelido della steppa.
La cosa più bizzarra era vedere il televisore alimentato dai pannelli solari e la radio che serviva, come sottolineavano loro, solo per seguire il Nadaam.
Dalla gher accanto, due piccole bambine nomadi gattonarono fino alla nostra porta, attratte dalla nostra visita e in cerca di cibo. Anche stavolta, la mia immaginazione faceva fatica a comprendere come due bambine potessero crescere selvaticamente in questo modo, lavandosi nel fiume, mangiando solo prodotti di cavallo, mucche e buoi: una dieta priva quindi di vitamine della frutta e verdura, che in questo paese non viene coltivata in quanto la terra è considerata sacra, per cui non coltivabile.
Penso che la nostra visita, la visita di due occidentali che hanno passato più tempo a far foto e filmati, abbia in qualche modo spezzato la loro routine scandita da mungiture e pascolo, e abbia portato un po’ di sapore occidentale.
Se la vita della gher è stata per me come conoscere un nuovo mondo, non poco stupore mi ha suscitato la capitale Ulan Baatar.
E’ stato come un viaggio a ritroso nel tempo, nell’Italia degli anni 50 del dopo guerra. Dai libri che leggo apprendo che la città è recente. Fino a ottant’anni fa c’erano solo carovane e bazar di mercati e oggi è un’oasi di cemento in un vallata verde. L’architettura cinese-comunista, che si manifesta nei palazzoni grigiastri dal tetto piatto e dalla forma rettangolare, spesso affiancati da baracche di legno e gher, crea l’atmosfera di questa città dalla difficile identità, sulle cui strade regna un traffico incontrollato e incontrollabile. La cosa impressionante è che per i pedoni non esiste alcun rispetto: con il semaforo verde o sulle strisce, il pedone non ha diritto di attraversare, deve girare in continuazione la testa, a destra e sinistra, e poi buttarsi ad occhi chiusi. Le strade sono piene di buchi e sui marciapiedi c’è il rischio di cadere in qualche botola o buco lasciato incostuditamente aperto. E’ quello che è capitato a noi fuori dal ristorante Marco Polo.
Il traffico è molto eterogeneo: accanto a gipponi coreani e nipponici, sfilano calessi. L’auto è uno status symbol, simboleggia la ricchezza che solo pochi conoscono e che quei pochi ostentano e sfruttano come simbolo di potere. La mia giovane guida Ermun continuava a ripetermi che chi ha i soldi può fare quello che vuole: mi raccontava che suo fratello avevo preso la macchina per andare nella steppa, malgrado non fosse maggiorenne e che ciò era possibile solo perché veniva da una famiglia agiata e conosciuta in città.
L’inquinamento è alle stelle, soprattutto d’inverno quando le tende e le baracche usano il carbone come combustibile. Gli abitanti raccontano che la città viene avvolta da una fuliggine grigia irrespirabile, mentre la temperatura scende a -15.
Il rapporto auto-abitanti è 1 su 3 abitanti, ma l’utilizzo mi sembra smodato, anche perché i mezzi di trasporto pubblici sono ridotti all’osso. Caratteristici sono i “mini-bus parlanti”. In assenza di segnaletica e mappe che ne indichino il tragitto, l’autista ad ogni fermata si affaccia alla porta e inizia ad urlare più volte il tragitto che compierà.
Pochissimi parlano inglese. La lingue scritta è il cirillico come in Russia e in ex-Jugoslavia. La lingua parlata è il mongolo: un idioma dal suono apparentemente diverso sia dal cinese che dal mongolo.
I nomi propri di persona sono lunghi e difficilissimi da pronunciare, motivo per cui sono stati adottati dei nick-name, magari totalmente diversi dai loro originali ma sonori, facili da ricordare e da pronunciare soprattutto per gli stranieri.
Ci raccontano che i loro modello di riferimento sono il Giappone e la Corea e quasi nessuno menziona la Cina, paese confinante. Anche Ermun ha visitato parecchie volte la Corea e il Giappone ma mai la Cina. I modelli delle pubblicità hanno però volti occidentali.
Purtroppo mi pervade il senso di decadenza: strade, marciapiedi, giardini. Nulla è curato, tenuto in ordine ma tutto sembra essere lasciato al logorio. La dimostrazione più lampante è il giardino della dimora dell’ultimo budda vivente, Bogda Khan, divenuto ora museo. Ebbene, malgrado sia un museo, il giardino reale è completamente incolto e mal tenuto.
Abbiamo attraversato quartieri dalle fogne a cielo aperto, con gente riversa per terra e sofferente. Non esistono vere e proprie strade e se piove,anche solo un quarto dora, la città si allaga.
Alcuni vicoli sono talmente stretti che due auto, per passare, devono sormontare con le ruote sul marciapiede e continuare la corsa in equilibrio. Divertente è stato trovarsi nel mezzo di un ingorgo: la gente era semplicemente intenta a pigiare il clacson più forte che poteva, senza trovare soluzioni che potessero sbloccare la situazione.
Ricordo che mio padre che scese dal taxi e si mise nel mezzo dell’incrocio a dirigere il traffico, come un vero vigile.
Non esistono le monete ma solo soldi di carta e non esistono gomme da masticare in formato confetto ma solo lunghe strisce come le Brooklyn. Non esistono cabine telefoniche e chi ha bisogno di telefonare, può rivolgersi sulla strada a persone che, attrezzate di tavolino e telefono cellulare, mettono il loro telefono privato a disposizioni dei passanti. Non so come venissero quantificati gli scatti.
Le donne giovani vestono all’occidentale, sandali con zeppe, gonne corte. Il loro modo di fare è estremamente ospitale e accogliente.
Sul fianco di una montagna è stata disegnata la testa di Gengis Khan, o meglio Chinggis Khan, come lo chiamano qui. Il suo vero nome era Temujin e la sua magnifica abilità fu quella di riunire un popolo che era diviso in clan, creando così un impero, in grado di salvare il popolo dalla minaccia cinese, e capace di grandi conquiste, da oriente a occidente.
Il Nadaam è la festa degli sport tradizionali: lotta, tiro con l’arco, corsa dei cavalli e il lancio con il dito medio di quadratini in ossa di bestiame. La lotta è la regina mentre la particolarità delle corse a cavallo è che i fantini sono poco più che bambini. Una sorta di battesimo dalle origini antichissime. I mongoli sono un popolo di cavalieri e per questo i bambini devono saper cavalcare da subito.
Oltre al Nadaam, in quei giorni si disputava la finale dei Campionati del Mondo di calcio. Un grosso tendone dotato di megaschermo, dalla capienza di circa 2000 persone, era stato allestito nella piazza principale. I mongoli vanno pazzi per il calcio, malgrado non sia uno sport molto praticato in quanto mancano le risorse e, la cosa sconcertante fu che, in migliaia seguivano tutte le partite del campionato malgrado si trattasse per loro di notte fonda. Non dimenticherò mai la notte della Finale. La partita iniziava alle 3.00 del mattino, ora locale, ma l’appuntamento al bar fu attorno a mezzanotte. Servivano tre ore per prepararsi al meglio al match. Il nostro amico Sato aveva comprato magliette della nazionale italiana per tutti e, nel pomeriggio, alcuni giornalisti avevano scaricato l’inno italiano e imparato l’intonazione. Il bar si riempì presto e sul tavolo brillava la coppa. Da una parte c’erano i sostenitori dei francesi e dall’altra i sostenitori azzurri. Alle 2, erano già tutti ubriachi e qualche schiaffo era già volato tra le due fazioni di sostenitori. Quando poi Zidane colpì Materazzi, ci fu il delirio e ai calci di rigore, nessuno capiva più nulla.
L’Italia vinse il mondiale quando in Mongolia sorgeva il sole. Erano le sette del mattino, quando facemmo capolino fuori dal bar per cercare di telefonare a casa e sentire i clacson dei festeggiamenti di sottofondo.
Per noi era giunta l’ora di far rientro in albergo, felici e vittoriosi. Per i mongoli, iniziava di nuovo la festa.
Questa è la mia Ulaan Bator, quella vista dai miei occhi e assaporata dai miei sensi.
Manuela Merlo