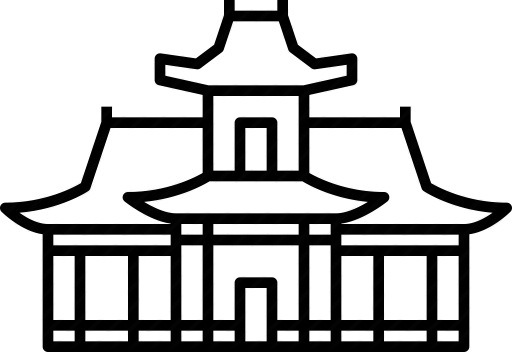PASSAGGIO DI CONFINE
Dopo una giornata a vagare per Hohhot, il capoluogo della Mongolia interna, il cui nome vuol dire “città verde”, ma è una pietosa bugia perché dappertutto è grigio, saliamo sul treno 4602 delle Ferrovie Cinesi, mescolate ad un gruppo di donne che trasportano dei meloni in una rete. In una notte tranquilla di viaggio arriviamo al posto di confine, Erlian - in mongolo Eeren -, poco dopo le sette del mattino. Una volta lì, sul piazzale della stazione si rimedia facilmente un passaggio in minivan attraverso la frontiera, che si trova a pochi chilometri, ma non si può attraversare a piedi. Ci accordiamo in fretta con un cinese sui trent’anni, vestito alla moda degli uomini d'affari di qui, mocassini di pelle, pantaloni e polo scuri. Si è avvicinato appena ci ha visto spuntare sul binario, e ora mi tiene per il braccio per paura che gli scappiamo via. Cinquanta yuan, circa 5 euro, ci dice, e partenza alle otto.
Il minivan ci porta davanti all'Hotel Centrale, nel cuore di questa equivoca cittadina, unica porta per terra dalla Cina alla Mongolia. Alle nove non è ancora successo nulla. Ogni tanto il nostro cinese accende il motore, partiamo per un giro apparentemente distratto nella zona trafficatissima del mercato coperto restrostante, quindici minuti per poche centinaia di metri scansando carretti e scatoloni, uomini e donne che alzano le serrande dei negozi stiracchiandosi, e ritorniamo nel piazzale.
Ancora attesa; Giulia, la mia compagna di viaggio, entra nell'hotel in cerca del bagno, mentre io resto, unica passeggera sul minivan, e mezza addormentata. Ripartiamo, ma questa volta il percorso cambia: ci fermiamo davanti a un negozio completamente vuoto, salgono due donne e con una terza avviene un passaggio di una mazzetta di banconote, poi riprendiamo la strada e usciamo in periferia, dove evidentemente abbiamo degli affari da sbrigare.
Il fatto è che dobbiamo caricare qualcosa di ingombrante, che richiede un'attenta pianificazione degli spazi: e cosa, se non due porte blindate complete di blocchi serratura e altrettante finestre con doppi vetri?
Decidono di smontare i sedili del minivan, almeno le ultime file. Vengo fatta spostare senza troppe cerimonie avanti e la donna più anziana, vestita con un'elegante casacca blu lucente, mi piazza in mano due mazzi da dieci chiavi ciascuna: sono quelli delle porte, da tenere con cura, mi fa capire.
Iniziano a caricare, la donna più giovane e l'uomo sono i manovali di fatica, l’altra donna dirige le operazioni. Sono a bocca aperta. Passiamo quindi a recuperare una tastiera elettronica, due servizi completi di stoviglie, diverse decine di paia di scarpe, cartoni di frutta, pesche e uva, collante, pacchi dal contenuto ignoto imballati da metri di nastro adesivo. Stivare tutto è un esercizio di logistica.
So che Giulia sarà molto preoccupata, siamo via da ben più di un'ora, ma non ho modo di avvertirla, e non saprei come tornare da sola al piazzale. La verità è che me la sto godendo un mondo. Quando abbiamo fatto il pieno di merce, iniziamo a caricare gli umani, due madri con i rispettivi bambini, uno con una maglietta stampata con la scritta ''Jesus'', l'altro con un mitra giocattolo assolutamente verosimile; e poi ancora un ragazzo dagli occhi verdissimi e la sua fidanzata che mi vuole insistentemente parlare in russo, e altri che si infilano nello spazio libero nel retro del minibus. Siamo in quindici. Di ritorno al piazzale, trovo Giulia che sta pensando di chiamare la polizia, mentre immagina il peggio. Io sono tranquilla e divertita. Alla prima domanda svagata che le faccio, si trattiene a stento dallo strattonarmi malamente. Non è proprio momento.
Raggiungiamo il confine in pochi minuti e superiamo tutti gli altri veicoli in fila facendo lo slalom, il nostro guidatore ride.
Dopo la prima barriera dobbiamo scendere dal minivan, pagare di nuovo i moduli di ingresso, che abbiamo già in mano e abbiamo già pagato, e entrare a piedi con i nostri passaporti nella zona di controllo cinese, passando sotto un arco monumentale dipinto con tutti i colori dell'arcobaleno. Nella grande stanza si sono formate quattro file, nessuna delle quali avanza di un millimetro, e una folla sparpagliata. Ci sono perlopiù mongoli, alti e robusti di corporatura, e noi due sole occidentali confuse. Nessuno riesce a scegliere una fila e starci con pazienza; anche noi decidiamo di cambiare. La ragazza che voleva parlarmi in russo mi si avvicina e mi fa segno, picchiandosi vigorosamente il dito sulla testa, che sono matta a spostarmi. Un po’ contrita, ritorno a dove sono venuta, in ultima posizione; dopo tre minuti, lei sta allegramente spintonando nella fila che mi ha fatto lasciare.
Ci vogliono più di due ore per avere il timbro cinese che ci permette di uscire dal Paese. La mia consigliera, che si è nel frattempo spostata nell'ultima fila di destra, finisce qualche minuto prima di me e io le faccio segno a grandi gesti di aspettarci, mi è venuta paura che ci lascino lì. Siamo le ultime ad arrivare, correndo, ma ci sono ancora, per riconoscere il nostro minivan fra i tanti parcheggiati basta cercare i serramenti che spuntano dai finestrini. Siamo diventati più di venti passeggeri e ci dobbiamo incastrare; finisco in braccio ad un signore dall'alito puzzolente, mentre riserviamo un intero sedile ad un bambolotto giocattolo seduto comodo sul suo passeggino di plastica, che non si deve assolutamente ammaccare.
Avanziamo 200m a passo d’uomo, e ci fermiamo, sono insopportabilmente ritorta. Apriamo di fretta il portellone scorrevole e ci riversiamo fuori per prendere fiato; quando risaliamo conquisto una confortevole posizione orizzontale, sdraiata sulle ginocchia di tre persone. La seconda fermata è il posto di confine mongolo: qui gli spazi sono ristretti e rimaniamo incolonnati ordinatamente. Un uomo cerca di entrare controcorrente, ma subito viene acchiappato da due soldati giovanissimi e ributtato in Mongolia.
Ce la caviamo abbastanza rapidamente, il tempo di un altro breve soggiorno in pullmino e siamo fuori. Ci avviamo a piedi, in mezzo a nuvoloni di terra e camion telonati carichi di merce, verso Zameen Uud, da dove parte il treno per Ulaan Baatar. All’ingresso della stazione incontriamo il primo occidentale dopo giorni, sembra un fantasma, i capelli rossi incollati al viso, la barba lunga, ricoperto interamente di polvere e non osiamo rivolgergli la parola.
La Lonely Planet decreta che il sabato, come oggi, non c'è servizio, ma il treno c'è e abbiamo tutto il tempo per prenderlo. I vagoni sono già pronti sul binario, per la partenza alle 17.20; compriamo il biglietto e mangiamo comodamente alla mensa della stazione, polpette innaffiate da succo di pesca ghiacciato per la sete infinita che ci è venuta.
Le carrozze sono organizzate in file con due robuste brandine sovrapposte e ci sono ampie rastrelliere per i bagagli, soprattutto merce che conviene comprare in Cina: carta igienica, una collezione di unghie finte, una tenda di perline, casse di frutta come quelle che abbiamo trasportato anche noi. Degli uomini di fatica dalla forza sovraumana aiutano a stivare i pacchi più pesanti, ci vuole una buona mezz'ora per organizzarci e sistemarci tutti comodi. Alla fine fa caldissimo e sembra non ci sia niente di meglio che succhiare gelato al latte da dei piccoli sacchetti che alcuni ragazzini passano a vendere, mangiandone la metà loro stessi.
Verso sera, una delle piccole ambulanti si siede di fianco a me e pettina una bambola Barbie biondo platino, parlandole ad alta voce. Un ragazzino, con una calzetta rossa e una arancio, si dondola fra le cuccette come su un'altalena. Io mangio due uova sode che ho comprato da una venditrice anziana, come anche la donna accanto a me, che tiene sulle gambe un cartone dove entrambe buttiamo i gusci. Più volte passano dei donnoni in divisa a controllare i biglietti, mentre nel vagone si scatenano corse pazze e uomini che si arrampicano sulle rastrelliere più in alto e rimangono accucciati lì fino a che non se sono andate.
Mi è capitata la brandina in basso: Giulia si è saggiamente rifugiata al suo posto e dorme, lasciandomi di nuovo al flusso di passanti che approfittano dello spazio accanto a me. Divido il lettino con una bambina mongola, avrà otto anni, sgraziata, i capelli cortissimi con una sfumatura ramata, il viso allungato, il busto magro e due gambette storte. E porta un incredibile abitino da ballerina in tulle, un po' strappato sotto le maniche a sbuffo. All'inizio lei si stringe in un angolo come un uccellino, poi si allunga a poco a poco e finisce che dormo acciambellata malamente, con i suoi piedi in bocca. Il mattino presto si sveglia e torna dal fratello dalle gambe troppo lunghe, che non le aveva lasciato spazio, fa capolino, e continua a sorridermi. Lasciar crescere i capelli, due belle trecce, farà miracoli.
Il posto lasciato libero dalla mia ballerina viene subito occupato da un'altra bambina, questa già bellissima. Ha delle scarpette rosse con il tacco, da una parte si stanno scollando. Viaggia con il padre, che le ha ficcato in mano un sacchetto di plastica con il portafogli e poco altro. Dopo aver parlottato un po', comprano da una venditrice riso e carne: prima si serve il padre, ma non mangia molto, e poi le passa il vassoio di polistirolo. Anche lei prende pochi bocconi e rimette tutto nel sacchetto. Quando però il padre si assopisce, lei riapre il pacchetto e velocemente mangia ancora, riso che finisce dappertutto, mentre cerca di fare in fretta, tenere in equilibrio la sportina, la giacca a vento e di maneggiare le bacchette. Poi si ricompone e le resta solo la bocca impiastricciata. Per finire, accetta una caramella dalle nostre vicine che fanno colazione a base di dolcetti e cioccolatini.
Capiamo di stare arrivando quando ricominciano le manovre con i bagagli. Tutti di nuovo spingono, superano, hanno fretta di mettersi davanti alla porta per uscire per primi. Il treno ci vomita fuori in un mattino fresco di Ulaan Baatar, dopo 18 ore di speranza e sudore.
Alla nostra guesthouse, alcune stanze in appartamento dietro Peace Avenue, le porte blindate sono di fabbricazione cinese. Nei minuti che mi ci vogliono ogni volta per cercare di far girare la chiave non faccio che pensare al loro viaggio fino a qui.
Paola Causin