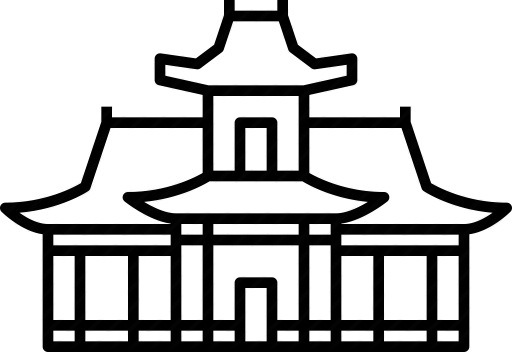Ulaan Baatar, 10 luglio 2006
Cari tutti, da mercoledì senza dormire, corsa pazza di tutti i passeggeri in partenza per UB da una parte all’altra dell’aeroporto di Mosca - perché ci avevano mandato alla porta sbagliata e l’aereo stava partendo senza di noi - un attimo per immaginare che sia stato il gatto nero del Maestro e Margherita ad architettare tutto, e poi scavalca i passeggeri del volo per Tokio, togli le scarpe, no anche la cintura, passa i controlli, raccatta le tue cose, riprendi a correre, buttati dentro l’aereo. Tutti i passeggeri sono in un lago di sudore, e da lontano noto una specie di leone marino che sembra appena uscito da una sguazzata nel mare. Ovviamente, è lui il mio vicino. Mi siedo e da lì in poi avrò l’opzione: a sinistra, la Siberia, sempre con l’alta alba gialla e viola, e le nuvole a cascata; a destra, un moscovita enorme e sudatissimo che sfodererà dalla sua comoda sacca varie bottiglie di Ballantines, scolandosele assieme a una vecchietta francese. Il russo si rivelerà essere un regista; mi mostrerà in anteprima tutti i bozzetti di scena del film epico su Gengis Kahn che sta iniziando a girare in Mongolia. Arriveremo tutti a Ub, ma il mio zaino no.
Tutto il giorno a fare carte negli uffici dell’università, e nessuno che parli inglese. Ma mi muovo leggera, tanto non ho bagaglio!
Partiamo per la montagna, e così, di colpo, dal niente, mi trovo in mezzo a tappeti di stelle alpine e gigli rossi, e comincio a conoscere un sacco di persone che si occupano o per studio o per pratica di quello per cui sono, forse, qui: lo sciamanismo. E poi scopro che Cecilia sta prendendo lezioni di mongolo da una ragazza dell’aimag di Dornod, una zona bellissima e selvaggia dove le pratiche sciamaniche sono rifiorite: e così la prossima settimana partiamo, assieme al marito e alle figlie dell’insegnante, ospiti della sua famiglia.
Oggi alle 11 c’è stata la cerimonia d’apertura del Naadam, migliaia di persone a baciare la lapide sotto la statua di un Gengis Kahn ciccione. Ma forse mi sembrava così per le poche ore di sonno: qui la partita è iniziata alle tre di notte, siamo finite a vederla in un auditorium stracolmo di bandiere e mongoli sfegatati, inneggianti a qualsiasi azione, francese, italiana, dei guardialinee.
Siamo usciti ed era l’alba, chiara chiara, strade fresche e ancora mongoli sui furgoni che gridavano.
Un abbraccio a tutti
Irene
Ulaan Baatar, 22 luglio
Cari, è sabato.
Piove, un cielo grigio fitto che sembra novembre.
Per fare un piacere a un russo che aspetta il visto per andare dalla sua ragazza a Ulan Ude, sul lago Baikal, e non ha più posto dove dormire, gli ho lasciato la sua stanza (e mia futura) ancora per un po’, e invece di spostarmi lì sono accampata da Cecilia. Lui ospita a sua volta uno/più amici, ma in qualche modo ci arrangiamo. Fuori, dal terrazzino (ma per quanto ci terrà su?) ferri arrugginiti che colano dal cemento delle case, in lontananza le colline coperte da gher e l’enorme ritratto di Gengis Kahn in bianco sul verde del monte. Da poche ore tornati dal Dornod, e non ho voglia di riadattarmi al cemento, alle macchine nere di smog, a questa pioggia.
Partiti l’altra domenica, con guidatore sbruffone, Zirma (l’insegnante di mongolo, deliziosa), suo marito e le due figlie. Due giorni dritti verso nord-est, due solchi di terra battuta e verde a perdita d’occhio, prati di gigli gialli, fiori rossi di patate, cavalli con le teste nei fiumi, cammelli con le gobbe afflosciate, lepri, marmotte, capre e mucche da scostare a suon di clacson e coppie di gru damigelle coi piccoli.
E poi aquile, quante, da non crederci.
La prima notte abbiamo piantato le tende subito dopo aver attraversato la Valle del freddo, 60 e più chilometri spalancati sul cielo dove neanche un ratto selvatico sembra volerci abitare.
Dopo un pellegrinaggio a Dadal, dove pare essere nato Gengis Kahn – posto spettacolare più che altro per le foreste di pini e betulle, e perché vedi già il confine russo, – ancora una giornata di testa fuori dal finestrino (non commento lo stato odierno dei capelli- il guidatore mi ha chiesto se normalmente li porto così…), di vento a cui lasciare andare pensieri, di odore di maggiorana dopo la pioggia.
Nella notte siamo arrivati al campo estivo dove vive la famiglia di Zirma. Prima avevamo passato quello invernale: le case per le persone sono identiche, ma non i recinti per gli animali, protetti con forti tettoie di legno intrecciato. Qui la cura per loro è infinita, anche quando vengono uccisi per essere mangiati. C’è qualcosa di molto potente in questa vita in comune - che mi aiuta anche a sentire e capire un po’ meglio, credo, i campi di forze e l’universo simbolico in cui lo sciamano agisce.
Nelle due stanze della casa, tutta di legno, la prima impressione è stata l’aria: irrespirabile quasi, completamente affumicata dai vapori dello sterco secco per scaldare l’ambiente. Poi i genitori di Zirma, sette dei suoi tredici fratelli, tanti nipotini. Poi i capretti, gli agnellini, le botti per far fermentare l’airag, ma soprattutto la vodka. La mamma di Zirma - una donna instancabile, sempre la prima a svegliarsi e l’ultima a spegnere di notte la candela del piccolo altare casalingo – ‘ste botti di vodka se le cura proprio, e a suon di bicchieri vuotati a collo, immediatamente riempiti, e subito da svuotare ancora - perché poi la signora un po’ si offendeva e un po’ci sbeffeggiava - (e noi a ringraziare di esser nate nel triveneto e di aver fatto un ottimo tirocinio alcoolico, altrimenti morivamo), siamo arrivati al sonno e al sogno, ridendo, benissimo.
Il mio compleanno considero di averlo festeggiato il giorno prima, perché quello effettivo è stato sempre in macchina, con uno splendido inframezzo in cui Zirma ha deciso di bere una birra in mio onore e non facendolo mai, si è ubriacata. Non ha smesso di ridere per un’ora.
Allora, la mattina prima, appena sveglie, abbiamo munto mucca, capra, pecora e cavalla. E poi, e poi, abbiamo preso i cavalli, i bambini sul carretto e siamo andati a raccogliere albicocche e ribes selvatici in una gola tra due colline. Al ritorno mi han lasciato andar da sola, con le due parole in mongolo per dire di fermarsi e di andare a questo meraviglioso cavallo che aveva vinto la corsa al Naadam, marrone e bianco, la criniera tagliata corta e una sella mongola assassina in legno.
Giù quasi galoppando verso una valle, ampia come un mare calmissimo verde, con una corona sottile di colline e un cielo che può ospitare insieme tutti i tipi di nuvole che uno vuole immaginarsi.
Poi al fiume, a lavarsi con i bambini che giocavano nell’acqua, e la capra uccisa con una bella martellata in testa proprio mentre tornavo alla casa. Tante ore a guardare il padre e il figlio maggiore preparare l’animale, prima disossato, poi riempito con pietre bollenti, mentre le donne pulivano le interiora. Non faceva minimamente impressione, c’era invece una cura, un ritmo nei gesti, una pazienza e una certa gioia che incantavano.
Cena: la mamma naturalmente ha riaperto le botti di vodka…
Poi la notte. Sono uscita un attimo. Cielo nero, caduto fino ai bordi della vallata, con le stelle che si erano arrischiate ad arrivare quasi fin sulla terra, e una Via Lattea che si era trasformata in un gigantesco arco teso all’infinito.
Vi abbraccio forte tutti!!
Irene Candelieri