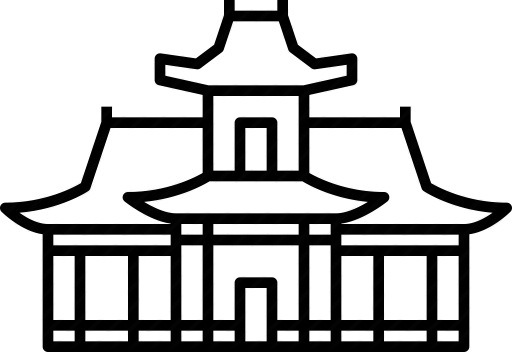Dov'è la tomba di un dio? Non è mai dove la cerchi.
Il percorso per trovarla è inclinato, insidioso, trascendente.
Zanabazar è un dio, incarnazione del Buddha, primo Bogd Gegen, il santo che risplende, maestro spirituale e politico della Mongolia dal 1638 – quando è una creatura predestinata di appena tre anni che recita a memoria i testi sacri – al 1723, avvelenato dai manciù, che temono il suo potere e la sua presunta immortalità. A quell'epoca nessuno arriva ai novant'anni, e nessuno ci arriva con quella energia.
“Lo scettro fulminante della saggezza”, significato tibetano di Zanabazar, il dio-re, discendente diretto di Gengis Khan, è inventore, matematico, poeta, scrittore, scultore – i suoi bronzi sublimi segnano l'arte di tutta l'Asia – e poi mago, architetto (a dodici anni costruisce il primo monastero, non un modellino, lo splendido Shankhiin khiid) musicista, pittore, astronomo, economista, medico, stilista, ridisegna perfino le kesa, gli abiti dei monaci copricapi compresi. Come linguista iventa l'alfabeto decorativo del Soyombo, che ancora fregia la bandiera mongola. Il biografo coevo Luvsanperenlei garantisce che Zanabazar ha poteri sovrannaturali, compie miracoli e ha il dono dell'ubiquità: come quando si trova a pregare in un tempio sperduto fra le montagne del Tibet e simultaneamente, a migliaia di chilometri di distanza, sta fondando l'accampamento mobile di Urga, destinato a diventare la nuova capitale della Mongolia, Ikh Khuree e, dal 1924, la definitiva Ulaanbaatar, l'eroe rosso. Altri testimoni giurano che, in quello stesso istante, Zanabazar stia tenendo una funzione al monastero Erdene Zuu nell'antica capitale Kharkhorin. Uno e trino.
Quel genio, quel re, quel dio, oggi riposa nell'ascetica intimità di un monastero sperduto al nord della Mongolia.
La chiamano «la tomba di Zanabazar», un edificio di legno incastrato nel complesso sacro dell'Amarbayasgalant, fra il tempio di Sakyamuni e la “gher gialla dell'ospitalità” dove campeggiano libri antichissimi, una collezione di sutra del Seicento e sculture liturgiche del maestro: al centro, a bucare un pavimento rabberciato alla meglio, il forno originale – tre lastroni incrociati di pietra grezza – utilizzato da Zanabazar per forgiarle.
Ma le sue spoglie non sono lì.
La vera tomba è la collina Baruunburen, letteralmente “l'ovest assoluto”, che sovrasta il monastero. Morfologia alla mano, quella però è già una montagna perché si parte da una base di ottocento metri di altitudine a cui bisogna aggiungerne altri duecento del rilievo.
Il nostro viaggio inclinato, insidioso, trascendente ci porta esattamente lì. Nel cuore sacro e gentile della Mongolia, fino al sepolcro del dio-re.
Il soffio celeste delle preghiere e delle opere di Zanabazar spira ovunque, negli antichi graffiti rupestri, tra le tombe unne, nelle tende bianche dei pastori, nei monasteri seminati tra l'Altai e il deserto del Gobi, nella scuola di dottrina buddhista del Chojin Lama, nella cittadella della fede di Gandan e nei musei della capitale: il più affascinante, quello di Belle Arti, in diciassette sale racchiude ventimila capolavori, e porta fieramente il suo nome.
La leggenda accartoccia la cronaca e si fonde alla fede, incondizionata. Nel 1655, al diciassettenne dio-re giunge notizia della morte del Panchen Lama, maestro del tempio tibetano di Tashi Lhunpo, fondato nel Quattrocento dal primo Dalai Lama.
Zanabazar spicca un volo di sette giorni, come un angelo-uccello, raggiunge il monastero, si accuccia sul corpo senza vita del religioso e officia un rito con il mandala, il disco sacro del buddhismo, fino a resuscitarlo. Insieme trascorrono giorni a passeggiare, pregare e chiacchierare, come due vecchi amici.
Le doti sovrannaturali del ragazzino attirano presto l'attenzione dell'imperatore cinese Kang Xi che lo convoca a corte per trasformarlo nel compagno preferito di filosofia e pellegrinaggi consentendogli di svolgere la sua attività artistica nelle condizioni migliori.
La grazia divina della sua anima viene così trasmessa alle sue sculture eterne, con quelle forme di eleganza e raffinatezza ultraterrena, a rappresentare il Buddha e gli altri abitanti del pantheon in uno stile che non ha precedenti e che non ha eredi. Tra le sue mani l'argento e il bronzo si trasformano per magia in oggetti divini, con quei volti distesi dallo sguardo infinito e benevolente, le mani sospese in gesti di eleganza taumaturgica, le pose in equilibrio dinamico e insieme definitivo.
In Mongolia lo considerano ancora oggi una combinazione miracolosa tra Michelangelo e Papa Giulio II, genio e religione alla massima potenza. Qualcuno preferisce definirlo il Leonardo da Vinci delle steppe. Il concetto è chiaro.
L'immagine è mossa.
Tutto quanto si muove dentro l'antico fuoristrada sovietico che rimbalza da ore sulle zolle della Mongolia settentrionale, non lontano dalle prime propaggini della Siberia, dentro regioni buriate dove è nato lo sciamanesimo primitivo.
Siamo partiti dalla capitale Ulaanbaatar di mattino presto e in poche ore abbiamo percorso i trecentosessanta chilometri fino a Darkhan attraverso un rettifilo d'asfalto che ha accorciato ogni distanza ma ha tolto anche ogni affascinante imprevisto. Abbandonata finalmente la millennium road si scarta tra vallate, boschi e mandrie barcollando a passo d'uomo senza un orizzonte apparente. Solo qualche gher, le bianche tende circolari, appollaiata sul percorso.
Attraversiamo piste invisibili fidandoci solo di qualche pastore – basta un cenno con il mento per indicare la direzione, lo sanno che stiamo andando lì – e dei riferimenti orografici come quel fiume improvviso, l'Orkhon, sulle cui rive, ottocento anni fa e settecento chilometri più a est, Gengis Khan generò l'impero più esteso che la storia racconti. E anche il più prezioso con quella pax mongolica che ha permesso il più importante incontro e scambio di civiltà mai (e mai più) avvenuto, tra Oriente e Occidente.
Da lassù proprio lui, il Condottiero, ci sta guardando e proteggendo, mi garantisce Baltan il driver mentre affronta un'altra palude travestita da tappeto d'erba smeraldo.
Sostiamo a un ovoo, l'altare di pietre e rami congiunzione tra l'uomo e il tengher, quel cielo talmente alto e lustro che sembra appartenere a un altro pianeta.
Svettano ovunque in Mongolia questi templi selvatici, soprattutto sulle alture, comunque dove la geomanzia dello sciamanesimo prima e del buddhismo poi, in una difficile convivenza religiosa, ha individuato l'energia mistica più potente.
Giriamo attorno all'ovoo tre volte, in senso orario, gettando la nostra brava offerta. Niente di prezioso, basta un segno. Baltan toglie dal portafoglio una banconota da cento tugrug e la getta fra le altre offerte, matite, sciarpe colorate, teschi, bottiglie e vecchie fotografie tenute ferme dalle rocce. Raccolgo un sassolino bianco e al terzo giro lo lancio agli dèi sperando apprezzino almeno il gesto.
Un'ultima sosta prima dello strappo finale.
Bat Erdene, quarantenne nomade dalla pelle coriacea e dal pastrano impolverato, ci accoglie nella sua gher offrendoci sorrisi e una ciotola di tè, una per tutti da passare, tagliato con latte di yak. Si scusa per non avere più airag, il latte di cavalla fermentato, da millenni nutrimento ufficiale della popolazione mongola. In compenso, la figlia Muren – che sbircia da un angolo dietro le sue fessure di occhi – raduna su un vassoio tocchi di formaggio sbriciolato: latte di cammella, assicura, come una garanzia di eccellenza a chilometro zero. La madre e i tre fratelli sono fuori ad accudire cavalli e capre, il patrimonio di famiglia. Nell'ultimo inverno lo zud, il fenomeno di congelamento del terreno che ghiaccia ogni possibilità di nutrimento, ha decimato gli armenti e ucciso anche due nonni di Muren.
Il sole comincia a flettere e dobbiamo ripartire sull'ideale direttrice che Bat Erdene ci ha indicato allungando il braccio dopo averci offerto un ultimo sorso di vodka mongola e una sniffata di tabacco dal palmo della mano.
Uno strappo sull'ultima collina e poi appare, improvviso, uno stupefacente miraggio.
Davanti a noi, nel verde scuro della pianura, una grande macchia rossa si compone lentamente fino ad assumere le nitide sembianze di una fortezza. Una fortezza della fede. Un monastero. Uno dei più straordinari, sofferti e misteriosi dell'intero continente.
Lo hanno chiamato Amarbayasgalant, scioglilingua generato dal nome dei due bambini, Amar (quiete) e Bayasgalant (gioia) che nella primavera del 1727 stanno giocando su questo terreno proprio mentre cominciano i lavori del tempio. Non un luogo a caso, ma un punto indicato da Zanabazar, morto da quattro anni, come centro dell'energia mistica di tutto l'universo, un poderoso shambala. Quasi come un risarcimento per l'uccisione del dio-re, è stato il nuovo imperatore dei nemici manciù, Enkh Amgalan Khan, a concedere questo prezioso dono al popolo mongolo. Il corpo imbalsamato di Zanabazar viene adagiato dentro un reliquiario incastonato di gioielli e traslato da Pechino in uno stupa d'argento massiccio edificato all'interno dell'Amarbayasgalant, l'ultima casa del Santo.
In pochi anni il monastero diventa un quartier generale della fede buddhista, nonostante l'isolamento geografico. Seimila monaci popolano la cittadella, ornandola dei tesori più preziosi, oggetti sacri, arazzi, monili, antichi libri di preghiera e centinaia di mirabili sculture realizzate da Zanabazar e dei suoi allievi.
Un luogo di pace e di gioia, come da battesimo. Almeno per due secoli. Poi l'apocalisse.
La brutalità delle purghe sovietiche, imposte da Stalin e messe in pratica dal fantoccio Choibalsan negli anni Trenta del Novecento, devasta in pochi mesi l'intero patrimonio sacro della Mongolia: templi rasi al suolo, monaci e sciamani sterminati.
I soldati dell'Armata Rossa raggiungono l'Amarbayasgalant: un cavaliere è riuscito a precedere la colonna di carri armati e ad avvisare la comunità del monastero. I monaci non si muovono, quello è il loro posto nel mondo, fino alla morte.
Non scappano al loro destino. Lasciarono anche tutti i tesori dove sono. Si preoccupano soltanto di Zanabazar: le sue spoglie non devonoo finire nelle mani sacrileghe dei Russi.
I soldati arrivano ed eseguono gli ordini, almeno quasi tutti: radunano i monaci uno vicino all'altro e li uccidono, utilizzando una pallottola per ogni due uomini, per risparmiare.
Saccheggiano i tesori preziosi, fondono sul posto il bronzo e l'argento dei templi e degli oggetti sacri poi schierano i cingolati per radere a suolo il monastero.
A questo punto Zanabazar compie il suo miracolo postumo.
Il comandante della pattuglia ordina ai suoi uomini di interrompere il bombardamento. La storia non ci rivela il motivo di quella decisione, ma ci consente di abbracciare ancora oggi la tranquilla quiete di questo luogo.
Il cielo sta già virando al viola, quando spegniamo il fuoristrada a distanza di rispetto dal monastero e montiamo la tenda in un punto qualunque di quel prato senza confine.
Baltan è distrutto dalla fatica – guidare sulle piste mongole richiede una forza mostruosa – ma ha ancora non so dove l'energia di praticarmi un massaggio, che lui definisce miracoloso ma che io trovo solo dolorosissimo, prima di vedermi addormentare come un bambino durante la ninnananna.
Il mattino dopo abbiamo un appuntamento. Anzi due. Con il maestro dei monaci e con il dio-re.
Un bambino dalla tunica rossa sporca come la faccia ci aspetta davanti al portone, di fronte ai cerchi magici impressi a calce sul terreno, una sorta di percorso per lo Tsam, arcaica danza di maschere divine e demoniache mescolate in un'orgiastica celebrazione, ripresa solo nel settembre 2002 dopo la proibizione durata sessantacinque anni.
Il ragazzino tiene in mano un grumo di ferraglia arrugginita: sono le chiavi dei templi. Chiediamo di Tulga, il monaco responsabile del monastero con il quale abbiamo appuntamento. Il bambino appoggia per terra il pesante mazzo di chiavi, si fruga nella kesa e tira fuori un vecchio cellulare. Dice due parole e poi lo ripone.
Come un maggiordomo che conduce l'ospite nel salotto buono in attesa del padrone di casa, ci spalanca la porta del sontuoso tempio principale, il Tsogchin Dugan.
La meraviglia dell'esterno, un'architettura cinese di pareti candide sormontate da tegole rosse arricchite da intarsi sacri e animali simbolici, è solo l'annuncio di quello che ci aspetta all'interno. Imponenti colonne ricoperte di khadak e thangka, le sciarpe e gli arazzi sacri che rappresentano ogni dettaglio più recondito del Buddhismo, drappi variopinti calano dal soffitto di legno, tappeti e teche di preghiera, mille statuette del Buddha e, sullo sfondo, il monumento a grandezza naturale di Rinpoche Gurdava, il santo che nel 1992 ha dato nuova luce al monastero.
In alto, in altissimo, a dominare la scena, c'è lui, Zanabazar, rappresentato su una sorta di sindone multicolore in una delle pose classiche delle sue sculture: morbidezza, serenità, eleganza, sacralità.
Un rumore improvviso ci fa sobbalzare riportandoci su questa terra. È il portone sbattuto dietro le spalle da Tulga, un uomo piccolo, viso dolce e cranio rasato. Lo collego subito all'immagine di Zanabazar, chissà forse è la sua reincarnazione. Qui tutto può essere.
Un sorriso e un inchino, nessuna parola fra di noi. Ci invita solo a seguirlo fuori.
Sul piccolo terrazzo del monastero due monaci bambini spuntano tra due cervi d'oro e soffiano dentro le conchiglie sacre, le shanka, facendole muggire con potenza. «Serve per svegliare l'ignoranza dell'anima e richiamare i fedeli alla funzione», mi sussurra Baltan come un interprete buddhista.
Entriamo nel tempio Sakyamuni. L'effetto è quello di una macchina del tempo. E dello spazio. Zanabazar deve aspettare. Prima c'è la preghiera.
I fedeli, donne, uomini, anziani e bambini, spuntano quasi per magia e si accomodano allegri e silenziosi sulle panche che formano il periplo attorno ai banchi della preghiera dove sono posizionati i monaci bambini: sembrano allievi svogliati di una scuola sopra le nuvole. Sono tutti giovanissimi, rasati, sporchi e dalle facce furbette. Ognuno tira fuori un massiccio libretto di preghiere tibetane e, al suono del gong, si comincia.
Probabilmente non sanno nemmeno che cosa stiano leggendo, sono litanie infinite e impronunciabili, mantra imparati a memoria e interrotti solo da colpi dell'antico tamburo decorato da simboli tibetani.
La cerimonia prosegue per diverse ore, ipnotica ed emozionante. Alla fine, uno dei baby monaci passa fra i fedeli distribuendo sacchetti di sopravvivenza pieni di pane dolce, yogurt secco, biscotti e resina di pino da bruciare come incenso. Prima di uscire dal tempio, i devoti lasciano una piccola offerta di denaro sotto le statuette dei Buddha.
I monaci possono finalmente tornare a essere bambini: scherzano fra di loro, rubano i dolcetti lasciati sulle panche, si spingono, tirano pugni e calci. Salta fuori una palla e comincia una partita di pallavolo fra i templi del monastero, a cui si aggiunge anche il driver massaggiatore Baltan.
Nel tempio restiamo solo noi. La profondità di campo sovrappone per un attimo il volto sullo sfondo della statua di Zanabazar con quello vivo e vicino di Tulga, che ha cominciato a sciorinare una preghiera in tibetano, solo per me.
Sa che sono lì per Zanabazar e questa è una poesia-invocazione del santo.
Cancella le tenebre dell'ignoranza,
illumina la saggezza primordiale.
Proteggici con la tua compassione
dall'oscurità della corruzione
e dai nostri peccati umani.
Smorza le fiamme della sofferenza
e alimenta le meraviglie di questa vita.
Diffondi il sole degli insegnamenti,
della pace, della felicità, della fortuna.
Liberaci da ogni arida tentazione
e rendici uomini umili e saggi.
Nel suo inglese schematico e quindi comprensibile, Tulga traduce la preghiera, mi accompagna a visitare l'intero complesso dell'Amarbayasgalant, mi offre del pane e della vodka tirata fuori da un anfratto del saio e finalmente annuncia che è arrivato il momento.
Mi porterà fino ai resti del dio-re.
Dovremo però stare in silenzio per tutto il percorso, è necessario per non disturbare l'anima di Zanabazar.
La quiete del tramonto sarà il nostro appuntamento.
Mancano ancora alcune ore, ma ci avviamo. Due piccoli uomini procedono obliqui verso la montagna che domina il monastero.
Alzo gli occhi e, alla fine di un'ascesa lunga 108 gradini – numero primario del Buddhismo – interrotta da tre piazzole con altrettante ruote della preghiera, raggiungiamo l'incombente statua del maestro Tsongkhapa, un'altra figura del Buddhismo, fiancheggiata da quella di due allievi.
Ci fermiamo sulla sommità. Ai nostri piedi il meraviglioso quadrato del monastero. Tulga però guarda altrove, verso ovest, dove il monte Baruunburen raggiunge la massima altezza.
Una preghiera sottovoce, un sorriso e si riparte.
Tagliamo in diagonale sul pendio fino a trovarci sul fianco meridionale della montagna.
Di fronte a noi un'altra salita, questa volta definitiva.
In vetta ci aspetta lo “Stupa dell'occhio”, detto Jarun Hashor, copia di quello nepalese: un periplo di ruote della preghiera – 108, non si scappa – ci accompagna mentre gli occhi del Buddha ci fissano da qualsiasi prospettiva.
Quello sguardo serve ai fedeli per spazzare via i peccati.
Ovunque campeggiano i simboli sacri del Soyombo, vergati da Zanabazar.
Il tramonto appoggia il cielo nero sul monastero della tranquilla gioia.
Il dio-re è puntuale all'appuntamento.
È sotto di noi.
È la montagna.
Javsandamba Gombodojin Eshidorj Zanabazar
nato nel 1635 a Yesönzüil (Övørkhangai, Mongolia)
morto a Pechino nel 1723
sepolto nella montagna Baruunburen, accanto al monastero di Amarbayasgalant (Selenghe, Mongolia)
Testo di Federico Pistone per il libro "Qui giace un poeta" (edizioni Jimenez, 2019)
La foto 1 è una statua di Zanabazar realizzata nel XVII secolo da uno dei suoi allievi. le altre foto sono di federico Pistone e si riferiscono al nmonastero di Amarbayasgalant